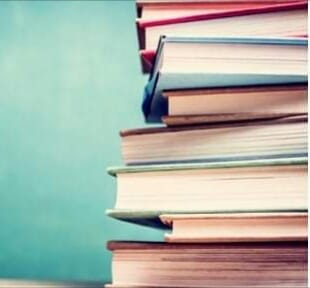Mi chiamo Ciro e dei miei sessant’anni ho poco da salvare. Nel posto dove vivo da quattro anni c’è gente che va e gente che viene. Con i nuovi arrivati costruisco un fragile castello di amicizia, che crollerà quando andranno via. Ci ricorderemo per qualche tempo, poi i nostri cuori precari continueranno a battere ognuno per conto proprio, come se non ci fossimo mai conosciuti. E pensare che trascorriamo diverse ore insieme, quelle che ogni giorno ci vengono concesse al di fuori delle nostre celle, nel cortile o nella saletta. Un paio, quattro o anche cinque, in base all’umore. Ché a volte non hai tutta questa gran voglia di parlare, di ascoltare sempre le stesse parole. Già, le parole. Alla fine le dimentichi: a forza di discutere continuamente di processi e di procedure, i vocaboli della quotidianità familiare diventano un’immagine sfocata, che si fa fatica a recuperare dal pozzo scuro dell’anima.
Ciro Meravigliao
Per i miei compagni sono Ciro Meravigliao. Una vita fa, con il pallone me la cavavo bene. Anche oggi, nel giorno in cui ci portano nel campo di gioco, faccio la differenza. In quelle due ore, con la testa voliamo altrove: corriamo come ragazzini spensierati, sbattiamo le nostre ali ferite come farfalle gaie nello spazio libero. Poi, è andata male: cioè, non lo so se è andata male o se sono stato io a farla andare male. Fatto sta che, da questi posti, entro ed esco da quando avevo quindici anni. A Napoli diciamo “magnate o’ limone” ed io ne ho mangiati tanti nella mia vita. Ormai non mi fanno più effetto. Quel sapore aspro è parte di me, smorfia nascosta di una vita consumata, come gli occhi chiari o i capelli che mi ostino a tenere lunghi, nonostante siano diventati grigi e radi.
Ho talmente tante cose da fare, che a volte il tempo non mi basta, anche se non rinuncio mai alla partita di Burraco e alla soap opera “Un posto al sole”. Sono infatti un lavorante, una figura che non ha il prestigio degli addetti alla cucina o dello spesino, ma che vale più del barbiere e del bibliotecario ed è pur sempre una spanna sopra il resto della massa indistinta. Lavo per terra, nella sezione e negli uffici; carico la lavatrice; faccio il “postino” da una cella all’altra quando ci si divide il cibo o il giornale. Insomma, mi sposto per la sezione con una certa libertà e resto fuori dalla mia cella più degli altri. Tutti mi vogliono bene e mi porgono un caffè o qualcosa da mangiare. Quando mi è possibile, ricambio con i guanti monouso che qua non si possono acquistare, anche se devo stare attento. Se vengo beccato da qualche guardia, mi tocca un rapporto disciplinare, quindici giorni di isolamento e la perdita del lavoro. Perché per loro è normale che si debba utilizzare la candeggina e lavare il cesso a mani nude. Per me, non lo è. Come tante altre cose, che accadono e sulle quali ho smesso di farmi domande dopo il consiglio di un anziano, decenni fa: «Non chiederti dov’è la logica, perché qua dentro niente ha una logica». Se ce l’ha, è sadica come le parole riportate sul quadrante dell’unico modello di orologio che ci è consentito tenere, dopo averlo acquistato dalla lista della spesa: “Libero” e “Tutto passa”.
Da pochi giorni ho come dirimpettaio di cella un ingegnere che si è subito dimostrato molto gentile. Gli ho chiesto se era disposto a darmi ripetizioni di matematica ed ha accettato ben volentieri. Quando mia figlia frequentava la scuola elementare, spesso mi chiedeva di aiutarla a fare i compiti, ma io non ne ero capace perché non sapevo fare nemmeno una “O” con il bicchiere. Ora ho una nipotina che, quando finirò di scontare la pena, andrà a scuola: ecco, non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione e credo che l’ingegnere potrà darmi una grossa mano. Imparo le tabelline e il giorno dopo le dimentico, ma lui ha molta pazienza. Ricominciamo daccapo e già riesco a svolgere benino qualche operazione, espressioni semplici. Lui stesso mi ha detto che c’è un suo amico bravo a scrivere e ne ho approfittato per prendere pure lezioni di grammatica, sintassi e ortografia. Vorrei essere in grado di mandare a mia moglie una lettera appena appena corretta, ma non so se mai ce la farò. Ho capito quando la “e” va accentata, quando mettere l’acca e quando no, però con il dettato ancora non ci siamo. I miei due professori stanno sempre insieme, nel cortile e nella saletta, dove per mezz’ora a testa si dedicano a me. Chi arriva per primo attende l’altro, come vecchi compagni di liceo naufragati e aggrappati allo stesso legno. Chissà se resteranno qua per tutto il tempo che mi sarà necessario.