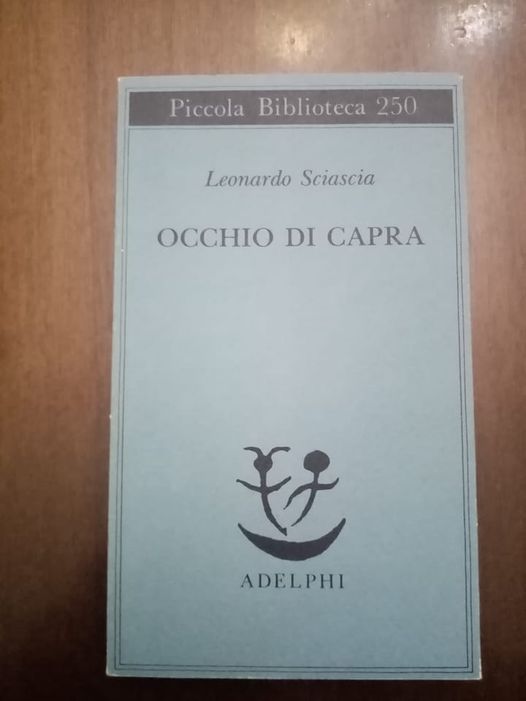
«Forse è a questa storia minima che io debbo l’attenzione che ho sempre avuto per la grande» dichiarò Leonardo Sciascia a proposito di Occhio di capra. Pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1984 e ristampato nel 1990 da Adelphi con l’aggiunta di alcune voci, il libro riprende l’almanacco di voci e modi di dire edito da Sellerio nel 1982 con il titolo Kermesse, a sua volta ispirato al dizionario di vocaboli e locuzioni dialettali che aveva impreziosito il volume fotografico I Siciliani, del grande fotografo bagherese Ferdinando Scianna (Einaudi, 1977).
Il titolo (in dialetto: “uocchiu di crapa”) fa riferimento ad una antica credenza popolare: se, al tramonto, il sole appare tagliato obliquamente da strisce di nuvole, assumendo così le sembianze della pupilla strabica delle capre, il giorno successivo pioverà: «Occhio di capra: domani piove».
Il saggio è un omaggio a Racalmuto, che Sciascia sentiva di conoscere “anche nei suoi silenzi”. Per il proprio paese natio valgono le parole dedicate da Jorge Luis Borges a Buenos Aires, messe in esergo dallo scrittore siciliano: «Ho l’impressione che la mia nascita sia alquanto posteriore alla mia residenza qui. Risiedevo già qui, e poi vi sono nato».
Per spiegare l’etimologia e il significato di termini e frasi tratti dalla tradizione orale, Sciascia fa ricorso ad aneddoti utili per preservare, oltre alla memoria delle parole, anche quella di storie minime, ma singolari e paradigmatiche di epoche e luoghi.
Tra i lemmi, uno riporta un episodio risalente al Ventennio, quando il regime fascista organizzò due plebisciti-farsa (nel 1929 e nel 1934) in luogo dell’elezione della Camera dei deputati (il Senato era di nomina regia), l’ultima tenuta nel 1924 con la famigerata legge “Acerbo”. Con i plebisciti, successivi allo scioglimento di tutti i partiti politici ad eccezione del partito nazionale fascista (1926), l’elettore aveva la possibilità di approvare o respingere il “listone” del Pnf. Facoltà che, ovviamente, era puramente teorica. Nel 1939 sarebbe caduto anche l’ultimo simulacro di democrazia, con l’istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni – composta non da membri letti, ma tali di diritto – in sostituzione della Camera dei deputati.
Il brano è il seguente:
CI SPUTASSI VOSSIA. Ci sputi lei. Espressione ormai proverbiale, per dire di un’azione che si è costretti a fare anche se teoricamente, formalmente, si ha la libertà di non farla. Fu pronunziata da un certo Salvatore Provenzano, ex guardia regia (corpo di polizia, quello delle regie guardie, istituito da Nitti e sciolto da Mussolini), davanti al seggio in cui si votava il consenso o il dissenso al regime fascista. I componenti del seggio consegnavano al votante la scheda su cui, teoricamente, il votante era libero di scrivere «sì» oppure «no»: ma di fatto le schede venivano consegnate con il «sì» già scritto, per cui al votante altro non restava che leccare la parte gommata della scheda, chiuderla e imbucarla nell’urna. Accorgendosi dunque Provenzano che già era stato scritto un «sì» dove lui aveva intenzione di scrivere un «no», si rifiutò di toccare la scheda: che la leccasse, chiudesse e imbucasse il presidente del seggio. Naturalmente, fu arrestato: ché sarebbe già stato offensivo dire al presidente di leccare la parte gommata della scheda, chiuderla e metterla nell’urna; ma dirgli «ci sputi» era dimostrazione di assoluto disprezzo per il regime fascista. (Provenzano è morto una decina d’anni addietro. Era un uomo alto, asciutto, la faccia cotta dal sole. Vestiva sempre con giacca di velluto a coste, pantaloni da cavallante, gambali di cuoio. Viveva del reddito di una sua piccola campagna. Caduto il fascismo, non rivendicò mai il merito di essere stato antifascista).