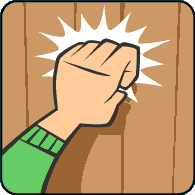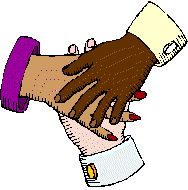Scusa
per il freddo.
C’era un muro
altissimo
tra me
e te.
Non avevo
alcun desiderio
di scavalcarlo.
Fine della corsa
Forse non siamo nella Bisanzio “insondabile” cantata da Francesco Guccini, in bilico tra il vecchio che va scomparendo e il nuovo che non si è ancora manifestato (“qualcosa sta cambiando, ma è un debole presagio che non dice come e quando”), ma di certo un ciclo storico sta volgendo mestamente al tramonto. Al di là di ciò che accadrà il 14, niente sarà più come prima. Che Berlusconi riesca a rabberciare una maggioranza o che vada sotto, difficilmente questo governo porterà a termine la legislatura. Fatte salve le prerogative del presidente della Repubblica, resta da capire se è praticabile la strada del cosiddetto governo di “responsabilità nazionale” o se la crisi ci condurrà dritti alle urne. La prima ipotesi sarebbe saggia, ma bisogna fare i conti con Lega e PDL, per nulla disposti a farsi da parte dopo avere vinto le elezioni. La seconda sarebbe logica e coerente con il funzionamento delle moderne democrazie: quando c’è una crisi di governo, la parola torna agli elettori.
Una lettura dei fatti non faziosa induce però a riflettere su di una questione affatto secondaria. È probabile che la società italiana si stia riprendendo ciò che aveva dovuto cedere con Tangentopoli. Berlusconi ha rappresentato un’anomalia per lo più subita nella patria delle fazioni, dei particolarismi, del frazionamento degli interessi. Piaccia o no, in Italia sarà sempre impossibile ridurre tutto a due partiti, a due visioni. Esistono troppe differenze. Tra nord e sud, all’interno di ogni singola regione e persino a livello provinciale. Questo Paese può stare insieme soltanto se tutte le sue componenti hanno voce.
Occorre quindi spostare indietro le lancette? L’antitesi rappresentatività/governabilità è stata risolta, nella Prima Repubblica, a vantaggio esclusivo del primo corno del dilemma. Nel Parlamento era presente “tutta” la società italiana, in virtù di un sistema proporzionale che prevedeva il recupero quasi integrale dei resti. Conseguenza immediata della frammentazione politica era però la brevità della durata dei governi, una media di circa nove mesi dal 1948 al 1992. Troppo poco per dare continuità all’azione governativa. Di fatti, un sistema talmente ingessato si reggeva soltanto per l’impossibilità dell’alternanza, sancita dalla conventio ad excludendum. Nella Seconda Repubblica è stata invece privilegiata la governabilità, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: una classe politica praticamente assediata dentro il Palazzo. La ricerca di nuovi strumenti di pressione e di rappresentanza (Forum, class action, social network), al di fuori dei circuiti politici tradizionali, è dovuta proprio allo scollamento evidente dei partiti dalla società. E il corto circuito esplode perché il sacrificio di quote di potere in nome della governabilità si rivela del tutto vano. Di fatti, a parte il Berlusconi del 2001-2006, dal 1994 ad oggi nessun presidente del Consiglio è rimasto in sella per l’intera legislatura.
La fine dell’ “era Berlusconi” porterà ad un rimescolamento profondo di idee, metodi di governo, contenitori politici, alleanze e, si spera, ad una maggiore tutela degli interessi generali rispetto a questioni più personali che politiche. Ad una classe politica che si auspica rinnovata, toccherà il compito di riuscire finalmente a conciliare le ragioni della governabilità con quelle della rappresentatività.
C’è nessuno?
Nell’opera teatrale La cantatrice calva di Eugène Ionesco, il signor Martin sostiene che, quando si va in giro, si vedono cose straordinarie. Addirittura, si può incontrare un signore che legge beatamente il giornale sul tram. Il dilemma che non gli dà pace è però complicatissimo: quando bussano alla porta, c’è qualcuno oppure no? La risposta è tutt’altro che scontata: a volte sì e a volte no.
Lo spettacolo messo in scena nel consiglio comunale di ieri è stato davvero degno del teatro dell’assurdo. Ad un mese dalle dimissioni del vicesindaco, Pippo Ascrizzi, il sindaco ha ritenuto di dare delle “comunicazioni”. Meglio tardi che mai. Un’opposizione più attenta avrebbe dovuto incalzare l’amministrazione sulla questione, magari con un manifesto pubblico che sottolineasse l’anomalia di due dimissioni consecutive, quelle dell’ex presidente del consiglio comunale, Tonino Alati, e quelle, appunto, di Ascrizzi, entrambe “per motivi personali”.
Lo intuiscono anche i sassi che i motivi sono altri. Eppure, tutto tace. Il torpore più assoluto. D’altronde, la classe politica e amministrativa è espressione della cittadinanza. La quale, tanto per usare un eufemismo, non dimostra particolare interesse per le vicende del Comune. Altrimenti, ad un consiglio comunale convocato dopo le dimissioni del vicesindaco, avrebbero dovuto assistere più cittadini rispetto ai nove – compresi i dipendenti comunali – che non hanno certo faticato per trovare le poltroncine libere.
Nello specifico, il sindaco ha dato lettura delle dimissioni di Ascrizzi, chiosandole – e qui sta la demenzialità – con l’auspicio beffardo che il suo ex vice possa continuare a dare il proprio contributo all’amministrazione comunale per la crescita del paese. Invece dell’apertura di una discussione sul punto – le frecciatine di Creazzo e Papalia non possono considerarsi tale – abbiamo appreso dal sindaco che gli è stata proposta una collaborazione dal primo cittadino di un comune con 700.000 abitanti – a conferma dell’ormai notissimo “qua c’è scienza”, pronunciato in un precedente consiglio – e che il nostro ragioniere comunale non ha eguali in tutta la Calabria. Per carità, è giusto lodare chi lavora bene; sull’auto-elogio, invece, continuiamo a pensarla come il saggio (“chi si loda s’imbroda”): è decisamente poco elegante.
Non è un po’ inconsueto che in un consiglio si parli più della bravura di un dipendente comunale che delle dimissioni del vicesindaco? Il cattivissimo commissario d’esami interpretato da Alberto Sordi nel film Totò e i re di Roma, al cospetto della deludente performance del nostro consiglio comunale, non avrebbe avuto alcuna indulgenza e avrebbe cominciato a strillare: “Senz’altro bocciato! Senz’altro bocciato!”
Resto perché…
Resto perché sono nato in Australia, a più di sedicimila chilometri di distanza dal mio paese;
Resto perché i miei genitori sono andati via e dopo dodici anni sono ritornati: il tempo di fare i lavori più disparati e tre figli;
Resto perché mio fratello Luigi è andato via e dopo dieci anni è ritornato: il tempo di fare anche lui i lavori più disparati e, fortunatamente, nessun figlio;
Resto perché mio fratello Mario è andato via dodici anni fa e non è ancora ritornato, né credo mai lo farà. Ma lui “è figlio unico”;
Resto perché quasi tutti i miei parenti sono andati via e non sono ritornati;
Resto perché non sopporto gli occhi gonfi di ogni partenza;
Resto perché subito dopo la laurea un mio amico mi disse: “fossi in te scapperei di notte da questo paese di merda”. A tredici anni di distanza, per lui non sarebbe neanche una soddisfazione.
Resto perché noi calabresi “avimu a testa dura”.
Resto perché sono stato due mesi a New York, e mi è bastato;
Resto perché penso che qualsiasi lavoro è dignitoso, anche fare il barista con laurea, dottorato di ricerca e un paio di libri scritti;
Resto perché spero che prima o poi finiranno le amanti dei professori universitari da sistemare all’Università;
Resto perché, se andiamo tutti via, a chi lo lasciamo questo paese?
Buu…oni a nulla/bis
Nella rubrica che cura su “Il Quotidiano della Calabria”, il professore Pietro De Luca, rispondendo al mio intervento su razzismo e violenza negli stadi, scrive oggi:
Non sono proprio sicuro che privatizzando oggi questo e domani quello arriveremo a inscatolare da una parte i buoni e dall’altra i cattivi. E poi, come procedere? Magari con il portafogli in mano? Il privato costa di più, il pubblico di meno. Nel privato andrebbero i migliori, gli intelligenti, i beneducati solo perché portano denaro? È sotto gli occhi di tutti che questo assunto non corrisponde al vero. Direi piuttosto che non esiste propriamente un problema degli stadi che non sia anche problema di umanità. Ultimamente un po’ scesa di livello. Se non si urla, non si aggredisce, non si inveisce contro questi e quegli, quasi non si è: di un partito, di una squadra, di un colore, di una nazione. Siamo tutti un po’ troppo su di giri. Una buona virata verso uno stile di vita più a misura d’uomo non guasterebbe. Anche negli stadi.
Non posso che condividere le considerazioni sulla società attuale. “Urlo, dunque sono”, ha ormai soppiantato la celeberrima locuzione cartesiana. È indiscutibile la violenza di certi linguaggi e atteggiamenti. Esiste una difficoltà evidente nell’accettare il punto di vista dell’altro, anche perché il tono alto delle proprie parole impedisce di ascoltare quelle pronunciate dall’interlocutore. Certo: è una questione di umanità. O di cultura, come mi ha fatto notare un mio carissimo amico. Tutto vero. Però il mio discorso era meno generico. Ci sono settori della nostra società che devono essere “pubblici”. Penso all’istruzione, alla sanità, al welfare in generale. Questi sono campi in cui l’intervento dello Stato è indispensabile per affermare i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutti i cittadini. Nel caso degli stadi, penso che c’entrino meno i diritti costituzionali e più la civiltà e la sicurezza. Non si tratta di “inscatolare da una parte i buoni e dall’altra i cattivi”. Esiste un principio, quello di “responsabilità oggettiva” delle squadre di calcio, che non potrà mai essere affermato, fino a quando la sicurezza e il mantenimento dell’ordine all’interno degli impianti sportivi non saranno di competenza delle stesse società sportive. E questo accadrà fino a quando esse non diventeranno proprietarie degli stadi. Quanto poi al discorso puramente economico, non mi risulta che i prezzi dei biglietti allo stadio siano propriamente accessibili a tutti. Oggi costa meno guardare un partita in pay-tv che allo stadio. Segno che il calcio è nel bel mezzo di una mutazione genetica che lo sta facendo diventare (ahinoi) un fenomeno sempre più televisivo.
Buu…oni a nulla
Chissà cosa penserebbero i deficienti che hanno fatto largo sfoggio di idiozia, ululando contro un ragazzo di vent’anni “colpevole” di essere un italiano di colore, dei dirigenti del Colosimi, la società di Prima categoria del cosentino che ha tesserato e trovato un lavoro e una casa all’ivoriano Coulibaly Tiemoko, giunto in Calabria al termine di un’odissea costata la vita al padre, a piedi attraverso l’Africa e su un barcone sballottato dalle acque del Mediterraneo.
Pretendere dai sedicenti “Ultras Italia” che hanno fischiato Mario Balotelli l’acume di Albert Einstein alla domanda sulla razza di appartenenza (risposta: “umana”), sarebbe davvero troppo. Per chiarire meglio il pensiero elaborato dall’unico neurone attivo, hanno pure esposto due striscioni significativi: “No alla nazionale multietnica” e “Non ci sono neri italiani”.
Alla base del pregiudizio che alimenta le pulsioni più recondite e abiette dell’animo nei confronti del “diverso” (sia esso nero, omosessuale, ebreo, zingaro e così via), vi è spesso non la mera malvagità, quanto quella che Hannah Arendt ha definito la “banalità del male”, l’inconsapevolezza cioè del valore etico dei comportamenti individuali. Questa considerazione non deve però affatto spingere all’indulgenza. Così come non deve costituire un alibi per attenuare le responsabilità.
Il problema, gira e rigira, è sempre lo stesso: lo stadio è una terra di nessuno dove, nonostante gli innegabili progressi compiuti negli ultimi anni, si può violare la legge con buone probabilità di farla franca. Molte curve sono ormai diventate un covo di beceri che pretendono “onore” e “rispetto”, invece del disprezzo che a ragione va riservato a chi espone striscioni con svastiche e simboli runici, fischia i giocatori di colore, esprime solidarietà per dei delinquenti ai quali è stato giustamente proibito di andare allo stadio.
Da più parti si inneggia al “modello inglese”. D’accordissimo. Ma la repressione, da sola, non può funzionare in un Paese che fa della certezza della pena un optional. Ci vogliono stadi nuovi e privatizzati, con tutti i posti numerati e controllabili con facilità. Solo in questo modo le società sportive diventeranno realmente responsabili della propria tifoseria e gli stessi gruppi ultras sarebbero costretti ad una maggiore attenzione nell’accettare le adesioni, come accade in tutte le associazioni. È per l’insieme di questi motivi che, in Inghilterra, tutti si sentono responsabili di ciò che accade all’interno di uno stadio e se un tifoso urla un insulto, lancia un oggetto, o soltanto si alza dal proprio seggiolino, viene immediatamente bloccato dai suoi stessi vicini.
Fare fronte
Hanno ragione d’essere, oggi, le categorie destra e sinistra? Morte e sepolte le ideologie del ventesimo secolo, possiamo ancora accapigliarci su cosa sia di destra e cosa di sinistra, come faceva Giorgio Gaber, prendendo in giro un po’ tutti?
Il Paese è prostrato da una crisi economica che dura da anni e della quale non si intravede la fine. Osservando i comportamenti di personaggi assurti a modelli di vita – è sufficiente un quarto d’ora davanti ad una telecamera per diventare un ascoltato ed influente maître à penser – è possibile rilevare quotidianamente un angosciante declino etico della società. Il messaggio, semplice e agghiacciante, è che con i soldi si può comprare tutto; con i compromessi nessun traguardo è irraggiungibile; l’intelligenza e il merito sono meno utili di uno stacco di coscia vertiginoso o di un passaggio dalla villa del Lele Mora di turno. Il sistema politico italiano e, prima ancora, la società civile stanno andando a rotoli e ancora – come se le lancette fossero pietrificate al 1994 – il dibattito si avvita sull’antitesi tra berlusconismo e antiberlusconismo. Una coazione a ripetere che, di fatto, è stata funzionale al perpetuarsi del potere di una classe politica inadeguata. Dove sarebbero ora i più fedeli lacchè di Berlusconi o, sull’altra sponda, i suoi più tenaci oppositori senza questo scenario di perenne lotta del bene contro il male? Personaggi che alimentano il culto della personalità del capo o la demonizzazione di colui che è considerato l’unico vero responsabile di tutti i mali della società italiana e non, piuttosto, il suo prodotto.
Soprattutto, ha senso una contrapposizione del genere nel Mezzogiorno, visto che non fa altro che andare a vantaggio del governo centrale e degli interessi del Nord del Paese, quelli che storicamente hanno avuto la prevalenza su ogni ipotesi di perequazione sociale, politica ed economica dell’Italia? Il fiorire di esperimenti politici a forte connotazione localistica sembra rappresentare una novità significativa. È la reazione di coloro che sono stanchi di essere considerati soltanto un voto affidato a classi politiche distanti, distratte e disinteressate. Qualcuno dovrebbe infatti spiegarci per quale motivo da giorni i mass media parlano esclusivamente dell’alluvione nel Veneto e ignorano (o quasi) la Campania e, soprattutto, la Calabria. Per quale motivo nessuno – come invece hanno fatto Corriere della Sera e La7 per il Veneto – si è fatto promotore di una sottoscrizione per raccogliere fondi per le regioni meridionali alluvionate?
Ecco perché occorre “fare fronte”, al di là di ogni appartenenza politica. Non per elemosinare qualcosa, quanto per avere riconosciuta pari dignità.
Quando la coppia scoppia
La metafora del cerino aiuta a capire, ma per rendere meglio l’idea occorre rifarsi a quelle scene in cui Bud Spencer, al termine di un lungo scambio di colpi dati e ricevuti, scaraventa a terra il malcapitato di turno. Bisogna capire chi, tra Berlusconi e Fini, alla fine soccomberà.
Il dato certo è che così non si può più andare avanti. Su questo concordano tutti. Il logoramento di Berlusconi e del governo dura ormai da un anno e mezzo, dalla lettera nella quale Veronica Lario contesta i metodi di selezione delle candidature pidielline e scoperchia il pentolone delle discutibili abitudini e frequentazioni del premier. L’effetto domino è devastante. Nel gorgo finisce tutto, matrimonio e alleanze politiche. Il metodo Boffo diventa l’arma con cui i giornali vicini al premier tentano di mettere la museruola a Fini (con il crescendo rossiniano che conduce alla vicenda della casa di Montecarlo), ma il “controcanto” del presidente della Camera diventa quotidiano, sino all’espulsione decretata dal collegio politico del PDL il 29 luglio scorso e alla nascita di Futuro e Libertà, con il discorso di Mirabello che il 5 settembre ratifica la scomparsa del partito del predellino.
Berlusconi difficilmente si dimetterà, mentre il ritiro della delegazione governativa finiana porterebbe, di fatto, ad un governo di minoranza costantemente esposto al fuoco amico dell’Aula. Dopo la convention di Bastia Umbra, il percorso sembra tuttavia tracciato. Questione di tempo. Preso atto della fine di un ciclo storico e politico, Futuro e Libertà dichiara di volere andare “oltre” Berlusconi e il berlusconismo, pur restando nell’alveo del centrodestra, ma rimettendo al centro del dibattito questioni politiche, non le vicende personali del capo del governo. La mission apertamente enunciata è il riequilibrio “territoriale” per rintuzzare le spinte nordiste dell’Esecutivo. Da qui l’affondo di Fini sull’utilizzo dei fondi FAS come un bancomat in mano a Tremonti per i più disparati bisogni della Lega. Va interpretata in questo senso anche la richiesta di un rimpasto governativo che apra all’UDC. Nonostante il ricordo poco confortante dei governi Berlusconi II e III, con le ricorrenti tensioni tra Fini e Casini, in gran parte dovute alla rivalità su chi debba raccogliere l’eredità politica del presidente del Consiglio.
Come andrà a finire? La caduta del governo in questo momento rappresenterebbe un imprudente salto nel buio. Un’eventualità da scongiurare anche nel caso in cui i finiani, secondo quanto hanno minacciato di fare, dovessero dimettersi dal governo. Per senso di responsabilità si dovrebbe procedere all’approvazione della Legge di Stabilità (l’ex Finanziaria), dopodiché, a dicembre (quando – non va dimenticato – la Consulta si pronuncerà sul legittimo impedimento), si dovrebbe aprire ufficialmente la crisi che porterebbe alle elezioni nella prossima primavera. A meno che non si dovessero trovare i soldi per realizzare il federalismo fiscale tanto caro alla Lega. In quel caso andrebbe tutto a carte quarantotto e gli scenari al momento più inverosimili potrebbero diventare possibili: congiure di palazzo, alleanze trasversali e ribaltoni, per completare la legislatura e portare a compimento qualcuna delle riforme al momento esistenti solo sulla carta.
Motivi personali
È l’espressione più in voga, una specie di mantra da ripetere per convincere e convincersi che tutto va bene, la pillola da assumere al bisogno, quando la temperatura sale un po’ troppo. Serve per nascondere la polvere sotto il tappeto, soltanto che il tappeto ora sta toccando il soffitto.
Si avverte qualche scricchiolio inquietante all’interno della maggioranza che amministra il nostro paese. Un paio di mesi fa, le dimissioni da presidente del consiglio comunale sventolate da Tonino Alati, alle spalle un corposo curriculum amministrativo sempre al fianco del sindaco, Enzo Saccà. “Motivi personali”, la versione ufficiale impressa in calce alla lettera di congedo protocollata al comune. Alzi la mano chi se l’è bevuta.
Qualche giorno fa, il passo indietro di Pippo Ascrizzi, il vicesindaco annunciato già nel corso della passata campagna elettorale, la cui nomina era stata presentata come architrave di un’operazione politica complessa e per certi versi ardita, quindi pesante quanto un carico da undici. Per due motivi: perché ha fatto sedere allo stesso tavolo e mettere d’accordo senza che nessuno si graffiasse due avversari fino ad allora irriducibili, con alle spalle quasi trent’anni di accesa conflittualità; perché si trattava di una nomina esterna, in quanto tale ancor più significativa. Anche in questo caso, “motivi personali”.
Per carità, potrebbe anche essere. Nel senso che nel nostro paese non si fa vera politica dagli anni Novanta, per cui tutto si riduce a rapporti personali. La contrapposizione Fedele/Saccà ha praticamente fatto terra bruciata, impedendo non solo la formazione di un’alternativa, ma anche lo sviluppo di un dibattito minimo, una presa di posizione politica qualsiasi, al di là della semplificazione – a volte un alibi per lasciare le cose come stanno – rappresentata dall’antitesi tra i due uomini forti della politica eufemiese. In questo senso, si potrebbe parlare di “motivi personali” perché non esistono più questioni politiche, ma questioni esclusivamente personali.
Se il cigolio proveniente da piazza della Libertà dovesse aumentare d’intensità, potrebbe sorgere qualche problema. Ma forse si temporeggerà un po’: azzardiamo fino alle provinciali della prossima primavera. Certo, se un manipolo di uomini di buona volontà si risolvesse a staccare la spina, chiudendo anticipatamente questa esperienza amministrativa, a occhio e croce non dovrebbero essere in tanti a strapparsi i capelli.
Il regionalismo centrifugo
Quarant’anni di regionalismo hanno minato la tenuta dello Stato? Non c’è dubbio che i partiti nazionali siano in affanno. A parte il caso della Lega Nord, non si può non rilevare che la connotazione regionale di molte leadership offusca la dimensione nazionale dei partiti. Basti vedere quello che sta succedendo in Sicilia, con Lombardo e l’MPA capaci di mettere all’angolo il PDL, con Micciché e la sua Forza del Sud in fuga dal partito del premier, così come la pattuglia sempre più numerosa di Futuro e Libertà. Io Sud di Adriana Poli Bortone in Puglia, il gruppo di Beppe Pisanu in Sardegna, la situazione campana che ha registrato lo scontro all’ultimo sangue tra Cosentino e Caldoro e tutte le altre controverse realtà regionali sono l’esempio palmare di come anche una leadership fortissima come quella di Berlusconi arranchi quando gli interessi territoriali riescono a coalizzarsi attorno ad una proposta unitaria, ancor più se essa riesce a superare la tradizionale contrapposizione destra/sinistra. Analoghe considerazioni valgono per la sinistra: Chiamparino in Piemonte e Cacciari in Veneto sono gli esempi più scontati, tanto per restare dentro il PD. Se poi si mette un piede fuori, balza agli occhi il caso Vendola, ostacolato dalla nomenclatura di sinistra ma capace di battere l’apparato del partito sceso da Roma per appoggiare il suo rivale nelle primarie per l’elezione a governatore. O Loiero, che non si sa se è dentro o fuori, ma che è in grado di controllare ben due gruppi regionali, quello del PD e quello della sua lista personale (Autonomia e diritti), con nascosta nella manica la carta da giocare come extrema ratio, il Partito democratico meridionale.
Di fronte ad una situazione talmente parcellizzata, sarebbe forse il caso di riconsiderare i motivi per cui 150 anni fa si scartò l’ipotesi regionale. In un’ottica però moderna, che attui in pieno il principio di sussidiarietà, affidando alle province pieni poteri e autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria. Solo così si potrebbe togliere un alibi a coloro che minacciano la secessione, si risparmierebbe un bel po’ di denaro pubblico – dimostrando finalmente di fare sul serio rispetto alle strumentali campagne per l’abolizione delle province, puntualmente finite su un binario morto – e lo stesso Stato, alleggerito di tante funzioni, potrebbe addirittura rafforzare il proprio carattere unitario.