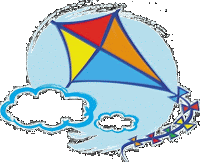Il dato più significativo delle elezioni comunali a Sant’Eufemia è la sconfitta di una prassi politica che con la politica, a dire il vero, ha poco da spartire. Colpa della scomparsa di quei partiti che facevano formazione dentro le sezioni, certo, ma è storia risaputa da quasi due decenni e vale per tutta la Penisola. Si è ritornati ai comitati elettorali ottocenteschi, con i “grandi elettori” di questo o quel candidato che si ritrovano alla vigilia della convocazione dei comizi per la pianificazione della campagna elettorale. Spinti da motivazioni più o meno nobili, sostenitori e componenti di una lista hanno discrete probabilità di proseguire nella collaborazione in caso di affermazione, mentre la sconfitta, solitamente, determina un rompete le righe generale. Esito prevedibile quando l’unico collante di aggregazioni estemporanee è la possibilità di una vittoria che determinerà la gestione di un minimo di potere o il saldo di qualche cambiale sottoscritta prima del voto.
L’assenza di politica è il primo male della politica. Detta così, è un’affermazione che sta tra Lapalisse e Catalano, ma tant’è. Non è nostalgia per le Frattocchie o per le palestre politiche dei partiti della Prima Repubblica, ma la disaffezione crescente ha una ragione non irrilevante proprio nella strumentalità dell’approccio elettorale. Se il solco tra politica e società civile si accentua progressivamente, è logico e per nulla sorprendente il rigetto nei confronti del politico di professione e di coloro che si presentano come alieni ad un elettorato già di suo irritato. Il retro della medaglia raffigura invece una politica ridotta a favore, clientela, capacità di aggregare nuclei familiari dall’ampio serbatoio elettorale indipendentemente dal merito della proposta programmatica. È questo il circolo vizioso che andrebbe spezzato. Impresa più che ardua, in realtà caratterizzate da un drammatico bisogno di occupazione, che può su ogni altro tipo di considerazione, anche sull’umiliazione subita da chi non ha altra possibilità della speranza che, “chissà, magari stavolta manterrà”.
Le elezioni amministrative eufemiesi forniscono un ulteriore elemento di analisi sul quale, chiunque si occupi di politica, dovrebbe seriamente riflettere. È stata la reazione nei confronti di un modus operandi indisponente. L’atteggiamento di chi si considera il padrone assoluto della volontà popolare e non il curatore di un bene che va gestito con umiltà e restituito al legittimo proprietario. Le votazioni danno e tolgono. L’esercizio del diritto di voto è l’espressione più alta della democrazia, non una stanca liturgia: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, recita non a caso il primo articolo della nostra Costituzione.
Ha vinto Mimmo Creazzo, ma i due grandi sconfitti sono i protagonisti dell’ultimo ventennio politico cittadino, l’assessore regionale pidiellino Luigi Fedele e il sindaco uscente Enzo Saccà. Il primo sconfitto nelle urne, dopo avere riproposto la candidatura a sindaco del fratello Giovanni, già battuto una prima volta nel 2007 proprio da Saccà. Il secondo addirittura incapace di mettere insieme una propria lista, nonostante un flebile tentativo sfumato nel giro di due settimane. Vicende simili, sottostanti entrambe all’idea presuntuosa del “dopo di me il diluvio”. È invece evidente che non esiste uno “scettro” (abbiamo dovuto ascoltare anche questo, rabbrividendo) da tramandare a mo’ di stecca militare. Né è possibile calpestare i principi elementari del confronto democratico e della dialettica politica, nell’antistorico tentativo di riproporre inaccettabili logiche da investitura medievale. Una lezione sulla quale tutti dovrebbero meditare.