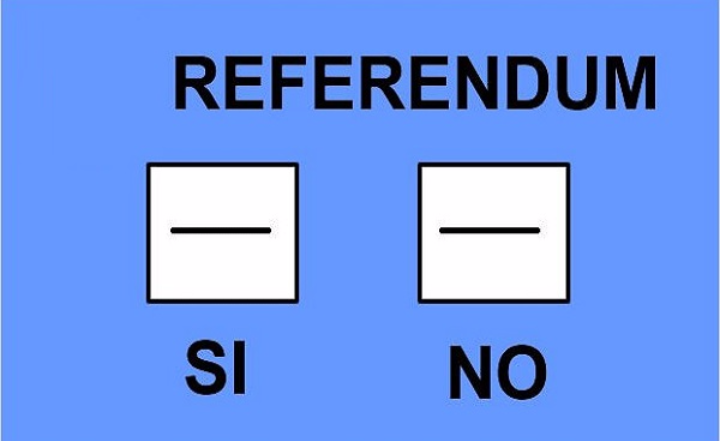L’11 settembre mi sorprese all’Archivio di Stato di Catanzaro, alle prese con le ricerche per la tesi del dottorato. Mi fu annunciato per telefono da mio fratello Mario, allora in Australia: un intreccio di fusi orario vertiginoso. Per radio, mentre rientravo a Sant’Eufemia, appresi i dettagli di ciò che era accaduto. Provai soprattutto incredulità: sul suolo americano una cosa del genere era impensabile.
Nel gennaio successivo fui a New York, per una ricerca sull’identità italo-americana insieme ad altri colleghi, che ci tenne là per due mesi. Un po’ ci sentivamo tutti americani, sulla scia del monito di Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, che parafrasava il vecchio discorso di John Kennedy a Berlino. Per cui non obiettammo nulla alla padrona di casa che ci raccomandò di non togliere le due bandiere a stelle e strisce poste ai lati dell’ingresso. D’altronde eravamo ospiti di un paese straniero.
Non c’era paura in giro, questo mi colpì immediatamente: soltanto commozione e un aumentato sentimento della nazione tra gli statunitensi, qualcosa a dire il vero distante dalle mie corde, che però aveva una sua giustificazione. Ricordo in particolare una processione sulla 5th Avenue con un corteo interminabile per una commemorazione di vittime irlandesi. E poi l’odore aspro, che feriva le narici, del World Trade Center, ben 5 mesi dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Ma anche la faccia allegra della guardia giurata che all’Empire State Building prese in consegna la scorta di bottiglie di vino, di birra e di gin che avevamo acquistato poco prima: «Ragazzi, che problema avete?!».
Ci siamo sentiti tutti americani, anche se per poco tempo. Già l’attacco all’Iraq, sulla base di un casus belli totalmente confezionato in laboratorio, ci avrebbe fatto ricredere. Così come tutta la politica statunitense in Medio Oriente, dove l’instabilità regna sovrana e il sogno della democrazia, che napoleonicamente si credeva possibile esportare sulla punta delle baionette, segna decisamente il passo.
Archivio storico comunale, siamo sempre all’anno zero
“Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”: il buon vecchio Trilussa aveva le idee abbastanza chiare. Vale quindi la pena insistere, anche si rischia la figura del disco rotto. Insisto. Se non altro servirà a tenere i riflettori accesi su una questione che mi sta particolarmente a cuore e che più volte ho sollevato in convegni, presentazioni di libri, incontri con gli amministratori del comune: l’istituzione dell’Archivio storico comunale a Sant’Eufemia.
Parole al vento. Parole, che (a parole) tutti condividono, sulla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese e sull’importanza del recupero della memoria storica locale, che però restano tali quando poi c’è da passare ai fatti. Ciò accade perché si investe poco sulla cultura, a tutti i livelli, non solo a quello comunale, ma anche perché manca una visione progettuale e ci si adagia su operazioni di corto respiro, che danno una visibilità immediata (e che costano anche poco, questo va detto). Da qui un rosario di iniziative, alcune dal valore discutibile, messe in campo soltanto per poterci attaccare sopra il bollino “cultura”, che tuttavia non offrono alcun contributo alla crescita culturale del paese.
L’istituzione dell’Archivio storico comunale consentirebbe invece di realizzare un bel salto di qualità. Chi ama la storia e ha familiarità con gli archivi, sa che essi costituiscono una fonte di primaria importanza per la storia di un territorio e per la ricostruzione dei processi sociali, storici e istituzionali di un comune. Un patrimonio di documenti, pergamene, carte e volumi fondamentali per riscoprire le proprie radici e comprendere le ragioni dello stare insieme, l’identità di un popolo; individuare il filo rosso che lega il presente di una comunità al proprio passato e lo proietta nel futuro.
Accanto al motivo ideale c’è poi anche la necessità di salvare dal progressivo e ineluttabile deterioramento un patrimonio che, nel caso di Sant’Eufemia, giace negli scantinati del palazzo municipale in registri e documenti privi di catalogazione, non consultabili, esposti all’umidità e alla polvere. Sul piano pratico, si tratta di riordinare, catalogare e inventariare il patrimonio documentario del comune: registri dell’anagrafe; verbali dei consigli comunali e delle giunte municipali; documenti ufficiali e corrispondenza con enti politici, uffici burocratici, personalità politiche di rilievo. Operazione che, evidentemente, potrebbe avere anche una non trascurabile ricaduta in termini occupazionali.
Sul finire del 2013, il settore cultura della Consulta cittadina aveva avanzato all’amministrazione comunale una proposta per l’istituzione dell’Archivio, che tra l’altro riprendeva uno dei punti del programma della lista vincitrice delle elezioni. Proposta purtroppo rimasta lettera morta, nonostante le iniziali buone intenzioni. Di nuovo parole al vento, impresse su carta e protocollate, dimenticate in qualche cassetto.
Tra i vivi che dormono
Vorresti una risposta. Lo so che davvero ti interessa sapere come sia potuto accadere. Com’è stato che un giorno ho calato i paraorecchie del cappello, allacciato i bottoni del cappotto, ridotto la mia vita a questo eterno andirivieni sul marciapiedi fuori di quella porta scassata, con i vetri opachi a proteggere la penombra di un paio di sedie e poco altro. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Nella testa una babele di parole che soffio leggere, per farmi compagnia: in tedesco, francese, inglese.
Un tipo strano, taciturno, solitario. Saluto tutti, perché tutti mi conoscono. Ma giusto qualche frase, un filo sillabato che annodo a un passato lontano, non più mio. Anche quando ti chiedo di tuo padre, di tua madre, dei tuoi fratelli. Faccio così con chi si ferma e non tira dritto senza neanche guardarmi, quasi fossi un fantasma. Poi torno al silenzio di questo basso, ai suoi colori spenti, vecchi. Vecchi come me, ormai.
Non è rimasto granché del bambino paffutello in sandali, riga di lato e camicia di flanella a quadri con le maniche arrotolate al gomito. Soltanto uno scatto, un attimo fermato per sempre da chissà chi, un tempo infinito seduto sul gradino del mastro calzolaio con tutta la squadra di apprendisti. Le gare a chi con la calamita raccoglieva più chiodini per terra, la sera prima di chiudere. Gli scherzi e le barzellette, mentre Mister Volare e il Reuccio si contendevano il cuore innamorato dei garzoni più grandi dall’altoparlante di una radio a valvole. Gli scapaccioni per un pezzo di cuoio tagliato male.
Come tanti cercai la mia stella lontano da qui. Hai presente i Maggiolini? Ancora vanno di moda, tanto che la Volkswagen continua a produrne di nuovi. Ecco, da un posto dimenticato da Dio ero andato a finire a Wolfsburg. Un tutt’uno con la fresa e con il tornio che facevo suonare come fossero un pianoforte.
Non mi chiedere cosa, a un certo punto, è successo. Sì, la conosco la storiella che ripetete e che vi raccontate per provare a spiegare il mio silenzio, la mia clausura. Per dare un senso logico a ciò che invece ne ha uno chiarissimo. «È stato drogato a forza, la droga gli ha bruciato il cervello e l’ha fatto diventare pazzo». Altri no, per loro c’entra il lavoro: «Ha avuto un infortunio in fabbrica. Ha battuto con la testa e da allora non è più stato lo stesso». O magari una donna, certo: come avete fatto a non pensarci prima? Dietro ad ogni cervello folle finito sulla Luna c’è un’Angelica scappata con qualcuno: cherchez la femme.
E invece no. Non è andata così. Semplicemente, è stato che a un certo punto ho detto “basta”. Non mi andava più di marciare alla conquista della felicità ripetendo in fabbrica, ogni santo giorno, gli stessi movimenti. Meccanicamente. Senza mai scambiare una parola con l’operaio accanto, uno sconosciuto con cui dividevo la mia solitudine. Senza mai pensare a niente, una dimensione fatta di sudore e gesti automatici. Sperando soltanto che un moscone non cercasse di infilarsi nel naso, distogliendomi dal mio lavoro.
Non avevo molto da perdere, tornai alle quattro mura scalcinate della mia infanzia. La compagnia dei corsi di lingua per corrispondenza, la radio unica finestra sul mondo. Passo le mie giornate così, tra i vivi che dormono. Altri daranno un significato ai propri tentativi, se la caveranno, sorrideranno.
Alluvioni, ieri e oggi
Storia vecchia quella delle alluvioni disastrose. Pensavo a questo mentre sui social si rincorrevano immagini, video e aggiornamenti del terrificante acquazzone (“bomba d’acqua”, secondo i giornalisti à la page) che ha interessato anche il nostro paese. Storie di danni e di frane, di acqua che porta via tutto: “nera che porta via, che porta via la via”, anche se non ci troviamo nella Genova di Fabrizio De Andrè, ma in questa terra violentata dagli uomini e punita dalla furia degli elementi. Storie vecchie che conosciamo bene, anche a Sant’Eufemia, ma che poco sembrano insegnare.
Correva l’anno 1878 (10 ottobre) quando un violentissimo temporale, tra le tre e le cinque di notte, causò due vittime, la rovina di diverse abitazioni e il crollo dei ponti Portella e Annunziata. Un disastro che si ripeté il 30 dicembre dello stesso anno, danneggiando le case costruite nelle adiacenze del fiume e, addirittura, facendo temere il cedimento di un angolo della chiesa (che venne chiusa al pubblico) e del resto della piazza attraversata dalla strada provinciale, nel tratto sopra la volta del torrente Nucarabella, dopo che la violenza dell’acqua aveva sfasciato le briglie.
Sant’Eufemia non fa eccezione e al suo territorio è possibile applicare la metafora dello “sfasciume pendulo sul mare” utilizzata da Giustino Fortunato agli inizi del Novecento per definire l’assetto idrogeologico della Calabria. Anche noi abbiamo “torbidi torrenti” che corrono verso il mare e, come in Gente in Aspromonte, quando Giove Pluvio si mette d’impegno, anche da noi “la terra sembra navigare sulle acque”.

Sono diversi i casi di dissesto idrogeologici segnalati negli anni dalle varie amministrazioni comunali. Con scarsi risultati perché gli interventi di messa in sicurezza, in una situazione così degenerata, hanno costi molto elevati. Basti pensare all’area circostante il ponte della ferrovia, quella probabilmente di maggiore pericolo, per la quale è mancata nel tempo una cura puntuale, tempestiva, ordinaria. Risultato? Ogni anno che passa l’erosione aumenta, i pilastri appaiono sempre più scalzati, le briglie rotte ormai inghiottite dall’alveo del fiume. E più o meno così vanno le cose nelle altre aree a rischio, ad esempio nella zona dell’Annunziata, dove è avvenuta la frana alla quale si riferiscono le fotografie. Ma altre frane e smottamenti si sono verificati un po’ ovunque, nelle frazioni e lungo le vie di comunicazione, con disagi più o meno consistenti e una brutta disavventura conclusasi con qualche danno e molto spavento.
Uno stato di cose per il quale ci sono anche responsabilità umane, certo. Cementificazione selvaggia, disboscamenti scriteriati, letti dei torrenti diventati discariche che nessuno più pulisce, così come le cunette perennemente intasate che trasformano le strade in piscine. Ce ne ricordiamo ogni volta che la paura ci fa capire quanto siamo piccoli di fronte alla potenza distruttrice della natura, mentre tiriamo un sospiro di sollievo perché tragedia non c’è stata. Perché il destino, stavolta, ha voluto essere benevolo.

*Fotografie di Sara Bonfiglio
Il principe dell’estate
«U professuri Garzu calau?». Per i chjazzoti (habitués di piazza Matteotti, rione Pezzagrande), da oltre quarant’anni l’inizio dell’estate coincide con l’arrivo in paese di Saverio Garzo; la fine, con la sua ripartenza per Asso (Como), dove risulta domiciliato. La residenza no, quella l’ha sempre mantenuta a Sant’Eufemia: un modo per rimanere attaccato alle proprie radici, credo. Ai valori di quella civiltà contadina cui spesso fa riferimento, con rimpianto, quando la conversazione cade sulla crisi della società attuale.
Non esiste un albo di tutti quelli che siamo scesi al mare, a Scilla, con Saverio. Rigorosamente Scilla, dove con la sua piccola dama ci attendeva Rocco, che poi Saverio avrebbe fatto venire a Sant’Eufemia per sottoporlo, sotto la pergola del bar Mario, alla prova del fuoco contro il fuoriclasse eufemiese Ceo “Galera”.
Siamo scesi, sì: io tra questi, insieme ai miei due fratelli, nella seconda metà degli anni Ottanta. Arrivavamo con i nostri teli da mare (la mia riproduceva una formazione dell’Inter sfigatissima di quel periodo) a casa dei suoi genitori e della sorella Marina, che subito autorizzava Mario – il più piccolo – a salire al piano di sopra: «Va’ rrussigghialu, c’ancora dormi!». E poi via, a bordo della BMW 316, come sottofondo ottima musica: su tutte, le musicassette di un De Andrè forse non proprio estivo (indimenticabile l’incipit della canzone Il testamento: “Quando la morte ti chiamerà”), ma foriero di suggestioni che la maturità avrebbe consentito di cogliere nella loro grandezza.
Asciutto, ossuto, con quei baffoni e il cespuglio di capelli neri (poi brizzolati, oggi bianchi), Saverio è un incrocio tra Carlos Santana e un asceta indiano, tra il bomber brasiliano Antonio Careca e un contadino precolombiano.
Autore di burle atroci e pesantissime, ormai entrate nell’immaginario collettivo: dalla simulazione dell’incidente stradale con i morti sul ciglio della strada, che gli è valso un litigio durato decenni, alla sparatoria con tanto di sangue sul petto della vittima; al travestimento da donna di facili costumi per adescare la vittima di turno, con il favore del buio del luogo scelto per la messinscena, che per poco non provocò un esito “tragico” e grottesco.
Ma anche capace di ricorrere al gioco per celare una profonda umanità, come quella volta che si “sostituì” all’amico vu’ cumprà e, dopo avere percorso la spiaggia di Scilla in tutta la sua lunghezza, riuscì a vendere gran parte della mercanzia.
Per molti anni Saverio è stato il principe dell’estate eufemiese. Non che ora non dia il suo contributo, ogni volta che qualcuno lo contatti per presentare una serata o lo coinvolga nell’organizzazione di un evento popolare. Tuttavia, il suo nome è legato indissolubilmente alle manifestazioni allestite dall’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, una stagione d’oro che l’ha visto protagonista come volto “ufficiale”. Una sorta di Mago Zurlì, amatissimo dai bambini che si esibivano nelle serate del “Mini Festival” e dai ragazzini impegnati nelle prove simpaticissime dei “Giochi senza Frontiere”.
Serate che hanno fatto la storia (piccola, ma pur sempre storia) del nostro paese, alle quali chi c’era guarda con un pizzico di nostalgia. In questo ideale album dei ricordi, in questo malinconico “com’eravamo” c’è Saverio con la sua allegria, nel cuore il desiderio semplice di divertirsi e di divertire, di strappare un sorriso, di regalare alla comunità un paio d’ore di serenità.
*Nella foto, tratta dal profilo Facebook di Francesca Tripodi, Saverio Garzo mentre presenta una serata del Gruppo Folcloristico. Alla sua destra, Mimma Cutrì.
A botta i diciannovi
Càpita, ogni tanto, di fare un appello mentale e di accorgersi di troppe assenze. Ho sempre detto che devo molto al bar di mio padre, perché ci sono cresciuto e ho avuto, da piccolo, il privilegio dell’affetto di chi lo frequentava. Stare dietro al bancone, per me e per i miei fratelli, non era soltanto il gioco di tre bambini che salivano sulla cassa della Peroni per fare il caffè.
Il rapporto con persone della più svariata estrazione sociale e culturale arricchisce sempre. Ho perciò pensato a una sorta di omaggio per alcuni protagonisti di questa lunga storia, pescandoli dalla mia memoria tra quelli che, a parte il personaggio che mi accompagna all’inizio, purtroppo non sono più tra di noi. Ho voluto ricordarli con il sorriso sulle labbra, recuperando aneddoti accaduti in un arco temporale di oltre trent’anni, che ho cercato di tenere legati condensandoli in un unico racconto. Ho anche pensato che la lingua più appropriata per parlare del bar Mario sia il dialetto, la lingua ufficiale – credo – di tutti i bar del mondo.
oji, quandu nc’i’u ricordu, mi guarda e ridi. S’ava sperdutu i quandu nta
televisioni nc’era na partita i tennis, mentri iddu jocava a scala quaranta.
Era giratu i spaddi, mancu a guardava: cu l’occhi nte carti. Se cadiva u mundu,
si spostava. Criju ca non si caddijau mai. Mancu dda vota chi nta n’autogrill
unu nc’i mpizzau a pistola nta schina, prima ’i nci futti u camiu: «Se ti muovi
ti stendo come un coniglio». Non si moviu, però non si fidau mi sa teni e nci
rispundiu: «E cu si, John Wayne?». Ora pariva ca u cuntu non era u soi: a
partita ava finutu e Galeazzi stava salutandu: «E dal centrale del Roland
Garros di Parigi è tutto: una cordiale buonasera a tutti». Cuntinuau m’i guarda
i carti e, mentri tutti erinu zitti e spettavinu m’i scarta, tuttu seriu,
chjanu chjanu, nc’i’a mollau: «nto culu».
pari c’a sentu, a vuci i don Ninu. Nci ntinnava, sa faciva gridandu. E poi spijava,
spijava sempri. Manchicani ch’era curiusu, cu dda risata chi si sentiva i fora
strata. Ridiva puru quandu u Pileri ndi cuntau ca ncunu figghiu i bonamamma
l’ava dassatu a pedi, pecchì nc’i’ava rrobatu a machina: «Era nu bellu 127,
aviva puru a quinta!».
trasiva u Micuneddu, cu na scarpa cchju ata e l’atra cchju vascia. Zoppijandu cercava
a Gazzetta, ca vucca faciva tsi-tsu–tsi-tsu, ma u penseru l’aviva sempri nto
cangiu du dollaru c’a lira. Nc’i nteressava ca s’aviva a regulari quandu nc’i
cumbeniva mi si scangia a pensioni chi nc’i rrivava da’ Merica.
nu bigliardu minavinu ch’i boccetti. I hijastimi i Galera jettavinu i pariti.
Voliva mi vinci a forza. Ma, a diri a verità, a nuddu nc’i piaciva mi perdi. U
Mammineddu, ch’era u cchju longu i tutti, pa prescia mi tira s’izau troppo
vijatu e si zziccau ca testa intra o lampadariu. Cumandé fravava i durci: era
pasticceri, ma ogni tantu stricava puru cavigghi e u tambureddu u levava comu o
ventu, quandu u Bagasciu sonava l’organettu nta chjazza. A so’ botta i diciannovi
restau nta storia, comu dda vota chi a boccetta nc’i partiu fora du bigliardu: na
scupettata chi pe nenti no mmazzau a nuddu i chiddi chi jocavanu e carti nto
tavulu avanti. U Mongulu e u zi’ Pinu eranu però i n’atra categoria, sapivinu
mi nc’i’unanu l’effettu, tiravanu i sponda comu s’era i dirittu, i ssai di voti
facivanu u filottu e, all’acchittu, si mpoiavanu al bacio.
Ragiuneri si gustava ssettatu, cu dda parrata rriggitana. Iddu era jocaturi i
carti: raminu, scala quaranta, trissetti. Comu a Pedazzi, chi a nuatri
figghjoli ndi portava i sordi i 5, 10 e 20 liri, pe collezzioni. ’O Farmacista
nc’i piaciva mi joca a calavrisa, ma era nu pocu levantinu e c’u rivorviru sempri
nta sacchetta. Ancora ndi domandamu comu nc’i vinni nta testa a Ntoni i cerca
mu mbrogghia. Quandu si nd’accorgiu, Ntoni fujiva avanti e u farmacista u
currijava ca pistola ’e mani, mu spara. Si gustava puru u maru Viddozzu, chi
ogni tantu nc’i veniva l’attaccu, si nghiuttiva a sicaretta e s’a faciva i
ncoddu.
n’atru bigliardu jocavanu a bazzica. U mastru era u Fotografu: se nc’i mancava
u pallinu, ca so’ palla era capaci mu faci puru s’era nta l’atru bigliardu.
Sasà mbeci nc’i mentiva tri uri, cu dda sticca avanti e arretu supra a manu,
tempu i faci nu tiru, ’e menzi i chiddi chi guardavinu nc’i calava u sonnu. Nta
chidd’atru bigliardu ancora, ogni tantu eu mentiva sutta ’o Vichingu, all’italiana. Dudici anni eu, na ottantina
iddu, ndi jocavimu l’orariu e nu jacciolu.
sirata, poi, rrivava Sparacani cu na para i landi i pizzi c’a sarda e ch’i
livi. Forsi, pizzi i dda manera, eu non ndi mangiai mai cchju.
Fine corsa
 |
| Photo @SaraBonfiglio |
Vorrei tornare bambina per potermi lanciare, ancora una volta, sulle tue gambe. Prendendo la rincorsa. Vivere in quel posto che era mio-solo-mio, per sempre. Non desiderare altro. Stretta tra le tue mani, come un trofeo da alzare o un’ostia da tenere alta. Essere la tua ragione di vita nella mezz’ora che precedeva i miei sogni fantastici, abitati dai folletti e dagli spiriti del bosco. Il premio alla fatica della tua giornata infinita, iniziata con il risveglio brusco dell’acqua gelida della fontana di fuori sul viso.
La dura vita dei campi. Tu e i muli, il silenzio dell’universo ritmato dal rumore degli zoccoli. Chissà se mi pensavi durante lo stillicidio di quel tempo lungo. Ma sì, certo che mi pensavi: non potevi che pensare a me, a noi, all’allegria chiassosa dei tuoi figli. Una ricompensa di riccioli e pagliaccetti, cotrareddi rannicchiati come cuccioli che si riscaldano con il loro stesso respiro. Con il terrore del buio e del pappu vecchiu.
Poi niente più. Di colpo. Senza neanche una parola. A cinque anni mi ritrovai mamma di Pinuccio, più piccolo di me, ma come me incapace di comprendere il perché di quel muro altissimo. Abituati al West che si spalancava al di là della porta della nostra casetta di tavole e lamiere, ci ritrovammo in una prigione di cemento affollata di bambini, smarriti tra le stanze infinite dell’orfanotrofio.
Galleggiavamo come piccoli astronauti, fuori dal tempo e dallo spazio. Giorni sempre uguali. Le facce ostili delle suore, facili al rimprovero. E poi quella mia tonaca larga, scomodissima per il gioco dell’elastico. Il mio preferito: salta dentro i due elastici, apri e chiudi, salta di lato, ruota e pesta l’elastico, incrocia… Movimenti che prima riuscivo ad eseguire a occhi chiusi mi risultavano ora impossibili.
Piangevo e non potevo, per via di Pinuccio. Dovevo rassicurarlo, fargli capire che presto saremmo andati via da quel posto triste. I nostri genitori non avevano colpa. Non avevano avuto altra scelta, l’avevano fatto per farci stare meglio. L’avevano fatto per noi.
I ricordi si incatenano agli odori, ai colori, a una folata di vento: déjà-vu improvvisi e inquietanti, come il freddo di quella mattina nelle ossa che ogni tanto ritorna, pungente. Le suore mi avevano fatto indossare il vestito buono, blu e bianco. Non sarei andata a scuola, ma non capivo cosa stesse succedendo. Nel parlatorio mi attendeva mio zio, la barba lunga e la faccia di chi non dorme da giorni. Non disse una parola. Uscendo dall’istituto il gelo dell’inverno mi ferì gli occhi, che cominciarono a lacrimare mentre attorno a me ogni cosa aveva sembianze indefinite. Cominciai a mettere a fuoco nell’istante in cui udì il pianto di mia madre, dal cortile popolato di silenzi. Il mio gigante dormiva al centro della stanza, in giacca e cravatta come prima di un matrimonio, quando rientrava con le tasche gonfie di pasta con il sugo e di cotolette.
La stessa giacca dell’ultima volta che era venuto a trovarci. Io e Pinuccio eravamo nel cortile, la madre superiora si avvicinò tenendo le mani dietro la schiena. Poi le allungò verso di noi: «cucù!». Due pacchi di biscotti! Per noi! Quindi alzò lo sguardo verso la terrazza, dove c’era nostro padre. Da quanto tempo ci stava osservando? Alto, bellissimo, sorrideva e ci faceva “ciao” con le cinque dita. Impazzita dalla gioia cominciai a correre verso la porta che dava sul cortile interno. Sentivo il cuore sbattere contro il petto, sempre più forte, quasi che volesse prendere il volo verso quella mano. Una suora mi bloccò sull’uscio: «non puoi». Non potevo andare da mio padre. Non potevo aggrapparmi alle sue ginocchia. Io, sua figlia. Fu l’ultima volta che lo vidi.
Chi mi avrebbe protetta, d’ora in avanti? Crescevo come quei gattini spauriti, lesti ad infilarsi nel primo buco al minimo rumore. Non ero capace di difendermi dalle insidie di un mondo che non conoscevo. Ero una straniera, osservata con la curiosità che si riserva agli animali del circo, commiserata per la mia condizione di “parcheggiata” presso l’orfanotrofio.
Un tempo che finì dopo l’esame di terza media, quando feci ritorno a casa. Avevo quattordici anni e nessuna esperienza fuori da quella campana di vetro. L’ingenuità mi rendeva facile preda, proprio ora che il mio corpo cominciava ad attirare gli sguardi avidi dei ragazzi. Come potevo resistere alle attenzioni di chi mi faceva sentire importante, io che non ero mai stata niente per nessuno?
Dissi di sì al primo che mi aveva avvicinato e fu la mia rovina. Un inferno cominciato subito dopo il fidanzamento “ufficiale” con Gianni, secondo tradizione celebrato in un giorno di festa comandata. Scegliemmo il Santo patrono, la messa nella chiesa piena di gente che ci circondava per farci gli auguri, le nostre mani intrecciate in fondo al corteo della processione, la cena con i parenti.
Una felicità troppo bella per essere vera era capitata proprio a me. Infatti, non era vera. Durò fino al primo ceffone: «non ti permettere di contraddirmi». Divenni presto una ragazza muta, reclusa in casa. Mai un’uscita per un cinema, le vetrine dei negozi, un gelato. Niente di ciò che era normale per qualsiasi altra ragazza. Volevo scappare da quella vita che frantumava i miei sogni di felicità, ma ormai ero in trappola. Il disonore non poteva e non doveva entrare nella nostra casa. Il matrimonio avrebbe migliorato le cose: così mi fu assicurato. L’arrivo di figli, poi, avrebbe salvato tutto.
Si sbagliavano. Ogni volta che prendevo un pacco di pasta o il pane a cridenza mi sentivo morire. Il mio nome segnato sulla libretta e accanto la lista della vergogna. Lui non lavorava, né si impegnava a cercarselo uno straccio di lavoro. Sua mamma, santa donna, a fine mese cercava di tappare qualche buco. La sua pensione ci permetteva di sopravvivere, ché vivere era impossibile. Lo sanno i miei piedi, che per due anni hanno calzato lo stesso paio di ciabatte, estate e inverno.
Purtroppo, lo sapeva anche Mino, quella volta che mi offrì un passaggio per tornare a casa. Accadde in una delle mie poche uscite dal paese, per una visita specialistica. Mi trovavo alla fermata dell’autobus del ritorno, quando udì una voce: «Maria, lo vuoi un passaggio? Così risparmi tempo e soldi». Mino era simpatico, spiritoso, la battuta sempre pronta. In meno di un’ora avevo riso più di quanto non mi fosse capitato in tutta la mia vita. I venticinque anni di età che ci separavano mi trasmettevano sicurezza. Non avevo mai smesso di cercare mio padre e avevo bisogno di qualcuno che si prendesse cura di me, che mi proteggesse. Come Mino, quando mi raccolse sotto il diluvio dopo l’ennesima lite con Gianni: la guancia calda, viola, segnata dalla violenza dei suoi schiaffi. Mi fece salire sulla macchina e mi asciugò le lacrime con la mano, mi accarezzò con una dolcezza a me sconosciuta.
Mi abbandonai a lui completamente, lo amai con la disperazione di chi sa di avere imboccato un vicolo senza uscita, che avrebbe portato alla gogna pubblica. Ero l’amante di un uomo sposato che poteva essere mio padre. Mino era riuscito a squarciare il velo del mio dolore, sentivo la mia anima rischiarata da una nuova luce. Forse era felicità, o forse illusione. Comunque mi bastava. Che la nostra fosse una storia impossibile contava poco: importava che finalmente vivevo.
Scoprii tardi la meschinità del suo magnificare l’impresa di portarsi a letto una coetanea di sua figlia. I nostri incontri erano prodezze da raccontare; io, lo strumento della sua vanità. E poi, si sa, “cu cunta menti a giunta”: in poco tempo diventai la sgualdrina di mezzo paese, una stupida che chiunque sarebbe stato in grado di scoparsi.
Dovevo fuggire, non voltarmi mai più indietro. Levarmi di dosso sguardi che erano sentenze. Strapparli dalla mia pelle. Puntare gli occhi di chi incrociavo senza provare vergogna. Salvare la mia bimba, l’unica nota positiva nel tragico spartito del mio matrimonio, dalla condanna senza appello di essere figlia di una puttana. Scappai di notte, la mia piccola stretta al grembo su quel treno che non voleva saperne di fermarsi. Mi attendeva la vita che ho voluto e che ho in qualche modo deciso. Anni come attimi, che inseguo a ritroso mentre svaniscono insieme a volti e parole. Sfumati in questo epilogo disincantato che sa di nostalgia delle tue carezze leggere sulle mie guance, ora che la corsa sta per finire.
Due parole sul referendum
Rispetto l’opinione di chi invece ritiene ancora prematuro o comunque non opportuno affrancarsi completamente dall’utilizzo dei fossili e, coerentemente, ha votato NO.
Rispetto anche chi non è andato a votare perché è stanco di questa politica e ne ha le scatole piene; così come rispetto quelli che sono rimasti a casa perché dell’avviso che tocchi alla classe dirigente di questo nostro Paese affrontare con competenza e responsabilità una materia così complessa. Comprendo le loro ragioni, che sono fondate.
Rispetto di meno chi invece ha deciso di disertare le urne esclusivamente per fare saltare il quorum, al termine di un “calcolo” politico che niente doveva avere a che fare con il contenuto del quesito referendario. Non si votava pro o contro Renzi e, per quanto mi riguarda, sono allergico ai plebisciti. Il trucchetto di unire il proprio NO con la percentuale (ahinoi sempre crescente) di astensionismo fisiologico che si registra ad ogni elezione è un’azione da “furbetti del quartierino” poco dignitosa, come tutte le “furbate”.
Rispetto meno ancora i dirigenti del Partito Democratico travestiti da ultras che si sono lasciati andare a battute da bar dello sport, con espressioni offensive nei confronti di chi non ha fatto altro che esercitare un diritto costituzionalmente riconosciuto, nonché una conquista di libertà ereditata dai nostri padri e nonni.
Non si scrive mai una bella pagina di democrazia quando così poca gente va a votare. Comunque la si pensi.
Dieci anni fa
Dieci anni a guardarli da qua sono un soffio. Una lunga apnea, un respiro trattenuto e poi rilasciato: ed è già oggi. Oggi una telefonata che non ti aspetti. Oggi le voci di dentro che mettono ordine nel caos di incredulità, dolore e fretta: «molla tutto e parti». Oggi un viaggio in macchina senza soste, all’arrivo gli occhi cisposi per quei 1600 chilometri percorsi d’un fiato, in trance, muti. Oggi i ricordi affastellati che assumono una coerenza luminosa. Che parlano di vita, non di morte. Di quella vita che nelle case del Sud è saga familiare, ovunque ci sia stato qualcuno che abbia voluto riscattare la storia dei propri cari.
Raccontano i sogni di chi ha scelto la rivoluzione andando via, nella valigia la speranza di un futuro migliore, per sé e per i propri figli. Storia di partenze e di incontri, storia di destini puntuali all’appuntamento della vita, quello che soltanto conta. Storia che ha i riccioli biondi di una figlia di Francia diventata più italiana degli italiani. Riccioli biondi e capelli lisci neri sulla testa dei figli e poi dei nipoti, il profumo dell’amore che non conosce confini, meticcio e sublime.
Resta il rimpianto per le tante cose che ancora andavano fatte e per le parole non dette, certo. I crateri che l’assenza (“più acuta presenza”) scava nell’anima, a distanza di anni. Le domande rimaste senza risposta sul perché della vita e della morte.
Domande di ieri, domande di oggi, in un presente eterno fatto di vuoti da riempire con il ricordo, con la felicità dei ricordi.
La festa del ritorno in una casa piccola, se non fosse stato per quella storia di partenze. Se non fosse stato per le onde infinite dell’oceano sfumate sulla battigia di un continente lontano, una distanza che trasforma l’abbraccio in un nodo indissolubile: «quello che è mio è tuo».
Il mare di ogni estate a Favazzina, gli occhi felici e il sale sulla pelle. Spruzzi e tuffi, gol e parate. Quanto mare abbiamo visto insieme? Dov’è finito, oggi, tutto quel mare?
Vuoti da colmare con una carezza ai fiori che la primavera fa sbocciare nel giardino eletto a buen retiro, ascoltando le canzoni che già canticchiarono giovani in chiodo sulle motorette, sorridendo per l’equilibrio precario di fotografie spericolate. Vecchi miti vissuti con la leggerezza di chi sa che tutto è possibile, nella stagione in cui tutto ancora era possibile.

L’intervista a Pont’i Carta
Qualche giorno fa sono stato contattato da Francesco Martino, che da un anno gestisce insieme a un gruppo di ragazzi di Sant’Eufemia d’Aspromonte il blog Pont’i Carta: abbiamo fatto una chiacchierata sui temi scottanti del momento, toccando questioni nazionali ma anche locali. Pubblico di seguito il contenuto dell’intervista, consultabile nella sua versione originale cliccando sul link:
https://ponticarta.wordpress.com/2016/04/09/a-colloquio-con-domenico-forgione/
Nei giorni scorsi abbiamo incontrato Domenico Forgione, segretario del circolo PD “Sandro Pertini” del nostro Paese. Domenico è un grandissimo studioso della storia di Sant’Eufemia, oltre che dottore di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea, giornalista pubblicista, scrittore e autore di numerosi libri sulla storia eufemiese e non solo. E’ proprio per questo, insieme al suo impegno politico che lo vede protagonista nel PD cittadino, che ci ha spinto ad incontrarlo e a porgli delle questioni. In maniera particolare, la nostra breve intervista si è soffermata su un tema che abbiamo deciso di affrontare con decisione anche nei prossimi giorni. Si tratta del referendum del prossimo 17 Aprile, evento che come spesso accade rischia di passare sottobanco, ma sul quale cercheremo di sensibilizzare il più possibile. Dunque, affronteremo anche nei prossimi giorni la “questione referendum” in diversi articoli. Intanto, vi lascio alla nostra conversazione con Domenico, auspicando che da essa si possano trarre già molti elementi di riflessione e di analisi sia sul referendum in se’, sia soprattutto sul nostro modo di porci con il contesto che viviamo, possa essere esso lavorativo, sociale o ambientale. Buona lettura.
1) Partiamo subito entrando nel vivo della questione che vogliamo affrontare. Che idea si è fatto del referendum del prossimo 17 Aprile?
Sono dell’avviso che bisogna sempre andare a votare, si tratti di referendum o di elezioni, anche per rispetto di chi ha lottato contro la dittatura fascista e ha pagato con la prigione e con la vita per la conquista di un diritto che oggi ci consente di essere un popolo libero. Non condivido la posizione di chi invita all’astensione. Ricorda il celebre invito rivolto agli elettori da Bettino Craxi nel 1991 (“andate al mare”) in occasione del referendum sulla preferenza unica, che segnò l’inizio della fine della Prima Repubblica. Credo però, anche, che lo strumento referendario sia talmente importante per il funzionamento della nostra democrazia che andrebbe utilizzato con maggiore parsimonia e preferibilmente per questioni di carattere generale, non tecniche, che rischiano di presentarsi come materia ostica per chi non sia un esperto del settore. Il referendum “sulle trivelle” ha assunto un valore che va oltre gli effetti che produrrà: sia che a vincere siano i Sì, sia se dovessero prevalere i No o, addirittura, anche nel caso di non raggiungimento del quorum. Questo perché, grazie all’intesa raggiunta tra governo centrale e Regioni, nessuna compagnia potrà mai più, in ogni caso, trivellare il mare entro le 12 miglia marine. Tuttavia, il referendum pone una fondamentale questione di principio riguardo la politica energetica nazionale, che personalmente gradirei sempre più “verde” e rispettosa della natura. Da qui il mio Sì, convinto: in favore dello sviluppo delle energie alternative, per la salvaguardia dell’ecosistema marino e, per dirla con le parole di Roberto Speranza, per la promozione di un modello di sviluppo ecosostenibile nel nostro Paese.
2) All’interno del Partito Democratico sono tantissime e molto diverse le posizioni riguardo al referendum. Bersani si è espresso favorevolmente al voto senza però sbilanciarsi verso una preferenza. Guerini e la Serracchiani hanno sposato la linea renziana dell’astensione, mentre Prodi ha chiaramente fatto intendere di essere sulla linea del NO. Infine Speranza ed Emiliano, molto critici con la linea di Renzi e favorevoli al SI. Visto che il referendum è stato proposto da nove regioni, di cui sette governate proprio dal Pd, non crede che ci sia stata un po’ troppa confusione? E il Pd eufemiese, quale linea ha deciso di sposare? Ci saranno delle vostre indicazioni?
Concordo sulla confusione, che però è anche conseguenza del carattere pluralista del Partito Democratico. Una ricchezza (la presenza al suo interno di diverse sensibilità) che diventa un handicap quando non si riesce a trovare un punto di sintesi. L’errore più grave, per il partito, sarebbe però fare di ogni appuntamento elettorale una sorta di regolamento di conti, un prova muscolare che produce soltanto disaffezione e alimenta l’antipolitica. Lo sforzo di tutti dovrebbe invece essere rivolto a far convivere le posizioni di tutti, senza il ricorso ai diktat della maggioranza: penso, ad esempio, alle troppe volte che su un provvedimento legislativo viene posta la fiducia. E senza, d’altro canto, che la minoranza del partito minacci di fuoruscire dal partito ogni volta che “va sotto”. La democrazia funziona così e, alla fine, in politica contano i numeri: chi ce li ha, porta avanti la sua visione di società, all’interno di una cornice di valori intangibili che i padri costituenti hanno scolpito, in particolare, nella Prima parte della costituzione repubblicana.
Per l’insieme di queste ragioni, non credo sia utile alcuna “crociata”. Personalmente andrò a votare Sì, però ritengo opportuno lasciare libertà di voto agli iscritti del circolo di Sant’Eufemia.
3) Noi di Pont’i carta, come blog nato proprio dalla necessità di sensibilizzare su temi che molte volte non sono conosciuti o che vengono troppo facilmente liquidati, abbiamo interesse a mettere in luce non solo ciò che potrebbe interessare il nostro paese, ma anche più largamente il nostro territorio, la nostra Regione e anche tematiche nazionali come il referendum. A tal proposito abbiamo scelto il referendum come argomento proprio col chiaro intento di sensibilizzare sul rapporto uomo e natura, oltre che su dei modelli economici di sviluppo nuovi e sostenibili. Alla luce di ciò, cosa pensa degli accertamenti che la magistratura sta effettuando sullo sversamento illecito di rifiuti speciali a Gioia Tauro, sempre nell’ambito dello scandalo “Trivellopoli” scoppiato in Basilicata? Quanto questa inchiesta potrà incidere sull’andamento del referendum?
Sin dall’esordio, ho salutato con favore la nascita del vostro blog, perché credo che ogni luogo di discussione sia (meglio: debba essere) occasione di crescita per la realtà in cui si vive. Vale sia nel caso in cui l’agorà sia reale, sia quando il confronto è virtuale, come nel caso del vostro blog o dei social network. Mi ha fatto pertanto molto piacere il vostro invito a rilasciare questa intervista e vi esorto a continuare su questa strada, quella dell’impegno costruttivo, della ricerca del dialogo e dell’elaborazione di proposte utili per la crescita sociale e culturale di Sant’Eufemia. Per rispondere al merito della domanda, mi auguro che l’inchiesta in Basilicata produca “anche” l’effetto di sensibilizzare maggiormente i cittadini sui contenuti del referendum. Ad ogni modo, ritengo che il lavoro della magistratura finalizzato all’accertamento di eventuali irregolarità nel trattamento di rifiuti speciali nell’impianto di Gioia Tauro non solo è giusto, ma siamo noi cittadini a doverlo pretendere con forza. Sulla salute delle persone non si scherza e se qualcuno ha commesso un reato, attaccando un falso codice identificativo su 26 mila tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, deve pagare.
4) Recentemente, in un incontro avvenuto nel nostro comune, cui ha partecipato anche il presidente dell’associazione “Ferrovie in Calabria” Roberto Galati, si è nuovamente discusso della situazione del nostro ponte di ferro della vecchia stazione. Cosa pensa della situazione del nostro ponte? Crede che possa divenire in futuro il simbolo di quel nuovo sviluppo economico sostenibile di cui parlavamo prima? Oppure è destinato solamente ad una funzione simbolica di “memoria collettiva” da conservare?
Nella battaglia per scongiurare la demolizione del ponte della ferrovia il PD di Sant’Eufemia si è speso molto, promuovendo una sottoscrizione che ha raccolto poco meno di 1.100 firme. Lo ha fatto grazie alla collaborazione dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni, in un momento di grande unità che ha fatto onore a tutti i protagonisti di quella lotta. Il primo passo, salvare il ponte, è stato fatto. Bisogna ora attivarsi per ottenere altri due importanti risultati: 1) mettere in sicurezza tutta l’area su cui il ponte insiste, che è interessata da una situazione di gravissimo dissesto idrogeologico; 2) recuperare e ridare “vita” al ponte stesso. In proposito, le soluzioni possibili sono diverse: dal ripristino della vecchia linea taurense San Procopio/Sinopoli – Gioia Tauro per il trasporto locale o in funzione turistica, alla realizzazione sul vecchio tracciato di una pista ciclabile e di un percorso naturalistico, sul modello della politica di recupero delle linee ferroviarie dismesse attuata in molte regioni d’Italia: soluzione, quest’ultima, che personalmente preferisco, in funzione della valorizzazione delle bellezze e dei prodotti dei territori che la ferrovia attraversa.
5) A proposito di futuro, come ultima domanda, vorremmo andare un po’ fuori tema. In quanto segretario del circolo del Pd “Sandro Pertini”, e in quanto studioso e profondo conoscitore della storia di Sant’Eufemia, cosa pensa che riservi il futuro al nostro paese? E, secondo lei, cosa serve seriamente al nostro paese per costruire un avvenire migliore? In tal senso, il circolo, che obiettivi si pone?
“Il futuro è un’ipotesi”, cantava Enrico Ruggeri quasi trent’anni fa. Quindi non so, con certezza, cosa esso ci riserverà. Vedo, come tanti altri, i segni di un declino preoccupante: il lavoro che manca, l’isolamento anche fisico che il nostro paese ha subito con la soppressione dello svincolo autostradale, i troppi giovani costretti ad emigrare, che portano altrove le proprie competenze e vanno ad arricchire il tessuto sociale delle realtà che li accolgono e dove riescono ad affermarsi. Mentre qua la meritocrazia latita e i diritti vengono spesso cambiati per generose concessioni del potente di turno, del compare o di chi sfrutta il bisogno altrui per fare carriera. Sant’Eufemia ha la fortuna di avere al suo interno le “armi” per costruirsi un futuro migliore: realtà associative vivaci e molto attive sul territorio, professionalità riconosciute e un tessuto economico con straordinarie potenzialità, a cominciare dal settore agricolo e da quello dell’allevamento del bestiame. Si tratta di riuscire a capitalizzare questo vasto patrimonio, mettendo da parte l’egoismo dei singoli e pensando, finalmente, al bene comune. La politica non può considerarsi fuori da questo processo: è anzi chiamata a svolgere un compito di guida, in una prospettiva di sintesi delle soluzioni migliori proposte dalle esperienze amministrative maturate negli ultimi decenni. Un paese con poco più di 4.000 abitanti ha bisogno di una prospettiva il più unitaria possibile, che valorizzi al meglio il capitale umano di cui dispone.