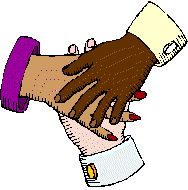Hanno ragione d’essere, oggi, le categorie destra e sinistra? Morte e sepolte le ideologie del ventesimo secolo, possiamo ancora accapigliarci su cosa sia di destra e cosa di sinistra, come faceva Giorgio Gaber, prendendo in giro un po’ tutti?
Il Paese è prostrato da una crisi economica che dura da anni e della quale non si intravede la fine. Osservando i comportamenti di personaggi assurti a modelli di vita – è sufficiente un quarto d’ora davanti ad una telecamera per diventare un ascoltato ed influente maître à penser – è possibile rilevare quotidianamente un angosciante declino etico della società. Il messaggio, semplice e agghiacciante, è che con i soldi si può comprare tutto; con i compromessi nessun traguardo è irraggiungibile; l’intelligenza e il merito sono meno utili di uno stacco di coscia vertiginoso o di un passaggio dalla villa del Lele Mora di turno. Il sistema politico italiano e, prima ancora, la società civile stanno andando a rotoli e ancora – come se le lancette fossero pietrificate al 1994 – il dibattito si avvita sull’antitesi tra berlusconismo e antiberlusconismo. Una coazione a ripetere che, di fatto, è stata funzionale al perpetuarsi del potere di una classe politica inadeguata. Dove sarebbero ora i più fedeli lacchè di Berlusconi o, sull’altra sponda, i suoi più tenaci oppositori senza questo scenario di perenne lotta del bene contro il male? Personaggi che alimentano il culto della personalità del capo o la demonizzazione di colui che è considerato l’unico vero responsabile di tutti i mali della società italiana e non, piuttosto, il suo prodotto.
Soprattutto, ha senso una contrapposizione del genere nel Mezzogiorno, visto che non fa altro che andare a vantaggio del governo centrale e degli interessi del Nord del Paese, quelli che storicamente hanno avuto la prevalenza su ogni ipotesi di perequazione sociale, politica ed economica dell’Italia? Il fiorire di esperimenti politici a forte connotazione localistica sembra rappresentare una novità significativa. È la reazione di coloro che sono stanchi di essere considerati soltanto un voto affidato a classi politiche distanti, distratte e disinteressate. Qualcuno dovrebbe infatti spiegarci per quale motivo da giorni i mass media parlano esclusivamente dell’alluvione nel Veneto e ignorano (o quasi) la Campania e, soprattutto, la Calabria. Per quale motivo nessuno – come invece hanno fatto Corriere della Sera e La7 per il Veneto – si è fatto promotore di una sottoscrizione per raccogliere fondi per le regioni meridionali alluvionate?
Ecco perché occorre “fare fronte”, al di là di ogni appartenenza politica. Non per elemosinare qualcosa, quanto per avere riconosciuta pari dignità.
L’equivoco
Dagli articoli e commenti pubblicati negli ultimi due anni, prima sul sito santeufemiaonline e ora su questo blog, si potrebbero fraintendere le mie reali impressioni sulla società attuale. Vorrei pertanto rassicurare i miei venticinque lettori (per dirla alla Manzoni): la nostalgica e facile suggestione del “si stava meglio quando si stava peggio” non mi appartiene, se non nel senso che soggettivamente posso preferire alcuni aspetti del passato rispetto a comportamenti che non condivido o non riesco a decifrare con i miei (desueti?) parametri di valutazione. Comprendo invece che i tempi sono mutati e che la realtà odierna è completamente diversa rispetto a quella di qualche decennio fa, perché le trasformazioni intervenute hanno stravolto le abitudini e la vita delle persone.
È sufficiente parlare con chi oggi ha settanta-ottanta anni per comprendere di quanto siano cambiate le nostre comunità. Parecchie persone sono cresciute in abitazioni prive di beni che noi diamo per scontati: elettricità, acqua corrente, servizi igienici, cucine, riscaldamenti (per non dire degli elettrodomestici e di tutto quanto sia collegato allo sviluppo tecnologico), persino brande e materassi. Quando, alla fine degli anni ’50, cominciarono ad arrivare in paese i primi televisori e la gente dei quartieri (le “rrughe”) si riuniva nelle abitazioni dei pochi fortunati che ne possedevano uno per vedere “Il musichiere” o gli sceneggiati, in tanti andavano a controllare dietro quell’incomprensibile scatolone per verificare se non ci fosse qualcuno nascosto.
Questo per dire che non sono un luddista, non considero cioè il progresso tecnologico un male; e per affermare una verità lapalissiana, cioè che senza dubbio la qualità della vita è di parecchio migliorata dal secondo dopoguerra ad oggi. È pur vero, però, che lo sviluppo industriale ha provocato contraccolpi negativi nelle relazioni sociali: si parla di meno, si tende sempre più all’autosufficienza affettiva, sono aumentate le paure verso l’esterno, si sta sempre di più in casa e di meno sulla strada, a contatto con la vita vera. Quando escono, specie i ragazzini e i bambini, sono sostanzialmente parcheggiati da qualche parte (tempo pieno a scuola, palestra, scuola di ballo, di musica, di tutto).
Questo non significa che i giovani e i bambini di oggi siano meno intelligenti. Semmai è vero il contrario, dato che l’abilità tecnologica di alcuni è veramente sorprendente. Bambini che ancora non hanno imparato a scrivere riescono ad utilizzare correttamente un computer o un telefonino. La loro capacità di apprendimento è di gran lunga superiore rispetto a quella delle generazioni passate, probabilmente perché il cervello, ricevendo maggiori stimoli dall’esterno, è più allenato e predisposto a sviluppare le capacità cognitive.
Il corto circuito scatta quando il nuovo fa tabula rasa del passato, quando sulla modernità non vengono innestati quei valori tanto “antichi” quanto bistrattati: famiglia, amicizia, rispetto, responsabilità.
La famiglia non può abdicare al proprio ruolo educativo. Il permissivismo e il giustificazionismo di alcuni genitori sono dannosissimi. Molti ragazzi pensano che tutto sia loro dovuto e che possano (e debbano) fare qualsiasi cosa passi loro per la testa. Questo perché non è stato loro insegnato che accanto ai diritti esistono anche i doveri; che il rispetto del prossimo e dell’ambiente che ci circonda è un valore fondamentale; che senza responsabilità non può esistere una vita di relazione.
Così come non può rinunciarvi la scuola, con i suoi insegnanti sempre più umiliati e considerati alla stregua di baby sitter, privi di qualsiasi autorevolezza.
Né tantomeno i rapporti interpersonali possono ridursi al click distratto con cui su Facebook si accetta una richiesta di amicizia. Non è inusuale che persone “amiche” nella rete, se si incontrano per strada neanche si salutano. Per me questo non è normale: è semplicemente inconcepibile.
La morte in diretta
Provo un profondo disagio nell’esprimere un giudizio negativo su Federica Sciarelli e sul suo “Chi l’ha visto?”, che seguo sin dagli inizi e reputo un esempio di vero servizio pubblico in palinsesti quasi interamente monopolizzati da programmi-spazzatura. Niente a che vedere, insomma, con tutti quei programmi che speculano – da mane a sera – sulle disgrazie altrui, esibendo le solite compagnie di giro e gli immancabili fenomeni da baraccone. Tutti a favore di telecamera, tutti pronti a dispensare la propria verità, i propri sospetti, i “si vedeva che era così”. Spesso lontani parenti delle vittime, gente che in molti casi non ha mai avuto rapporti (o non ne ha da tempo immemorabile) con i malcapitati protagonisti della tragedia, ma che ne approfitta per poter godere del proprio warholiano quarto d’ora di celebrità.
In quale gorgo stiamo precipitando, se non riusciamo a fermarci davanti a niente, se non comprendiamo che davanti all’orrore occorre a volte spegnere le telecamere e lasciare che il dolore torni ad essere un sentimento privato, da tenere per sé e non da esibire nella piazza televisiva?
La spettacolarizzazione della morte è un esempio di come qualsiasi sentimento, per esistere, ha bisogno di essere buttato in piazza, condiviso con altri, “linkato” come avviene su internet per qualsiasi cosa, sia un post, una foto o un video.
E poi c’è questa abitudine, pessima, di fare baccano, quando invece occorrerebbe stare zitti. Ci sono dei momenti in cui si devono spegnere le luci, abbassare le voci e lasciare campo al silenzio. La morte esige silenzio, compostezza, raccoglimento. Non quegli odiosi applausi che ormai frequentemente si odono ai funerali. Da sempre, l’applauso esprime gioia, non dolore. Il dolore si esprime con il silenzio e con le lacrime, possibilmente a telecamere spente.
Dovrebbe esistere un modo per affermare il diritto di cronaca senza turbare le coscienze. Quelle telecamere che insistevano sul volto della madre per carpirne le reazioni alla notizia della confessione resa ai giudici dal cognato hanno fatto del male alla famiglia della vittima, a noi che assistevamo e alla televisione in generale. È stato superato il limite del buonsenso. Quello che avrebbe dovuto avere Federica Sciarelli (o qualche responsabile del programma), interrompendo d’imperio la diretta dalla casa dell’assassino, senza chiedere alla madre di Sarah se volesse ascoltare le notizie che si stavano diffondendo in rete e spiegando, dopo (alla famiglia e al pubblico), ciò che stava accadendo.
L’untore
La caccia all’untore è da sempre uno sport molto popolare in Italia. Tanto quanto l’adulazione verso i potenti. Comportamenti molto diffusi che costituiscono due facce della stessa medaglia. In genere, è proprio colui che è platealmente adorato – specialmente se potente e temuto – ad essere altrettanto odiato una volta caduto in disgrazia. Pescare nella storia della nostra nazione esempi che avvalorino questa tesi è esercizio facilissimo. Piazzale Loreto – una scena da “macelleria messicana” (Ferruccio Parri) – non sarebbe altrimenti comprensibile. Il cadavere dell’uomo osannato fino al giorno prima, preso a calci, sputato, orinato.
Fatte le debite proporzioni, è ciò che accade nella vita quotidiana: a scuola, in ufficio, al comune, nel condominio, ovunque vi siano rapporti gerarchici, anche soltanto in senso lato. Vale a dire dappertutto.
Da circa un mese a questa parte, il giochino preferito degli Italiani è lo sputtanamento di Marcello Lippi. Mentirei se dicessi che il personaggio mi sta simpatico. Tutt’altro. Lo trovo arrogante, saccente, troppo pieno di sé e poco rispettoso del mondo che lo circonda. Senza contare che agli occhi di un interista, l’ex allenatore della nazionale sconta non soltanto il pessimo ricordo lasciato nella breve parentesi nerazzurra, ma soprattutto il peccato originale della sua juventitudine, l’essere stato, a vario titolo, compagno di merende di Moggi, Giraudo e Bettega. Ritengo inoltre pertinenti gran parte delle critiche sui limiti tecnici della nostra nazionale e sulle responsabilità del suo condottiero. Insomma, un po’ se l’è cercata.
Eppure ho l’impressione che si stia superando il segno. Una sensazione che è diventata certezza quando ho visto in tv uno spot di suonerie per telefonini che invitava a scaricare una canzone dall’eloquente titolo “Vergogna”. Inutile dire chi sia il personaggio che dovrebbe provare vergogna e i motivi. In quel momento ho pensato che aveva ragione Indro Montanelli nel sostenere che quando si accendono i roghi occorre mettersi sempre dalla parte della strega, anche a rischio di salire sul rogo con lei.
La redazione sportiva Rai ci ha massacrato per giorni con le “dieci” domande alle quali Lippi avrebbe dovuto rispondere, magari prima di confessare la propria irredimibile colpevolezza e la richiesta spontanea di essere confinato in un Gulag siberiano. Non ho notato nella Rai identico accanimento per questioni ben più importanti, per esempio le dieci domande (toh, non hanno neanche la dote dell’originalità) del quotidiano “La Repubblica” per Berlusconi dopo lo scandalo D’Addario, letteralmente censurate dal servizio pubblico nazionale.
È un segno dei tempi, di un certo giornalismo ormai diventato gara di ugole, come abbiamo potuto constatare per un anno intero con il fenomeno Mourinho, tanto per restare nel campo sportivo. Criticato perché irregolare, irriverente e anticonformista, ma già rimpianto perché personaggio straordinario, l’unico in grado di fare riempire pagine di giornali e trasmissioni intere con una sola battuta contro quel sistema che fa mangiare nello stesso tavolo giornalisti, allenatori, procuratori. Magari gli stessi che di fronte alle telecamere fanno la faccia feroce e se ne dicono di tutti i colori. Ognuno recitando il proprio copione.
Dalla parte di Gino
“Non sono colpevoli”: con questa motivazione sono stati rilasciati Matteo Pagani, Marco Garatti e Matteo Dell’Aira, i tre volontari di Emergency che erano stati arrestati dalle autorità afghane il 10 aprile a Lashkar-gah (dove sorge un ospedale dell’organizzazione fondata da Gino Strada), con l’accusa gravissima di essere tra gli organizzatori di un attentato contro il governatore della provincia di Helmand.
Per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la liberazione dei tre volontari è “un sollievo per tutti”. Forse lo è di meno per quelli che sin dal primo momento avevano gettato benzina sul fuoco, avallando acriticamente un’accusa inverosimile e infamante sulla base di un pregiudizio ideologico molto diffuso a destra: Strada è un irregolare, dogmatico nel suo ripudio della guerra “senza se e senza ma”; Emergency non fa distinzione nel prestare soccorso ai feriti, siano essi civili, militari o terroristi. Per questi motivi, ha abbastanza credito in certi ambienti la deduzione di relazioni pericolose con i fondamentalisti islamici.
I primi ad avvalorare la tesi di “Strada terrorista” erano stati i giornali del Gran Capo, con il ritratto a tutta pagina del fondatore di Emergency vestito da talebano o con alcuni titoli (“Terroristi, vittime o pirla”) che insinuavano il dubbio di una complicità quasi necessaria, a meno che i volontari non fossero davvero degli sprovveduti.
Anche qualche politico con responsabilità di primo piano ha sentito il bisogno di esternare e non ha fatto di certo una figura leggendaria.
Alfredo Mantica, sottosegretario agli Esteri: “Il governo italiano deve accertare la verità, mi auguro che la verità dia ragione a Gino Strada, ma ho delle perplessità”. Parole non esattamente improntate alla cautela, tanto per usare un eufemismo, condite dalla stoccata finale: l’accusa a Strada e ad Emergency di fare “un po’ troppa politica” a dispetto della vocazione umanitaria. Anche le dichiarazioni di Larussa e Capezzone sono apparse quasi compiaciute per l’imbarazzo e la difficoltà in cui si è trovata Emergency. Segno che non deve essere la simpatia il sentimento più diffuso negli ambienti governativi e che a qualcuno non sarebbe affatto dispiaciuto approfittare dell’incidente per screditare e distruggere mediaticamente il detestato Strada. D’altronde, ONG e cooperanti, ma anche giornalisti e freelance (come Enzo Baldoni o Giuliana Sgrena) sono spesso dipinti come quelli che, in fondo “se la cercano”, alla stregua degli incoscienti che vanno in vacanza in Yemen nonostante le raccomandazioni contrarie del governo.
Su cosa possa celarsi dietro la scoperta dell’arsenale trovato all’interno dell’ospedale (due cinture da kamikaze, cinque pistole, nove bombe a mano) non ci sono molte certezze. È stato rievocato il rapimento di Daniele Mastrogiacomo (2007), una vicenda che lasciò strascichi a causa del ruolo decisivo svolto da Emergency nella trattativa per la liberazione del giornalista di Repubblica. In particolare, i fratelli dell’autista di Mastrogiacomo, che fu barbaramente sgozzato dai talebani, hanno accusato l’ospedale di essere una “centrale” del terrorismo.
Per Strada si tratta invece di un complotto ordito dai servizi di sicurezza afghani e dalle stesse truppe britanniche Isaf per togliere da quell’area un testimone scomodo (Emergency) nel momento in cui si profila l’offensiva di primavera contro i talebani di quella provincia, che presumibilmente verrà condotta senza tanti riguardi per la popolazione civile. Gli arcinoti “effetti collaterali” delle guerre, ma anche di quell’ossimoro che è la missione di pace condotta da soldati armati fino ai denti.
Se fosse davvero questo l’obiettivo, purtroppo è stato raggiunto, dato che l’ospedale è stato momentaneamente chiuso e tutto il personale trasferito a Kabul.
Minita
Più o meno 35 anni fa, quando ho cominciato ad articolare qualche frase, a chi mi chiedeva quale fosse il mio nome rispondevo “Minita”. Di quell’età ho conservato, negli anni, soprattutto la curiosità, il piacere della ricerca e la capacità di stupirmi per le scoperte che la vita riserva a ciascuno di noi. Ma ogni scoperta, ogni pensiero, per avere vita hanno bisogno di essere condivisi, altrimenti si rivelano soltanto un esercizio sterile. È quello che mi auguro di poter fare grazie a questo blog con coloro che troveranno interessanti e degni di discussione gli argomenti che di volta in volta proporrò o verranno da altri suggeriti.
Devo ammettere che non provo molta simpatia per chi, bardato da una solidissima e inattaccabile armatura concettuale, ha sempre pronta la risposta per ogni interrogativo. Non credo che esista una verità valida sempre e ovunque, ma infinite verità. A volte è difficile riuscire a sostenere con sicurezza cosa sia giusto e cosa sia sbagliato: oggi riteniamo esecrabili comportamenti e convinzioni che i nostri avi consideravano legittimi ed eticamente corretti. Dipende tutto dal contesto storico, culturale e sociale cui facciamo riferimento. Per questi motivi mi trovo più a mio agio con chi è ben disposto al confronto e a rivedere, se necessario, le proprie certezze per trovare, nel rapporto dialettico, le risposte alle tante domande che chiunque abbia un minimo di sensibilità quotidianamente si pone.
“Quante strade deve percorrere un uomo prima di poterlo chiamare uomo?”. È la domanda con cui Bob Dylan, quasi cinquant’anni fa, cambiò non solo il modo di fare musica, ma anche la vita di milioni e milioni di giovani, consegnando alla storia un interrogativo che rimane di straordinaria attualità.
Quando il senso di vuoto e la solitudine del pensiero diventano insopportabili, in una società in cui sembra paradossale l’isolamento, può risultare utile anche affidare alle onde virtuali della rete un messaggio dentro la bottiglia. A futura memoria.