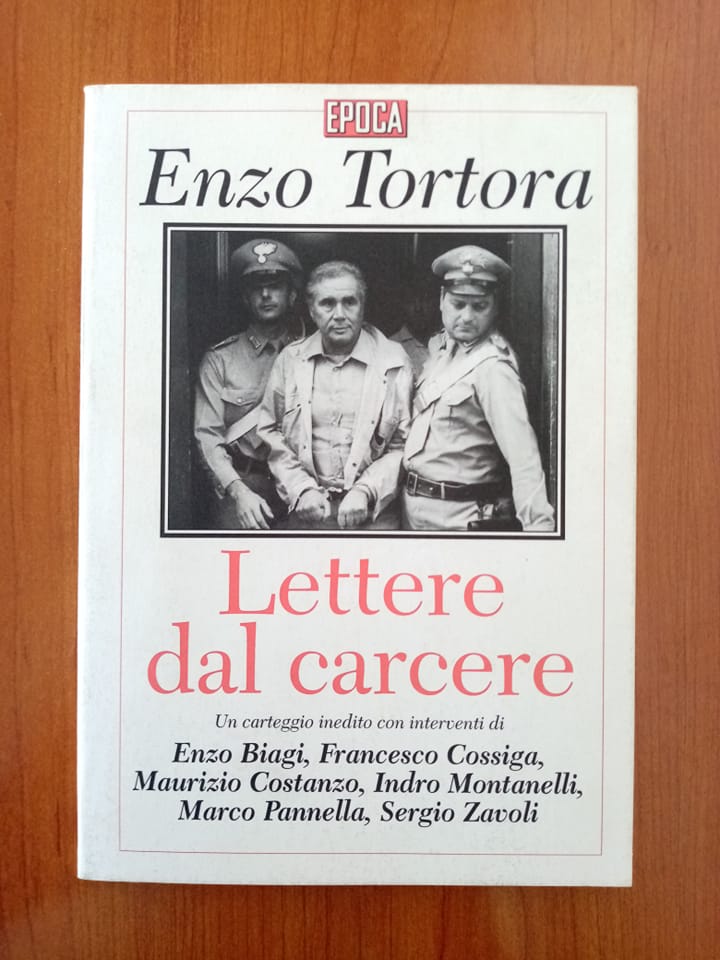Ci sono oggetti che, a guardarli oggi, sembrano usciti dalla macchina del tempo del mitico “Doc” in “Ritorno al futuro”. Nella soffitta del passato ritroviamo la malinconica testimonianza degli anni volati via. Noi stessi ci sentiamo vintage, ed è forse questo il motivo per cui a volte ci assale un senso inspiegabile di inadeguatezza di fronte allo stravolgimento antropologico della società odierna.
Azzardo un’ideale graduatoria, rigorosamente in ordine alfabetico e ovviamente integrabile ad libitum.
CINGHIA LEGALIBRI. Prima dell’irruzione degli zaini, gli studenti portavano a scuola i libri stretti in cinture elastiche con la chiusura a gancio, in genere una fibbia di metallo. Andava benissimo per due-tre volumi più qualche quaderno, che venivano disposti in ordine di larghezza, dal basso verso l’alto. Oltre, o quando c’era in aggiunta un vocabolario, il trasporto diventava una prova di equilibrio, talmente faticosa da necessitare un continuo cambio di braccio. Penne e matite venivano agganciate all’elastico, solitamente personalizzato con la scritta del proprio nome, della squadra del cuore o della band musicale preferita.
ENCICLOPEDIA. Per intere generazioni il motore di ricerca più diffuso e consultato ha avuto forma cartacea. In ogni casa uno scaffale era occupato dai volumi che raccoglievano, in ordine alfabetico, le voci informative sullo scibile umano. Costituivano lo strumento di conoscenza dal quale gli studenti copiavano a mano il contenuto sul “quadernone delle ricerche”. I suoi pesantissimi tomi, in copertina rigida e dotati di spigoli appuntiti, se tirati in testa erano in grado di offendere.
FAZZOLETTO. Accessorio immancabile nelle tasche di uomini e donne, è stato soppiantato dai kleenex. A differenza dei fazzoletti in carta, quello in cotone era però lavabile e perciò riutilizzabile nei secoli. Oggi potrebbe diventare il simbolo delle battaglie ambientaliste, ma non se lo fila più nessuno. Eppure c’è stato un tempo in cui il “muccaturi” a fiori, a righe su fondo bianco o colorato, orlato, rendeva elegante e raffinato il soffio del naso.
FLIPPER. Il re delle sale da gioco si ergeva tra i videogiochi cabinati. Una specie di Luna Park che sprigionava luci e suoni, mentre l’indicatore di punteggio saliva fino ad impazzire quando raggiungeva il record. Centrare i bersagli con la biglia colpita dalle alette azionate dai pulsanti esterni era adrenalina pura. Alzi la mano chi non avrebbe voluto essere Carlo Verdone nel film “Troppo forte”, l’unico giocatore al mondo capace di strapazzare il flipper senza farlo andare in tilt.
GETTONE TELEFONICO. Oggetto vintage per antonomasia, sulle sue tre scanalature nascevano e morivano le storie d’amore, in anni obiettivamente difficilissimi. Mettersi in fila se non si trovava la cabina telefonica libera, attendere il proprio turno con la rabbia che montava quando la conversazione, che sembrava conclusa, riprendeva con maggiore pathos, comporre il numero dell’amata e incrociare le dita affinché fosse lei a prendere la cornetta e non il padre. In generale, rappresenta la preistoria della telecomunicazione. Tempi in cui si chiamava il 161 per conoscere l’ora esatta.
MAPPE STRADALI. Raramente le tasche degli sportelli delle auto non contenevano le mappe stradali della Michelin, che oggi è possibile consultare digitalmente. Prima dell’avvento di internet calcolare il percorso stradale necessitava diottrie e clima non ventoso quando la mappa veniva spiegata in tutta la sua estensione, sul cofano anteriore. E valla a ripiegare.
MUSICASSETTA. Abbiamo odiato il nastro che si inceppava e che andava srotolato aiutandosi con una matita. Indimenticabili le registrazioni dalla radio di personalissime compilation, scegliendo tra le canzoni proposte dalla voce impostata dei dj, tra una dedica e l’altra. Puntuale, nel corso dell’esecuzione, l’irruzione del messaggio pubblicitario che invitava a visitare il negozio di scarpe all’angolo.
PETTINE. Accessorio irrinunciabile per gli uomini di tutte le età, veniva custodito in astucci di similpelle e usciva fuori dalla mariola delle giacche al momento opportuno. Salvava situazioni, quando il calvo non andava di moda ed era possibile imbattersi in riporti che sfidavano qualsiasi legge della fisica. Sull’auto trovava collocazione nell’aletta parasole, pronto all’uso se il conducente aveva bisogno di una sistematina a capelli, basettoni e baffi.