Una reazione istantanea come un riflesso condizionato. Come il piede che scalcia non appena il martello colpisce il ginocchio. Come il sorriso che scatta naturale davanti alla bellezza di questi ragazzi colorati e con gli occhi pieni di speranza. Occhi che non si arrendono, che non possono arrendersi perché se lo fanno loro c’è davvero da abbassare la saracinesca e sparire. Lasciare il campo ai bruti che sabato notte, ma neanche tanto (alle 21.40 circa), hanno tentato di colpire al cuore l’avamposto più alto della cultura eufemiese, quel liceo scientifico che rappresenta la speranza e l’argine. La speranza di un futuro migliore; l’argine alla barbarie che pure resiste e rilancia. Per questo motivo non occorre abbassare la guardia e insistere, tenere i riflettori accesi perché anche se non sono stati rilevanti i danni materiali dell’esplosione nei locali che ospiteranno il liceo “Fermi”, è grave l’azione subita da tutta la città. Non è stato colpito il liceo, attentati del genere feriscono il futuro di un’intera comunità, che per questo è chiamata a reagire. A schierarsi. A metterci la faccia. Accanto ai ragazzi e ai loro bellissimi striscioni di vita, contro la morte della violenza e della sopraffazione.



Farlo con ancora più forza di quella espressa stamattina nel corteo partito dalla sede attuale del liceo e che, percorrendo le vie del paese, ha fatto tappa nei locali dell’ex scuola elementare “Purgatorio” e da lì è poi approdato nella sala consiliare del Palazzo municipale, dove due portavoce degli studenti hanno rivolto al sindaco di Sant’Eufemia Mimmo Creazzo l’invito a non indietreggiare nell’impegno a favore della legalità e della civiltà:

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari,
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei,
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare”. (Martin Niemöller)
Iniziamo con la citazione di questo testo, perché pensiamo che un episodio come quello avvenuto sabato sera, un ordigno esploso dentro la nuova scuola, non possa (e non deve!!!) passare sotto silenzio.
Il silenzio delle persone genera l’indifferenza: l’indifferenza uccide!
Noi non possiamo tacere sull’uso di metodi che generano violenza e paura.
Sogniamo un luogo, e Sant’Eufemia può essere quel luogo, dove non abbiamo più paura e dove pensiamo che lavorare per il Bene Comune sia un valore irrinunciabile. Perseguire il Bene Comune vuol dire, soprattutto, tutelare i diritti dei più deboli, di quelli che stanno ai margini della società, di chi non ha voce.
Sogniamo un luogo in cui possiamo vivere relazioni basate su collaborazione e concordia, perché pensiamo che la Pace sia una delle condizioni fondamentali per vivere felici e vivere una vita autentica.
Per questo scendiamo in piazza e ci mettiamo la faccia, perché il nostro futuro sia possibile e non venga precluso da chi crede di opprimere e prevaricare sugli altri.
Chiediamo a chi gestisce la cosa pubblica di testimoniare in modo più responsabile la tutela dei diritti dell’uomo e la promozione della bellezza della condizione umana.

Un inno alla partecipazione contro il disimpegno, l’indifferenza e l’apatia, per una battaglia che è di tutti. Che ognuno di noi deve sentire propria. Perché, come ha sottolineato nel suo intervento la dirigente scolastica del “Fermi” Graziella Ramondino, “la scuola è da sempre stata il tempio della cultura e della civiltà: la profanazione di una sua istituzione, quale che sia la matrice, simboleggia comunque un attentato alla civiltà e al progresso degli uomini e va respinta con ogni forza ed energia per evitare che conquiste millenarie dell’occidente civilizzato regrediscano d’un colpo nella barbarie”.
In una comunità che deve essere solidale, il momento dello scontro e delle divisioni non può sussistere quando viene colpito il futuro delle nuove generazioni. L’auspicio è che siano organizzate altre iniziative, oltre a questa spontanea e “improvvisata” dalla sera alla mattina attraverso il tam-tam dei social sulla spinta emotiva dell’indignazione, alla quale non tutti coloro che avrebbero voluto hanno potuto partecipare. Un consiglio comunale aperto darebbe una dimensione ufficiale e un taglio istituzionale, com’è giusto che sia quando episodi così gravi colpiscono la cittadinanza.
Questo è il momento dell’unità, l’ora in cui la comunità diventa testuggine. L’ora in cui tutti devono dare un contributo di civiltà, la goccia che insieme ad altre gocce diventa mare. L’ora in cui l’I care di don Milani diventa azione.
Perché quel “me ne importa, mi sta a cuore” contiene la forza rivoluzionaria del cambiamento reale, quello delle coscienze che la scuola è chiamata a formare. Delle donne e degli uomini che verranno e che vogliamo migliori di noi.


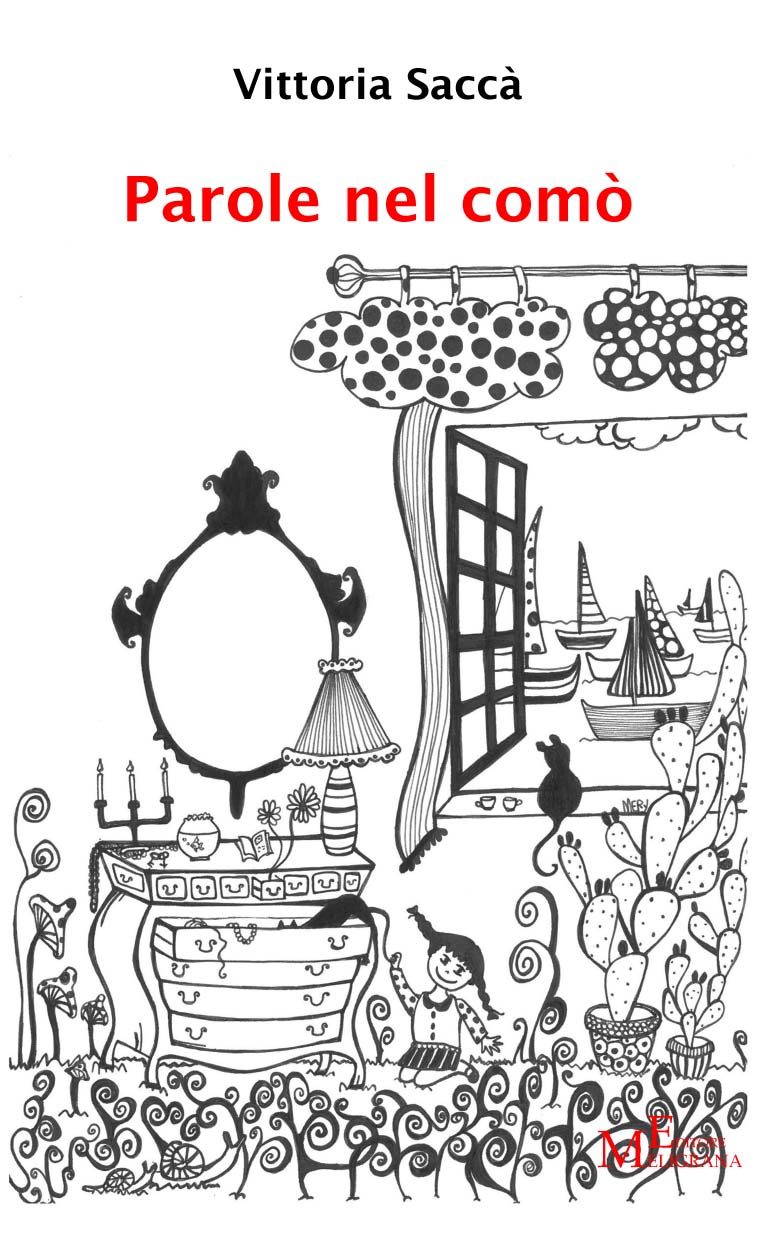


 Si trattò, allora, di una sorta di omaggio da parte di Cavour e dell’establishment sabaudo al politico leader della rivolta siciliana del 1848, capo del governo provvisorio che aveva dichiarato decaduto Ferdinando IV di Borbone e offerto la corona del regno di Sicilia al duca di Genova, Alberto Amedeo di Savoia (il quale tuttavia non accettò l’offerta). Ma fu anche una designazione dal profondo significato politico, perché Ruggero (o Ruggiero) Settimo “dei principi di Fitalia”, antico protagonista del movimento liberale che in Sicilia aveva ottenuto la costituzione del 1812 e poi guidato il moto separatista del 1820, rappresentava quei ceti dominanti della Sicilia, un tempo autonomisti e indipendentisti, che ora venivano recuperati alla causa nazionale e unitaria.
Si trattò, allora, di una sorta di omaggio da parte di Cavour e dell’establishment sabaudo al politico leader della rivolta siciliana del 1848, capo del governo provvisorio che aveva dichiarato decaduto Ferdinando IV di Borbone e offerto la corona del regno di Sicilia al duca di Genova, Alberto Amedeo di Savoia (il quale tuttavia non accettò l’offerta). Ma fu anche una designazione dal profondo significato politico, perché Ruggero (o Ruggiero) Settimo “dei principi di Fitalia”, antico protagonista del movimento liberale che in Sicilia aveva ottenuto la costituzione del 1812 e poi guidato il moto separatista del 1820, rappresentava quei ceti dominanti della Sicilia, un tempo autonomisti e indipendentisti, che ora venivano recuperati alla causa nazionale e unitaria.











