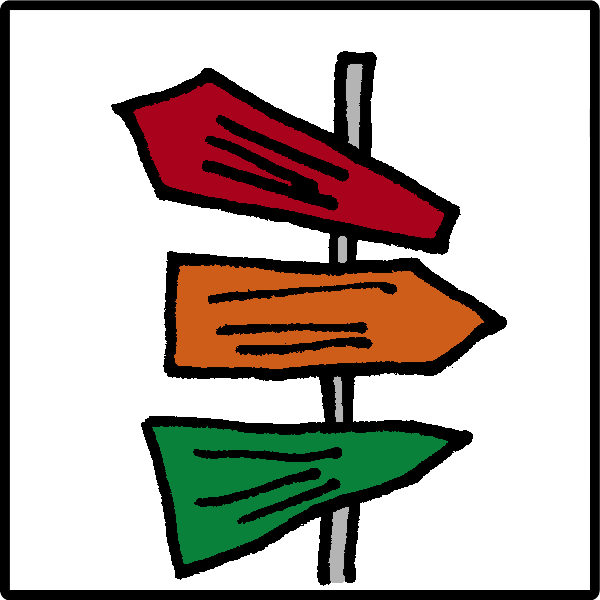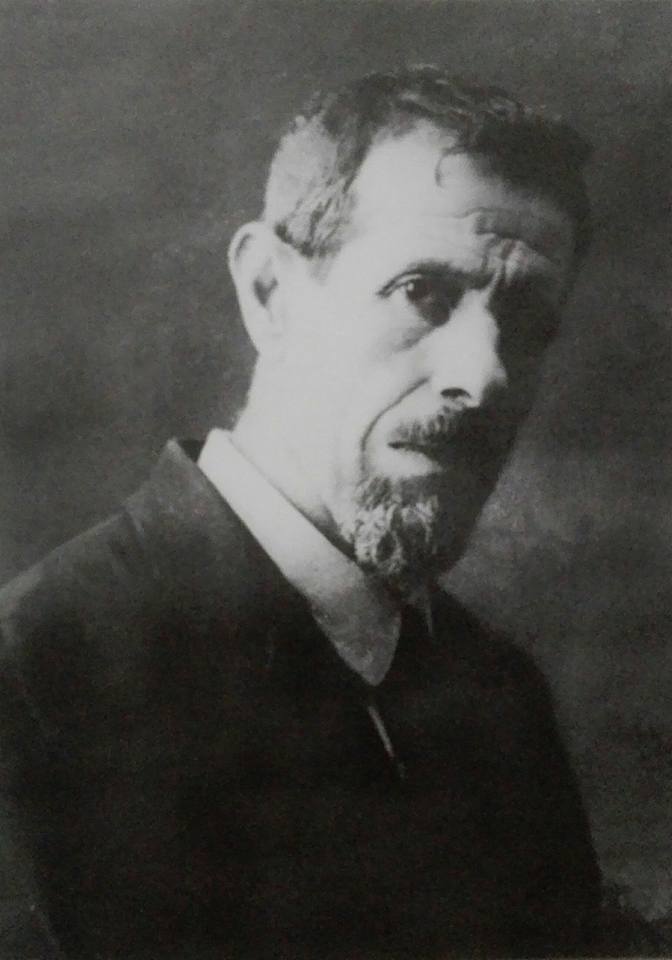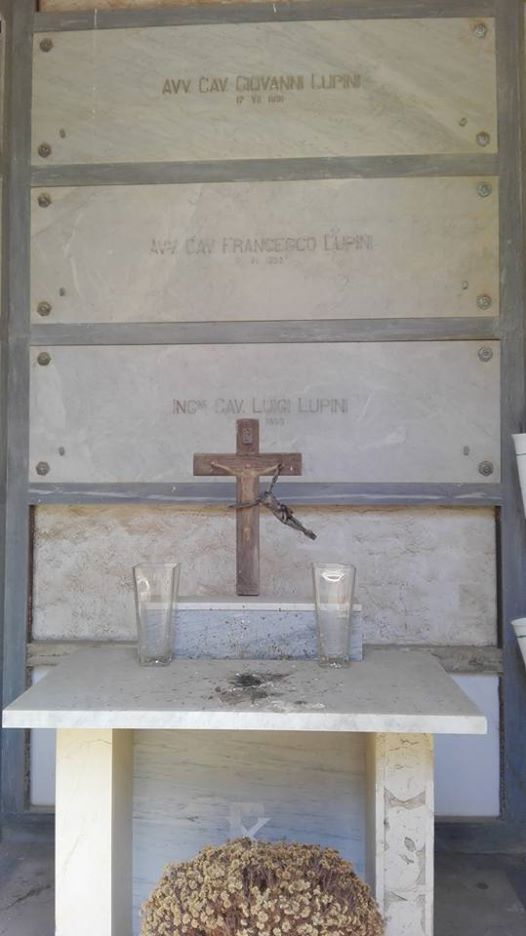Prima dell’espansione urbana degli anni Ottanta nelle contrade Giovancortese, Castellano e Arena esistevano pochi nuclei abitativi, dal carattere per lo più familiare. Un’espressione che ancora sopravvive nel linguaggio popolare rendeva l’idea della perifericità di quest’area: “calu ’o paisi” dicevano infatti i suoi abitanti quando intendevano recarsi nel centro del paese. La presenza di un albero di noce in seguito abbattuto accomunava inoltre Giovancortese e Castellano con il toponimo ’a nucara. Per “scendere” al Petto si percorreva la via Arena ancora sterrata, che a un certo punto si restringeva in un viottolo stretto e scosceso. In quegli anni era così.
Ma erano anche tempi in cui i rapporti di vicinato avevano il carattere familiare tipico delle rrughe di un tempo. Anche chi arrivava “da fuori” finiva per sentirsi parte di una famiglia più allargata. Così è stato per la mia famiglia: i nostri vicini Micuzza e Ninuzzo Condina sono stati per noi qualcosa di più che semplici vicini di casa. La stessa cosa vale per la figlia Nina che abitava proprio nel piano sopra di noi e per gli altri figli, le cui voci si rincorrevano di balcone in balcone tutto intorno. Ma al centro c’erano loro due: Ninuzzo con quel suo fisico da omone burbero che incuteva timore e Micuzza con la sua dolcezza naturale, con quel sorriso che oggi più che mai fa emozionare.
Era una società fatta di semplicità e di affetto genuino. Mia mamma, per loro, è stata davvero un’altra figlia: non è retorica, è la realtà. Quando Micuzza arrivava dalla scala esterna che univa la loro casa al pianerottolo della nostra, aveva sempre qualcosa in mano: “cimedde” e amaretti preparati nel forno a legna, conserve sott’olio, olive “scaddate” o sotto sale, frutti del suo giardino.
Ninuzzo e Micuzza sono al centro di Giovancortese anche oggi che hanno 97 e 95 anni; ora che – sabato 28 ottobre – festeggeranno 75 anni di matrimonio. C’era la guerra nel ’42 e soltanto la sua buona stella consentì al marinaio Antonino Condina di uscire indenne da quella tragedia, anche se vide i corpi carbonizzati dei morti e udì le urla strazianti degli ustionati nel bombardamento alleato della base navale di La Maddalena, il 10 aprile 1943, quando furono attaccati gli incrociatori “Trieste” (che fu affondato) e “Gorizia” (che nonostante i gravi danni riuscì a riparare a La Spezia): 140 vittime e circa 200 feriti gravi.
Da allora il mondo è cambiato, ma questa coppia dalla straordinaria longevità continua ad essere il centro di Giovancortese, perché quest’area si identifica con la loro storia: la storia di una civiltà contadina che ha ancora tanto da insegnare: sacrificio, lavoro, generosità. Gente semplice che ha speso la propria vita per offrire ai figli una possibilità di crescita.

Ninuzzo e Micuzza sono il cardine di una famiglia che nel tempo si è sparpagliata in Italia, negli Stati Uniti e in Australia: sette figli, diciassette nipoti e trentadue pronipoti che in paese però tornano di continuo, a turno, perché qua trovano ristoro: nel sorriso di Micuzza che sconfigge la malattia e nell’energia di Ninuzzo che tutti i giorni si siede a bordo della sua mitica Golf amaranto per andare in farmacia o all’orto, da dove torna con mazzetti di fiori di zucca e buste di cetrioli, zucchine e pomodori da regalare a parenti e amici.
Il richiamo della terra è elisir di lunga vita, quella terra lavorata con la zappa da ragazzo e che ha sempre continuato a lavorare: anche quando ha cominciato a fare altro, quando dall’asino è passato al camion e agli altri mezzi di cantiere necessari per dare l’avvio all’urbanizzazione di Giovancortese.
Ninuzzo, l’ultimo cestaio del paese, che intreccia sapientemente i “panari” tra un gioco enigmistico e l’altro. E che ancora pianta alberi, perché “tra qualche anno faranno i frutti”. C’è della magia in questa concezione del tempo che si fa beffe dell’età.

E c’è della magia nel sorriso di Micuzza, anche quando sembra giungere da un mondo altrove: un mondo fatto di ricordi confusi e faticosi, che solo l’amore di figli e nipoti può in qualche modo mettere insieme per tentare di ricavarne un senso.
Quella stessa magia che si respirava quando, da bambini, assistevamo al rito dell’apertura delle valigie di qualche loro figlio di ritorno dall’estero per dividerci gli Hershey’s Kisses, i cioccolatini americani a goccia con la caratteristica “miccia” che spuntava dall’incarto argentato. La stessa magia che si spande nell’aria quando Ninuzzo abbraccia Micuzza e dice: «’A me’ figghiola».