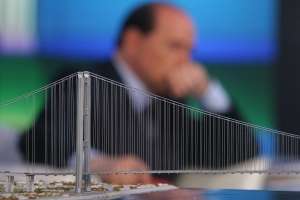C’è un preoccupante silenzio attorno alla vicenda di Francesco Azzarà, l’operatore di Emergency rapito il 14 agosto a Nyala, nel Darfur, regione del Sudan dove dal luglio del 2010 è attivo un centro pediatrico messo in piedi dall’organizzazione fondata da Gino Strada. La Farnesina tace, mantenendo la linea inaugurata da Franco Frattini nei giorni successivi al sequestro. Siamo fermi alla dichiarazione del deputato Pdl Lella Golfo, che riprendeva fonti diplomatiche: “Francesco è in ottime condizioni e sarebbe stato individuato il luogo in cui è tenuto prigioniero”. Da quattro mesi è un “non possiamo parlarne per motivi di sicurezza”, per “problemi di intelligence” e per “non mettere a repentaglio l’incolumità del prigioniero”.
La mobilitazione iniziale è stata imponente, in Calabria e in tutta Italia. L’immagine di Azzarà sugli edifici pubblici di moltissime città, negli stadi, portata alla Marcia per la pace di Assisi dal comitato “Francesco Libero”. Poi è sceso il silenzio. Le uniche informazioni al di fuori del burocratese del ministero degli esteri sono venute da Cecilia Strada, che davanti alla Commissione straordinaria dei diritti umani del Senato, a metà settembre, dichiarò che Emergency era riuscita a stabilire un contatto diretto con Azzarà (“resiste bene, per quanto possibile nella situazione in cui si trova. Mangia e beve e tiene duro”) e, qualche settimana dopo, da Gino Strada, intervenuto telefonicamente a Che tempo che fa per annunciare che “ci sono buoni motivi per dire che molto presto potremo riabbracciare Francesco”.
Quando si immaginava imminente la soluzione, qualcosa si è però inceppato, facendo saltare tutto. Da allora, non è più filtrato nulla. Sui giornali e sulle televisioni nazionali la notizia non ha ormai alcuna risonanza. A tenere alta l’attenzione sembra essere rimasto soltanto il deputato del Pd Franco Laratta, che già nei mesi passati aveva ripetutamente esortato l’ex ministro degli esteri Franco Frattini ad intervenire in Aula sulla questione. Una nuova interrogazione, presentata insieme al collega di partito Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 21, chiede ora al neoministro Giulio Terzi di riferire “se il governo segue con costanza il sequestro di Francesco Azzarà; se vi sono stati contatti con i rapitori; se si hanno notizie sulla condizioni e sullo stato di salute del rapito”.
A chi su twitter gli ha posto domande sulla sorte del volontario di Motta San Giovanni, il ministro Terzi (più verosimilmente, il suo ufficio stampa) ha risposto: “seguiamo costantemente, con massima attenzione. Il riserbo è nell’interesse di Azzarà”. Per cui difficilmente se ne saprà di più. Qualcosa però non torna in una vicenda che, data per risolta nello spazio di un mese, si è rivelata complessa e, per l’opinione pubblica, indecifrabile. Proprio per questo, sul caso Azzarà occorre tenere accesi i riflettori.
Aveva ragione Bennato
Ci hanno insegnato che tutti gli –ismi sono la degenerazione di idee buone. A parte il fatto che una simile affermazione è opinabile, è giustizialismo – quindi negazione della giustizia – indignarsi per quanto sta accadendo a Reggio Calabria e, più in generale, in Calabria?
Un altro facile e diffuso luogo comune accusa la magistratura di invadere lo “spazio” della politica e di fare, essa stessa, politica. Un’azione eversiva, al servizio di non meglio precisati “poteri forti”, contro l’ordine costituito, quello che una malintesa idea di democrazia considera legittimato a qualsiasi porcheria dal consenso popolare, che viene così caricato di un significato etico e populista contrario ad ogni principio democratico. Invece è vero il contrario. La magistratura occupa uno spazio vuoto, lasciato incustodito da partiti che non sono capaci di selezionare una classe politica degna di questo nome, e da una società civile tenuta al guinzaglio dal padrone di turno, oggi come 150 anni fa.
Il problema è uno solo e racchiude tutti gli altri. Se di notte tutte le vacche sono nere, se il magistrato è uguale all’avvocato, che è uguale al politico, che è uguale allo ’ndranghetista, che è uguale all’imprenditore, che è uguale al poveraccio che non sa come arrivare a fine mese nella regione più povera d’Italia; se tutto è uguale e immutabile, vinceranno sempre “loro”. Possono arrestarne 100 al giorno. Vinceranno sempre “loro”, perché ridurre tutto a una questione di ordine pubblico fa soltanto comodo a chi si sciacqua la bocca con l’antimafia da salotto e da convegno, con l’antipolitica, con le banalità qualunquiste. Perché qua – Calabria 2011 – questo sta succedendo. Che non si capisce più chi sta con chi. E per spiegarcelo, deve scendere un giudice da Milano.
Joe Sarnataro & Blue Stuff, Nisciuno! (dall’album E’ asciuto pazzo ‘o padrone, 1992). Venti anni dopo, le parole scritte da Edoardo Bennato per Napoli sono ancora attuali.
Comunque vada, dovrebbe essere un successo
Questione di ore e ci dovremmo avviare ad un esecutivo guidato da Mario Monti. C’è una gran voglia di archiviare al più presto la stagione berlusconiana, diciassette anni vissuti in apnea, rincorrendo annunci sempre più mirabolanti, una “rivoluzione liberale” promessa e mai realizzata, il rimpianto e la delusione di tanti per ciò che poteva essere e non è stato, come in una famosa poesia di Gozzano.
Non mancano però i colpi di coda. Il Pdl è lacerato, Alfano non sembra in grado di produrre una sintesi che tenga insieme chi non vuole sentir parlare di governo Monti (Brunetta, Rotondi, Matteoli, Sacconi) e chi invece è più possibilista e, anzi, lo considera un passaggio ineludibile in questa fase (Frattini, Scajola, Alemanno, Formigoni, Lupi). L’appoggio esterno può rappresentare un compromesso accettabile? Forse no. Perché a quel punto bisognerebbe valutare la reazione di Terzo polo e Pd, che non avrebbero alcun interesse ad intestarsi provvedimenti di lacrime e sangue, con il Pdl e la Lega a martellare l’opinione pubblica in un’infinita campagna elettorale. Maroni è stato chiaro: da lunedì la Lega è all’opposizione e oggi finisce il ciclo politico iniziato nel 1994, con l’alleanza tra Bossi e Berlusconi. È un “tutti liberi” e non si capisce quale potrebbe essere l’approdo. Proprio il timore di perdere il fedele alleato e di vedersi sbriciolare tra le mani il partito trattengono Berlusconi dallo sposare apertamente la soluzione Monti, altrimenti vissuta come una vera e propria liberazione. Per molti, all’interno del Pdl, la rottura con la Lega è un prezzo troppo alto, soprattutto fino a quando Casini insisterà nel suo terzismo.
Tutto sembra quindi condurre a Monti, da ultimo anche la correzione di tiro di Di Pietro, inizialmente per le elezioni anticipate. Comunità internazionale e mercati si sono già espressi in maniera favorevole, dimostrando un protagonismo al limite dell’ingerenza negli affari di uno Stato sovrano. D’altronde, sono stati Fmi e Bce a decretare la fine dei governi di Grecia e Italia, circostanza sulla quale comunque si dovrà riflettere per capire quale sarà il destino delle democrazie nei prossimi anni.
Monti o non Monti, se il prossimo governo non vuole fallire la propria missione, deve prendere pochi ma significativi provvedimenti, dei quali peraltro si parla da tempo immemorabile. Senza esempio e credibilità, nessuno avrà mai l’autorevolezza necessaria per potere imporre sacrifici. Ecco perché tra i primi provvedimenti, da prendere ora, non da promettere per il prossimo decennio, occorre inserire l’abbattimento dei costi della politica (riduzione del numero dei parlamentari, pesante decurtazione dello stipendio, abolizione di vitalizi, privilegi e benefits) e una robusta patrimoniale. Seguiti da una legge sul conflitto d’interessi affinché “non accada mai più” e da una riforma della legge elettorale che restituisca al cittadino il potere di scegliersi i rappresentanti in Parlamento. Un cronoprogramma da realizzare nel più breve tempo possibile e poi andare al voto. Ma questa classe politica sarà capace di uno scatto di dignità?
E meno male che non è successo niente
Ha dovuto arrendersi all’evidenza. Non ce n’era più uno favorevole alla “bella morte” in un’ordalia parlamentare di prodiana memoria. Si è fermato un attimo prima. Merito, forse, dell’invito di Bossi a fare un passo “di lato”, giunto dopo che già il ministro dell’Interno Maroni aveva dichiarato che l’accanimento terapeutico non aveva senso. Verrebbe proprio da dire sic transit gloria mundi, pensando a quanto i destini e la fortuna della Lega siano dipesi dal rapporto preferenziale avuto con Berlusconi.
L’immagine del premier in Aula, impegnato a controllare i tabulati della votazione per accertarsi sull’identità dei “traditori” è una nemesi crudele per il presidente del consiglio insediatosi con la più ampia maggioranza della storia repubblicana. Sino alla fine, nonostante l’atmosfera da fine impero, è stata però una gara a chi era più convincente e surreale nel minimizzare. Bastava ascoltare il giornalista di Libero Filippo Facci, tanto per fare un esempio utile anche per deprecare la latitanza della Rai, nel momento più delicato per il governo, e l’ottimo servizio pubblico reso invece da una televisione privata (La7), con la lunghissima no-stop pomeridiana: “non è successo nulla”. Cos’altro doveva accadere, se hanno votato 308 deputati su 630 (309 se si prende per buona la giustificazione di Gianni Malgieri: “ero in bagno”)? Il Rendiconto generale dello Stato è stato approvato grazie all’astensione dell’opposizione. In altre parole, la maggioranza non esiste. E Maurizio Paniz aveva ancora la forza di argomentare che “non è detto che quelli che si sono astenuti oggi siano contrari al governo. Occorre fare prevalere la legge dei numeri. Da qui a dire che si è conclusa una storia politica ce ne corre”. Mentre Antonio Martino cercava di metterla sul decoro: “Berlusconi merita una fine più gloriosa. Dovrebbe cercare la fiducia in Parlamento sulla lettera della BCE e, se il Parlamento vota contro, vuol dire che in questo Parlamento non c’è nulla”. Un giochino, o un ricatto.
Sul piano strettamente procedurale, il premier non è tenuto a dimettersi, in assenza di un voto di sfiducia. Ma i consigli degli alleati e lo spread Btp/Bond schizzato a quasi 500 punti non hanno certamente confortato i propositi di resistenza ad oltranza. Cosicché, poco dopo le 18.30, c’è stata la tanta invocata salita al Colle e la promessa di rassegnare le dimissioni subito dopo l’approvazione della Legge di Stabilità. Un modo per concedersi un finale di partita dignitoso, prima di passare il pallino a Napolitano.
A quel punto inizierà un’altra partita, nonostante la contrarietà del leader del Pdl ad ogni ipotesi contraria alle elezioni anticipate. I giochi di Palazzo sono iniziati. Con il fronte anti-voto, interno allo stesso Pdl, pronto ad appoggiare una personalità prestigiosa capace di traghettare il Paese fino al 2013. Altri, invece, temono l’ennesimo bluff. Di Pietro, per esempio, consiglia prudenza e insinua il dubbio sulle reali intenzioni di Berlusconi. Che alla fine potrebbe approfittare dei prossimi giorni per realizzare l’ennesimo gioco di prestigio e ricompattare la maggioranza. Una provocazione, data la promessa fatta al presidente della Repubblica. Ma al tramonto le ombre si allungano e fanno più paura che mai.
Un’altra settimana di passione, forse l’ultima
Buona regola, oltre che misura di prudenza, è attenersi al vecchio e saggio consiglio del Trap: “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. In altre parole, non bisogna mai dare nulla per scontato. Soprattutto con “lui”. Ha già dimostrato ampiamente di avere una capacità di risollevarsi degna di Amintore Fanfani, il “rieccolo” di montanelliana memoria. D’altronde, viene spesso paragonato a “Ercolino sempre in piedi”, mitico pupazzo della Galbani che più lo atterravi e più si rialzava.
Comunque, pare che ormai sia cosa fatta. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per scrivere la parola “fine” sulla fallimentare esperienza di governo iniziata nel 2008, con la più ampia maggioranza avuta da un governo repubblicano. Il vuoto creato attorno al presidente del consiglio è palpabile. In Italia e all’estero. Nel suo stesso schieramento, è un invito sempre più insistente a farsi da parte. E non solo tra i malpancisti, quella genia di parlamentari pronti a vendere la residua dignità per un posto da sottosegretario. “Responsabili” fino a quando hanno un tornaconto personale: una poltrona o la garanzia di una ricandidatura. Se anche Gianni Letta si è convinto che “così non si può andare avanti”, siamo ai titoli di coda. Non bastasse la fronda interna (con i vari Formigoni, Scajola e company attenti ai possibili movimenti tellurici del dopo Berlusconi), gli osservatori internazionali sono ancor più espliciti. Il titolo del Financial Times è eloquente: “In nome di Dio e dell’Italia, vattene”.
C’è quasi dell’eroismo nella resistenza opposta dal premier. O dell’irresponsabilità, dalla prospettiva opposta. Forse la consapevolezza che, una volta fuori dal bunker di Palazzo Chigi, molte giornate dovrà trascorrerle nelle aule dei tribunali.
Intanto, è un fuggi-fuggi generale. La maggioranza è un’anguilla che a tentare di bloccarla scappa da tutte le parti. Parlamentari dati in uscita sui quali il pressing di Denis Verdini e dello stesso premier non sembra più produrre effetto. Ma non definiamoli eroi. Tra coloro che ora vestono la maschera dei censori, la stragrande maggioranza è responsabile dello sfascio morale in cui si trova l’Italia. Sono quelli che hanno votato qualsiasi porcata e che si sono sfilati soltanto in questo decadente epilogo. E che con questa legge elettorale saranno rieletti. Difficile pensare che qualcuno sia disposto a fare cadere il governo e poi sparire dalla circolazione. I movimenti al centro sono frenetici ed è probabile che partiti di crinale come Udc ed Mpa diventeranno una lavanderia politica.
Fine di una storia, dunque. Con un rimpianto. Quello di non essere stati in grado di farcela da soli. Alla fine, dovremo ringraziare la comunità internazionale che ha provocato l’isolamento di Berlusconi, e Paolo Cirino Pomicino, il regista delle manovre che stanno sfilando uno ad uno i parlamentari pidiellini. Va a finire che moriremo davvero democristiani.
Il ritorno di Santoro
Che sarebbero state poche le novità, è stato chiaro sin dall’ingresso di Santoro nello studio sulle note della canzone di Vasco Rossi “I soliti”. Il pubblico di “Annozero” non ha avuto difficoltà a risintonizzarsi su “Servizio Pubblico”, praticamente il sequel del talk show andato in onda su Rai2. La stessa apertura con l’anteprima del conduttore, che ha ricordato due maestri del giornalismo, Enzo Biagi e Indro Montanelli, ed evocato la “rivoluzione civile” auspicata da Mario Monicelli. La stessa musica, quella di Nicola Piovani. Persino gli stessi caratteri utilizzati per scrivere il titolo del programma. Una formula vincente, confermata dai dati d’ascolto. Circa tre milioni di telespettatori e il 14% di audience (dietro soltanto a Rai1 e Canale5) il colpo messo a segno grazie ad una “multipiattaforma” composta da emittenti locali, Sky, siti internet e radio. La dimostrazione che è possibile fare televisione non di nicchia anche al di fuori del finto duopolio Rai-Mediaset.
“Sarà una tv che sale sulla gru”, era stata la promessa. E due gru, simbolo della protesta dei disoccupati, fanno parte della scarna scenografia. Con esse, tre torri d’acciaio da dove il “frate indignato” Vauro, con il suo “giramento di cordoni”, presenta le sue vignette, Giulia Innocenzi lancia in diretta i sondaggi su Facebook e il “paese reale”, quello dei disoccupati e dei precari, prende la parola. Sul palco non c’è il tavolo di “Annozero”, ma soltanto due sedie per gli ospiti della puntata, intitolata “Licenziare la casta”: l’imprenditore Diego Della Valle e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, sottoposti alle domande di Franco Bechis, Luisella Costamagna e Paolo Mieli, il “complottatore capo” (copyright di Giuliano Ferrara) del piano di disarcionamento del premier. Doppio Travaglio, come Vauro: “la balla della settimana” – il magistrato Ingroia “partigiano” della Costituzione – e “i soliti ignoti” sull’argomento della puntata. Asciutto e incisivo il servizio di Sandro Ruotolo sugli sprechi della politica, al quale hanno fatto da complemento le considerazioni di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, coppia di giornalisti abituata a fare le pulci alla casta. Ottimi i contributi provenienti dalla “strada”: l’intervista al deputato di Fli che ha definito Finmeccanica “il marchettatoio” di questo governo; le rivelazioni di Antonio Razzi, sedicente eroe per avere avuto il “coraggio” di tenere in vita il governo; la stizza di Claudio Scajola, beccato all’uscita dal famigerato appartamento, in parte pagato a sua insaputa dall’imprenditore Diego Anemone.
Nel complesso, prova superata, anche se alcune cose vanno riviste. Per esempio, sarebbe bene ascoltare più campane. E poi, non andare “fuori traccia”, un’impressione che si è avuta con l’intervista alla testimone chiave dei processi sul “bunga-bunga” e con il servizio sul latitante Valter Lavitola, autodefinitosi “lo sfigato della situazione”. Lo schema disegnato sulla lavagna dall’ex direttore dell’Avanti per spiegare i soldi a Tarantini è stato un numero da avanspettacolo, ma la vetta della comicità è stata raggiunta con il comizio di Scilipoti: “è finito il tempo dei cialtroni! È iniziato il tempo della meritocrazia!”.
Il Big Bang di Renzi e quell’idea che manca
Il segnale inequivocabile dell’approssimarsi delle elezioni sono le faide che si stanno scatenando all’interno del partito democratico e, più in generale, nel centrosinistra. Un riflesso pavloviano: appena si affaccia l’ipotesi di una votazione e, ancor più, di una possibile vittoria, iniziano i litigi. Verrebbe quasi da rimpiangere il centralismo democratico del vecchio Pci. Ora è “tutti contro tutti e ognuno per se”, al massimo per la propria corrente. I volti, alla fine, sono gli stessi di sempre. Sulla questione, ha ragione da vendere Matteo Renzi: “non è possibile che cambino continuamente i simboli dei partiti e restano sempre le stesse facce”.
La tre giorni alla stazione Leopolda ha ufficializzato le ambizioni di leadership del sindaco di Firenze. Una proposta di rottamazione del Pd e di un vecchio modo di fare politica, al quale si vuole contrapporre una proposta diretta e partecipata, non ingessata da rituali oligarchici. Un “partito format”, secondo la definizione di Aldo Grasso, giovanilista, ammiccante, piacione. “Si è presentato con il vestito della prima comunione”, ha ironizzato Luciana Littizzetto, mentre Maurizio Crozza è stato più cattivo: “il niente che avanza”. Il “Big Bang” ha ovviamente scatenato anche la reazione dell’establishment di sinistra. “Tardo blairismo in salsa populista”, per Rosy Bindi; “Renzi nel Pd è una contraddizione”, la quasi scomunica di Cofferati. Diplomatico invece Bersani. A differenza di Vendola: “Renzi è il vecchio”. Di certo, non unisce. Tanto da alimentare le peggiori illazioni. È stato addirittura ripescata dagli archivi Mediaset una puntata della Ruota della fortuna alla quale partecipò (e vinse). È stato ricordato l’incontro con Berlusconi ad Arcore (dicembre 2010), una visita a domicilio inconsueta da un punto di vista istituzionale, guardata dal Pd con sospetto e irritazione. È stato sottolineato con abbondante dose di malizia il contributo di Giorgio Gori (l’ex direttore di Canale 5 che portò in Italia il Grande Fratello, poi fondatore di Magnolia, società che produce L’Isola dei famosi) alla stesura delle “cento idee per l’Italia”. Tre indizi che fornirebbero la prova schiacciante di un Renzi “Berlusconi di sinistra”. Pierfranco Pellizzetti è andato giù pesante: “Il solo elemento di novità del renzismo è l’uso spregiudicato delle tecniche di comunicazione imbonitoria”.
Dalla disfida tra i ricostruttori di Bersani e i rottamatori di Renzi, a rimetterci potrebbe essere, come al solito, l’intero centrosinistra. Il programma della Leopolda, è stato detto, è discutibile e integrabile. A mio avviso, una lacuna andrebbe colmata in via preliminare. Altrimenti è impossibile confrontarsi sul resto. Il peccato originale della sinistra è la mancata approvazione di una legge sul conflitto d’interessi, subito dopo la vittoria alle elezioni del 1996. Bisogna stabilire, una volta per tutte, che chi – come il premier – si trova al centro di un groviglio di interessi, soprattutto nel settore dell’informazione, non può fare politica, per la ragione elementare che il suo tornaconto personale prevarrà sempre sul bene della collettività. Oggi, non sarebbe neppure un provvedimento punitivo contro Berlusconi, ormai al termine della sua parabola politica. Semplicemente, la regolamentazione di un’ anomalia inconcepibile in un Paese democratico.
Si fa, non si fa, si fa, non si fa…
Il primo ad affrettarsi a dire che no, il ponte si farà lo stesso, nonostante l’approvazione della mozione presentata dal dipietrista Antonio Borghesi, è stato il ministro Ignazio La Russa: “la mozione dice che il governo eventualmente può sopprimere i finanziamenti per l’opera, ma posso assicurare che non lo farà”. A ruota, la precisazione di Palazzo Chigi, dello stesso tenore. Qualche giorno fa, era stato il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, a ribadire che il Ponte rimaneva una priorità del governo, nonostante l’Unione europea non avesse inserito il Ponte tra le opere prioritarie del Corridoio 1.
Troppo semplice cavarsela con la battuta di La Russa: “una mozione non si nega a nessuno, ma vale per quello che vale”. La sensazione è che sia stata posta una pietra tombale sulla grandeur berlusconiana da immortalare con una costruzione faraonica. Bocciata con un provvedimento di buon senso che rimedia ai tagli dei trasferimenti del governo a Regioni ed Enti locali per le infrastrutture, andando a recuperare così 1,7 miliardi di euro. Qualche considerazione sull’opportunità di un’opera che difficilmente risolverebbe i problemi della Calabria è inevitabile. Guadagnare trenta minuti nell’attraversamento dello Stretto non risolverebbe alcunché. Senza voler fare del facile “benaltrismo”, è un problema l’isolamento dei comuni calabresi delle zone interne, dovuto a collegamenti scarsi e disastrati. Sono un problema le code interminabili sull’A3, le stragi della 106 ionica, le frane che impongono la chiusura di intere strade provinciali, i fatiscenti treni-lumaca. Nello specifico, è un problema l’esistenza di un duopolio che gestisce il trasporto nello Stretto sulla pelle dei pendolari, permettendosi aumenti dei prezzi frequenti e inspiegabili, senza che le legittime proteste non si rivelino soltanto un avvilente abbaiare alla Luna.
Il Ponte unirebbe Calabria e Sicilia, in un deserto di infrastrutture. L’unica utilità sarebbe quella dichiarata da Berlusconi: “se uno ha un grande amore dall’altra parte dello stretto potrà andarci anche alle quattro del mattino senza aspettare i traghetti”. Sotto il profilo dello sviluppo economico, cambierebbe poco. La Calabria deve guardare oltre la Sicilia. Occorre puntare lo sguardo ai mercati del Nord Italia e dell’Europa, per cui servono strade e ferrovie che ne riducano le distanze. Deve guardare ai Paesi del Mediterraneo. Il suo sviluppo passa necessariamente dal rilancio e dal potenziamento del Porto di Gioia Tauro (indotto e iniziative imprenditoriali che non riducano lo scalo a box per il pit stop delle navi), ora in grave crisi per l’addio della Maersk Line che ha causato una drammatica diminuzione del traffico.
La quantità di soldi spesi fino ad ora per la “realizzazione” del Ponte è da guinness dei primati: 270 milioni di euro (8,5 miliardi il costo finale previsto). Niente male per un’opera che – probabilmente – non si farà. E pensare che l’11 giugno la Società Stretto di Messina ha compiuto trent’anni. Un compleanno che rischia di diventare amaro, anche se la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2050. Il tempo (per gli sprechi) non basta mai.
Tornano Santoro, Vauro e il baffone di Ruotolo
Manca oramai pochissimo all’esordio televisivo della squadra di Santoro, fissato al 3 novembre, ore 21.00. Il giovedì di Rai Due è intanto naufragato con i pessimi ascolti di Star Academy, soppresso prima che sul palco arrivassero i pomodori. A conferma delle politiche suicide della Rai dove, pur di fare favori al premier, si sta affossando la televisione pubblica. Pare che ora si voglia puntare su Giuliano Ferrara per un Annozero di destra, nello stesso canale e nello stesso orario. Un premio per il successo di Qui Radio Londra, programma rivelatosi di nicchia e per il quale, “stranamente”, nessuno ha chiesto la chiusura, causa ascolti nettamente al di sotto delle aspettative. Si potrà seguire Servizio pubblico (titolo del nuovo programma, inizialmente Comizi d’amore) su Sky, ma anche su diverse emittenti locali, oltre che in streaming sul sito di Repubblica, Il Fatto Quotidiano e Il Corriere della Sera.
A fare pubblicità al programma, nello spot che sta girando in rete, il premier in persona.
Una bandiera di vittoria piantata sulla pancia di un morto
Sono state spese fin troppe parole su Gheddafi, sulla sua parabola politica e umana, su quelli che nel giro di pochi giorni si sono accorti che a Tripoli regnava un dittatore e sono passati da un deferente baciamano alla condanna del regime e alla guerra. Per giustificare l’imbarazzo, si è anche parlato di logiche di realpolitik, attribuendo implicitamente una statura da grande attore internazionale a chi non ce l’ha, tanto da essere di recente sbeffeggiato pubblicamente da Sarkozy e Merkel. Invece era soltanto l’albertosordismo della politica estera italiana che ogni tanto riemerge: orecchie calate con i forti, volto truce con i deboli.
La logica preponderante nei rapporti internazionali è il cinismo, il “sic transit gloria mundi” con cui Berlusconi ha liquidato l’amicizia con Gheddafi. La fine che spesso tocca in sorte ai dittatori rappresenta plasticamente i termini della questione. Sostenuti, tollerati, foraggiati, vezzeggiati fino a quando sono funzionali a interessi politici ed economici prevalenti; scaricati senza troppi scrupoli quando non servono più o diventano ingestibili. Il colpo di grazia alla testa del dittatore libico ha levato dall’imbarazzo quanti, tra i protagonisti della politica internazionale, sarebbero stati chiamati da Gheddafi a testimoniare in un regolare processo. La furia giustizialista che da più parti si è levata puzza di sospiro di sollievo per lo scampato pericolo e nasconde un intento autoassolutorio.
Ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Il tentativo della Nato di giustificare il bombardamento del convoglio sul quale viaggiava Gheddafi è goffo. Come ha sostenuto il ministro degli esteri russo, non vi era “alcun collegamento tra la no-fly zone e un attacco a un bersaglio a terra”. Infine, il rais è stato catturato in una buca, ferito ma ancora vivo, ed è stato giustiziato sul posto. C’è qualcosa di intollerabile nella caccia all’uomo, nella furia che si scatena quando la belva annusa il sangue della preda: “e gli occhi dei soldati cani arrabbiati/ con la schiuma alla bocca cacciatori di agnelli” (Sidun, Fabrizio De André).
Non è in discussione il giudizio su Gheddafi, per niente ammorbidito dalla fine tragica. Era e rimane un criminale, un aguzzino del popolo libico. Però, anche lui, aveva diritto ad un regolare processo. La giustizia sommaria è sempre una giustizia barbara, violenza che si aggiunge a violenza, in una vertigine di sangue che rievoca i versi di Ignazio Buttitta: “scippari l’occhi l’unu cu l’autru,/ scurciari l’unu cu l’autru, ammazzarinni/ e chiantari banneri di vittoria/ nte panze di morti” (Ncuntravu u Signuri).