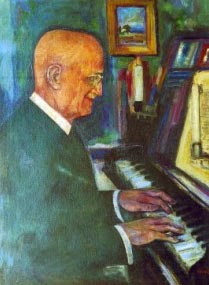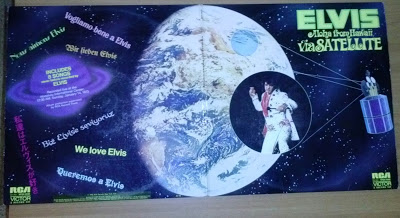L’11 novembre ricorreva il cinquantesimo anniversario del concept album di Fabrizio De André Non al denaro non all’amore né al cielo, nato dalla collaborazione con Giuseppe Bentivoglio (testi) e Nicola Piovani (musiche, arrangiamenti, direzione d’orchestra).
L’album è liberamente tratto dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters (1915), arrivata in Italia grazie a Cesare Pavese, appassionato studioso della letteratura americana che affidò il libro ricevuto dagli Stati Uniti ad una sua ex studentessa, la giovane Fernanda Pivano, che lo tradusse tra il 1937 e il 1941. Si era in pieno regime fascista, la cultura americana veniva osteggiata e la politica di italianizzazione toccava vette irraggiungibili di ridicolo: clamorosa l’imposizione del vocabolo “mescita” in luogo dell’inglese “bar”. L’esatto contrario di ciò che accade oggi con l’invasione di termini inglesi utilizzati anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Da un eccesso all’altro, verrebbe da considerare.
L’ostracismo culturale investiva il campo musicale (jazz) e quello della letteratura: la stessa Pivano pagò con qualche giorno di carcere la traduzione del libro, pubblicato dalla casa editrice Einaudi nel 1943. La questione era politica poiché la raccolta di poesie di Masters toccava temi non graditi al regime, come dichiarò anni dopo “Nanda”: «Parlava della pace, contro la guerra, contro il capitalismo, contro in generale tutta la carica del convenzionalismo. Era tutto quello che il governo non ci permetteva di pensare. Mi hanno messo in prigione e sono molto contenta di averlo fatto».
De André, che aveva scoperto Edgar Lee Masters a circa diciotto anni, rimase colpito dal fatto che «nella vita, si è costretti alla competizione, magari si è costretti a pensare il falso o a non essere sinceri, nella morte, invece, i personaggi di Spoon River si esprimono con estrema sincerità, perché non hanno più da aspettarsi niente, non hanno più niente da pensare. Così parlano come da vivi non sono mai stati capaci di fare». Anni dopo riprese il libro, scelse 9 tra le 244 poesie e le riscrisse attualizzandone le vicende. Fernanda Pivano valutò straordinaria l’operazione: «Sono contenta dei suoi cambiamenti e mi pare che lui abbia molto migliorato le poesie. Sono molto più belle quelle di Fabrizio, ci tengo a sottolinearlo».
Nelle nove tracce musicali sfila l’umanità tipica della poetica deandreiana degli ultimi: lo scemo del villaggio che non riesce a dare forma al “mondo” che custodisce nel cuore; il giudice nano che si vendica del pettegolezzo della gente condannando a morte per soddisfare il proprio sadismo; l’ateo al quale due guardie bigotte cercano l’anima a forza di botte; il malato di cuore che muore baciando la donna amata (“il mio cuore le restò sulle labbra”); il medico che cura i più miserabili senza chiedere alcuna retribuzione; il chimico che muore da solo per paura dell’amore; l’ottico che realizza lenti speciali per consentire ai suoi clienti di “inventare i mondi sui quali guardare”; l’autobiografico suonatore Jones, musicista alcolizzato il cui anarchismo ispira il titolo dell’album.
Dormono tutti sulla collina, insieme alle vittime del lavoro e ai caduti in guerra, a Bert ucciso in una rissa, ad Ella morta di aborto e alla prostituta Maggie, “uccisa in un bordello dalle carezze di un animale”. Accomunati dalla morte, la livella che ci rende uguali e fa di ogni esistenza “un corpo fra i tanti a dar fosforo all’aria”.