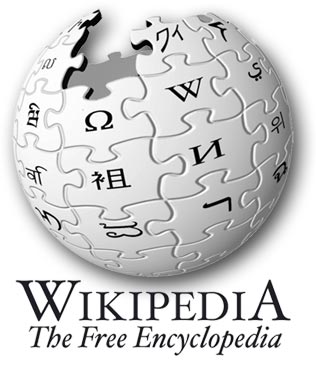Ringrazio l’emittente regionale LaC e il giornalista Agostino Pantano per il servizio giornalistico andato in onda nell’edizione del telegiornale delle ore 14.00. Naturalmente, i tempi televisivi non hanno consentito di mandare in onda l’intervista mia e di Pasquale Napoli nella loro integralità. In ogni caso, credo che la qualità del lavoro sia eccellente perché sintetizza alla perfezione il contenuto di quanto da noi dichiarato e i termini della questione: lo stato disastroso del tratto della Strada Provinciale 2 che collega Sant’Eufemia all’ex svincolo autostradale, pericoloso anche per l’incolumità fisica di chi la percorre; l’abbandono del nostro territorio da parte di Anas e della Città Metropolitana; la doppia beffa della popolazione di quest’area che si è vista sottrarre lo svincolo e attende invano i lavori di compensazione/risarcimento che erano stati promessi per mettere un po’ a tacere una protesta sacrosanta.
La realtà è sotto gli occhi di tutti ed ha le caratteristiche di un percorso molto accidentato per via delle innumerevoli buche presenti sul manto stradale. Buche che provocano danni ai veicoli in transito oltre a creare situazioni di pericolo per gli automobilisti che, cercando di scansarne qualcuna, rischiano di sbattere contro chi procede dal senso opposto di marcia. Tutta questa situazione si aggrava con la presenza di una fitta nebbia che spesso quasi azzera la visibilità di un percorso scarsamente illuminato (laddove ci sono lampioni, funzionano a giorni alterni nella migliore delle ipotesi) e dalle strisce stradali impercettibili, se non assenti.
Si tratta di una strada utilizzata quotidianamente da centinaia e centinaia di automobilisti per lavoro o per altre esigenze, che rendono necessario raggiungere l’autostrada alla popolazione dell’intero comprensorio. Va inoltre evidenziato che più volte nel corso di una giornata essa viene percorsa dall’autoambulanza del 118, che a Sant’Eufemia ha la sua postazione: per chi deve salvare una vita non è proprio il massimo lavorare in queste condizioni. Senza dimenticare, infine, i molti ciclisti amatoriali provenienti da tutta la provincia per i quali è impossibile pedalare a bordo strada e che sono costretti a pericolosissime gimkane tra le buche.
È necessario un intervento straordinario, che peraltro era stato promesso. E poi bisogna intervenire con regolarità per eseguire quei lavori di manutenzione ordinaria che impediscano il periodico riproporsi di tali situazioni di emergenza.
Tipi da Facebook
Si legge poco e si naviga molto, è un dato incontestabile. Il rapporto Censis del 2016 è per certi versi impietoso: a dispetto dell’alta percentuale di laureati, i “lettori forti” (più di 12 libri in un anno) sono solo il 13,7%. Sono cambiati i canali di informazione, come conferma il crollo dei lettori di quotidiani tra 2007 e 2016 (-26,5%). Dopo il telegiornale (63%), è Facebook la principale fonte d’informazione per gli italiani (35,5%): più indietro i giornali radio (24,7%) e, appunto, i quotidiani (18,8%), superati anche dai motori di ricerca (19,4%), poi a seguire troviamo YouTube (10,8%) e Twitter (2,9%). Facebook è uno strumento pratico per la rapidità della ricerca degli articoli che siti o contatti personali condividono: notizie di cronaca, post di approfondimento, comunicati stampa, eventi. Nonostante il conflitto non ancora risolto tra news e fake news, tra informazione e disinformazione, il social di Zuckerberg da questo punto di vista è utile. Ciò ha però prodotto anche una sorta di mutazione “antropologica”: senza scomodare Umberto Eco, è innegabile che l’utilizzo dei social da parte di molti utenti non sempre risponde allo scopo di informarsi, mantenere/riallacciare rapporti con amici e parenti lontani (una benedizione), condividere con gli altri momenti importanti della propria vita: avvenimenti, “successi” (una pompatina al proprio ego fa sempre bene, inutile negarlo), dolore e dispiaceri (ma qua si potrebbe aprire una parentesi infinita su tempi e modalità, riservatezza e pubblicità di sentimenti intimi e personali). Eh, no: “oltre”, c’è tutto un mondo da studiare. Un compito che esula dalle mie capacità, per cui mi limiterò soltanto a tracciare un breve profilo dei “tipi” che più mi fanno divertire, ma anche riflettere: mi incuriosisce cercare di comprendere certi meccanismi mentali, anche se spesso non resta altro da fare che alzare le braccia e sorridere. Ma procediamo con ordine.
L’ALLUSIVO – Non è mai diretto, ma è come se lo fosse. In una comunità virtuale nella quale tutti conoscono tutti, non è complicato intuire il destinatario di una frecciatina. Però l’allusione aggiunge un tocco di sottigliezza alla volgarità dell’attacco frontale e in più, particolare da non sottovalutare, consente di raccogliere qualche consenso in più perché offre al potenziale sostenitore la possibilità di salvarsi in calcio d’angolo: «Sì, ho messo mi piace e ho commentato quello stato, ma non credevo fosse riferito a te».
IL CATASTROFISTA – Svolge una funzione sociale. Terremoti, alluvioni, frane, cicloni, cadute di asteroidi sulla Terra ed estinzione dei ghiacciai sono il suo pane quotidiano. Se c’è una sola nuvola nel cielo, state tranquilli. Siete in una botte di ferro. Lui ne seguirà l’evoluzione fino a quando potrà finalmente mettervi in guardia: «Restate tappati in casa!».
L’EPURATORE – Ha un’attività ciclica, che si manifesta puntuale come il disco di Mina a Natale. I suoi ultimatum nascondono una propensione palingenetica volta alla realizzazione della “soluzione finale” contro vagabondi e parassiti del web. Che sarebbero tutti quelli che non interagiscono con lui commentando o “mipiaciando”. Inaccettabile, per cui: «Raus! Presto farò un po’ di pulizia tra i miei contatti!».
IL MALATO – Di lui sappiamo se ha il termometro a mercurio o quello elettronico, le medicine che prende, i dolori di testa insopportabili, eventuali cadute o indigestioni. Più che un profilo Facebook quello che abbiamo davanti è un foglio di anamnesi. D’altronde, il filosofo contemporaneo Peppe Voltarelli ha ragione quando sostiene che il lamento è una forma di godimento. Il top però viene raggiunto con la “registrazione” presso un ospedale, senza ulteriori informazioni. La solidarietà così obliquamente cercata in quel caso “deve” scattare immediata: «Che ti è successo?».
IL QUESTUANTE – Si muove nella penombra della messaggistica privata, dove solo tu puoi vederlo. Arriva con passo felpato quando meno te l’aspetti, anche se in genere preferisce essere il tuo buongiorno con una richiesta che – santiddio – non dovrebbe costarti niente esaudire: «Lo metteresti un “mi piace” allo stato che ho appena pubblicato?».
LO SGAMATORE – Aggiorna raramente il suo stato e ancor meno interagisce con i suoi contatti, dei quali però conosce vita, morte e miracoli “virtuali”. In pratica utilizza Facebook esclusivamente per tenere sotto controllo gli amici, ai quali ogni tanto rivela le sue sensazionali doti da Sherlock Holmes facendo l’occhiolino e sussurrando all’orecchio: «Sei andato al mare a Scilla, eh?».
IL SORVEGLIATO – È un perseguitato. Spiato in tutto quello che fa: pubblica uno stato e i suoi contatti, pensate un po’, lo leggono. Kgb, Cia, Mossad e Stasi gli stanno sempre col fiato sul collo per carpire informazioni che verranno poi decodificate da un cervellone centrale. Nel frattempo, i suoi stati sono passati al setaccio dai suoi contatti, che – sicuro – li commentano privatamente, nei bar, dal fruttivendolo o dal parrucchiere. Ma lui non teme nessuno: quello che deve dire, lo dirà.
IL TAGGATORE – Pubblica qualcosa e ti “tagga”, magari insieme ad altre venti persone ignare come te. Perché in quel momento tu non sei con lui! Passi per un articolo o un evento che può interessarti, per la condivisione di uno stato d’animo comune, ma il tag in una foto mentre sorseggia l’aperitivo è decisamente troppo: non te lo metto il “mi piace”, tirchio.
IL TATTICO – Il suo “mi piace” è sempre calcolato, mai messo a caso. Una forma di captatio benevolentiae per dimostrare interesse/simpatia e, nello stesso tempo, sperare di suscitarne in virtù della legge non scritta sul contraccambio della cortesia. Vive costantemente in bilico tra l’ansia di farsi vedere e la paura di esporsi troppo. In fondo, lui è un trapezista dei sentimenti.
Aylan e noi
Mio nipote ha quasi tre anni. L’età di Aylan accarezzato dall’onda sulla battigia. La stessa t-shirt, gli stessi pantaloni “a pinocchietto”, le stesse scarpette da tennis. Spesso si addormenta sul divano a faccia in giù, proprio come Aylan nella fotografia che ha fatto il giro del mondo, con le braccia lungo i fianchi e i palmi delle mani rivolti verso l’alto.
A differenza di mio nipote e di tanti altri suoi coetanei, Aylan non sta però dormendo. Quanti ce ne sono come lui nel mondo? Bambini che dovrebbero avere l’età del gioco, non quella della fuga disperata dalla guerra. Di quanti Aylan non sappiamo niente, fino a quando il dolore non ci viene sbattuto in faccia, con una violenza che ci lascia senza fiato, sgomenti? Infine, era necessario diffondere quella immagine?
Giro attorno a questo interrogativo dal momento in cui la fotografia ha avuto diffusione nel web ed è finita sui giornali, nella versione più cruda o in quella pietosa che ritrae il corpo senza vita di Aylan in braccio a un poliziotto turco. Come in una moderna Deposizione, ha fatto notare Adriano Sofri.
Non ho la risposta. Ascolto. Leggo riflessioni legittime. Tutte: quelle a favore della pubblicazione della tragedia angosciante di un bimbo che affonda il viso nell’acqua, così come quelle contrarie. E non so cos’è giusto. Non so dove tracciare il confine tra diritto di cronaca e spettacolarizzazione del dolore.
È pur vero che oggi esiste soltanto ciò che si vede, per cui i fotogrammi della morte e dell’orrore possono rivelarsi utili per scuotere coscienze intorpidite, che non riescono a percepire la dimensione biblica del dramma delle guerre e dell’esodo di migliaia e migliaia di essere umani. Essere umani – purtroppo occorre sottolineare anche questo, in tempi di strumentale e becero razzismo – che in assenza di immagini vengono percepiti come i numeri di una fredda contabilità, non come fratelli disperati da soccorrere.
La famiglia di Aylan scappava da Kobane, città curdo-siriana simbolo della resistenza contro la violenza distruttrice delle milizie dell’Isis. Marito, moglie e due figli che speravano di raggiungere la Grecia e da lì prendere il volo per il Canada, dove la sorella parrucchiera del padre di Aylan era riuscita a farsi rilasciare i visti per i quattro congiunti. A Kobane, ha assicurato il padre di Aylan, saranno seppelliti la moglie Rehan e i due figli, Aylan e Galip, cinque anni, morti con altre otto persone in seguito al ribaltamento dell’imbarcazione che avrebbe dovuto trasportare i profughi dalla Turchia all’isola greca di Kos.
La fotoreporter Nilufer Demir ha rivelato al “Corriere della Sera” la ragione di quegli scatti: «Ho subito capito che era morto. Non c’era nient’altro da fare. Era l’unico modo per far sentire l’urlo di quel corpo». Aylan come Kim Phúc, la bimba che con la sua corsa verso il teleobiettivo, nuda e bruciata dal napalm, assurge a denuncia degli orrori della guerra del Vietnam. O come Tsvi Nussbaum, il bimbo polacco con berretto, cappotto e pantaloni corti, a braccia alzate durante il rastrellamento del ghetto di Varsavia, emblema della tragedia dell’Olocausto.
Non so schierarmi. Perché è vero che siamo talmente assuefatti che l’immagine rischia di essere fine a se stessa, di alimentare il circo mediatico del dolore e di calpestare dignità e pietà, deontologia e buon senso, nella squallida gara per la conquista di qualche “like” in più. Ma forse è anche vero che soltanto la visione dell’orrore riesce a destarci dal torpore e può fare comprendere alla comunità internazionale la gravità delle emergenze umanitarie di alcuni Paesi flagellati da guerre e fame, convincere Stati nazionali e sovranazionali della necessità di un cambio di registro in tema di politiche di accoglienza e gestione di flussi migratori divenuti ormai inarrestabili.
Umberto Eco e gli imbecilli del web
Ho assistito, ovviamente sui social media, alla polemica suscitata dalle parole di Umberto Eco a proposito degli effetti negativi di un certo utilizzo dei social stessi. Ho condiviso il suo pensiero, che credo abbia espresso in maniera volutamente provocatoria. Talmente provocatoria che tutti i siti d’informazione ci hanno dopo fatto il titolo: “Con i social parola a legioni di imbecilli” (La Stampa, versione digitale). La polemica, a ben vedere, è nata proprio sui titoli: assist formidabili per calarsi l’elmetto in testa e partire all’attacco dell’intellettuale spocchioso, arrogante e pieno di sé, che giudica la plebaglia incolta dall’alto della sua cattedra e delle sue innumerevoli lauree honoris causa, moderno marchese del Grillo in ermellino: “io so’ io e voi non siete un cazzo”.
Se in generale si riuscisse ad andare più in profondità, nel caso della lettura di un pezzo giornalistico a scorrere con gli occhi un paio di righe sotto i titoli dell’articolo o del suo “lancio” sul web, si scoprirebbe che spesso il pensiero è più articolato della sua sintesi, più complesso dell’esca che incoraggia gli internauti a cliccare sulla notizia. Una categoria nella quale abbondano i “pigri”, coloro che neanche aprono il link per collegarsi alla notizia e finiscono così per confondere l’iperbole con la realtà.
Tornando a Umberto Eco, il resoconto del suo intervento nell’articolo pubblicato dal giornale torinese dice altro, e precisamente che l’illustre semiologo invita i giornali “a filtrare con un’equipe di specialisti le informazioni di internet perché nessuno è in grado di capire oggi se un sito sia attendibile o meno. I giornali dovrebbero dedicare almeno due pagine all’analisi critica dei siti, così come i professori dovrebbero insegnare ai ragazzi a utilizzare i siti per fare i temi. Saper copiare è una virtù ma bisogna paragonare le informazioni per capire se sono attendibili o meno”.
Nell’epoca delle rivelazioni “sensazionali” sui “danni” provocati da quel vaccino o sulla “pericolosità” di determinati alimenti, del “nessun giornale ve lo racconta” e del terrorismo mediatico che alimenta psicosi collettive, il richiamo di Eco a un maggiore rigore nella selezione delle informazioni che galleggiano nell’oceano di internet andrebbe invece accolto come espressione di buon senso. Altro che spocchia.
Piccole faide giornalistiche
I fatti sono ormai noti. Il grugnito di Calderoli, che dà dell’orango al ministro per l’Integrazione Cecile Kyenge, in seguito derubricato dall’esponente leghista a battuta da comizio, frasario indispensabile per sintonizzarsi con la pancia del proprio elettorato, ma da inquadrare “in un ben più articolato e politico intervento di critica” alla politica del governo sul tema dell’immigrazione e dei diritti degli immigrati.
La sollevazione del mondo politico, con la richiesta di dimissioni dalla carica di vicepresidente del Senato avanzata dallo stesso premier Enrico Letta.
La reazione della società civile, con la petizione per chiedere le dimissioni di Calderoli lanciata da Stefano Corradino e Beppe Giulietti di Articolo 21 su change.org, che in pochi giorni è già stata sottoscritta da 172.000 sostenitori.
Nulla di nuovo, verrebbe da dire. Ognuno fa il suo gioco.
Compresi i giornalisti.
La violenza delle randellate scagliate contro Lidia Ravera da Luca Mastrantonio sul “Corriere della Sera” non l’ho capita, ad esempio. Vabbè che si vive anche di urla, ma ripescare un articolo di quasi nove anni fa per proporre un’inverosimile analogia tra l’attuale assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Lazio e l’ex ministro leghista a me è sembrato scorretto e abnorme. Oltre che falso nel merito.
Cosa sostiene infatti Mastrantonio? Che nel 2004 Ravera avrebbe paragonato a una scimmia Condoleezza Rice, sottosegretario di Stato nella seconda amministrazione Bush jr.
Se però si va a leggere l’articolo in questione, come invita a fare la scrittrice assurta alla notorietà con lo pseudonimo “Antonia”, coautrice insieme a Marco Lombardo Radice (“Rocco”) del libro cult Porci con le ali (1976), la forzatura interpretativa salta immediatamente agli occhi. Si concordi o meno con il tono molto aspro della critica all’esultanza delle femministe italiane per l’incarico affidato alla Rice (il tema era questo), di razzismo – a mio avviso – è difficile trovarne.
Lidia Ravera denuncia in sostanza la “manipolazione” e la “strumentalizzazione” operate da Mastrantonio grazie all’affiancamento delle “due paroline magiche” (donna e scimmia, quando invece la giornalista si riferiva a una donna che “scimmiotta”).
Alla replica di Ravera sul “Corriere”, Mastrantonio ha controreplicato: “Ammettere che la metafora, per lei lapalissiana, possa suonare anche ignobile avrebbe reso più credibile la sua denuncia di quanto ignobile sia l’uscita di Calderoli”. Un artificio antico e diffuso un po’ ovunque quello di riservarsi l’ultima parola.
Questi gli ingredienti della polemica, che è paradigmatica di un certo modo di fare giornalismo.
Non so a voi, ma a me l’intervento di Mastrantonio è sembrato un’entrata a gamba tesa con pallone lontano dal gioco.
Polito e il calo dei matrimoni
Ho letto la riflessione domenicale di Antonio Polito sulla prima pagina del Corriere della Sera: “Quelle leggi antimatrimonio”.
Una panoramica a trecentosessanta gradi sulle ragioni del calo inarrestabile dei matrimoni in Italia: quarantamila in meno negli ultimi tre anni. Uno pensa: la crisi economica. Macché. Quello è l’ultimo dei problemi per l’ex direttore de Il Riformista, che infatti neanche la inserisce tra le cause del declino dell’istituto matrimoniale.
Il motivo principale andrebbe invece ricercato nella selva legislativa della materia, “una pletora di leggi e regolamenti che in Italia disincentivano a sposarsi”. Un esempio? La recente circolare dell’Università di Genova che, estendendo le norme della legge Gelmini contro il nepotismo dei baroni, proibisce l’assunzione di docenti sposati con colleghi che già lavorano nell’ateneo della città della Lanterna. Tra le invettive scagliate contro la riforma Gelmini quella del giornalista campano, seppure “indiretta”, è la più singolare. Non ci aveva pensato proprio nessuno, bisogna ammetterlo.
Un caso di scuola, prosegue Polito, riguarda invece la regolamentazione delle assunzioni in Rai. Benedetto figliolo, è notorio che la Rai è ormai il bancomat di mogli, figlie, amanti di politici e vip di turno (collaborazioni, consulenze e chi più ne ha più ne metta). Per dire: per anni gli italiani hanno stipendiato il compagno di Antonella Clerici, un animatore di villaggi turistici diventato improvvisamente autore dei programmi della procace conduttrice televisiva, sparito l’indomani della fine della storia d’amore tra i due. E sarebbe sufficiente leggere le firme dei servizi dei telegiornali e dei membri delle redazioni giornalistiche (un velo pietoso sulla carta stampata), per farsi una semplicissima domanda (“sarà figlio/a di?”) e dedicare una sonora pernacchia a Polito.
Ma forse siamo noi accecati dalla furia anticasta e inebriati dal grillismo più sfrenato, mentre quello di Polito è un ragionamento ineccepibile, che scoperchia l’ingiustizia di norme discriminatorie e inaccettabili per qualsiasi paese civile. Se lo tolgano dunque dalla testa i 12 milioni di italiani conteggiati dall’editorialista del Corriere che vivono “al di fuori della famiglia tradizionale”: è vano sperare di regolarizzare la propria situazione sentimentale, pena la rinuncia alla cattedra universitaria o alla scrivania di un tg nazionale. Notoriamente, il sogno di tutti gli italiani.
Senza contare, incalza un incontenibile Polito, tutti quei furbastri ottuagenari che non si risposano per non perdere l’uso della casa o per non dovere rinunciare all’assegno di reversibilità della pensione del defunto coniuge. Anche se qua è più indulgente, concedendo e concludendo che l’istituto giuridico del matrimonio è diventato “troppo rigido per una società tanto flessibile”.
Sulla crisi economica, sulla precarizzazione del lavoro e sulla disoccupazione giovanile, sul disastro dell’edilizia sociale neanche un accenno. Coppie di giovani senza un lavoro dignitoso, senza un alloggio, senza la speranza di un futuro migliore e per Polito sembra che il problema sia la riforma Gelmini. Troppi salotti televisivi e poca strada. La sindrome dello scollamento dalla realtà evidentemente è una patologia che non colpisce soltanto i politici.
Il giornalismo copia-incolla
Sostengo da tempo che tutti i giornali locali dovrebbero fare uno sforzo economico per assumere in redazione un giornalista che si occupi esclusivamente della supervisione dei contributi di giornalisti e collaboratori vari. Figura professionale che tra l’altro esiste e la cui importanza nell’economia di un giornale non va assolutamente sminuita. Sono innumerevoli i casi di giornalisti famosi che hanno iniziato come correttori di bozze. Partendo dal gradino più basso, Eugenio Balzan arrivò addirittura alla direzione amministrativa e alla comproprietà del “Corriere della Sera”, negli anni in cui il giornale di via Solferino era diretto da Luigi Albertini.
Ciò eviterebbe lo spettacolo che si presenta agli occhi dei lettori con la pubblicazione di strafalcioni ortografici e sintattici raccapriccianti e, francamente, inammissibili. Se poi il correttore di bozze fosse anche un discreto lettore di libri (dotato di un minimo di cultura generale) e un fruitore attento alle dinamiche e alle modalità della comunicazione sul web, il giornale farebbe bingo.
Quanto meno non incapperebbe nella figuraccia occorsa a Calabria Ora. Il giornale diretto da Piero Sansonetti, nell’edizione di oggi, ha infatti dedicato uno speciale di tre pagine (I Quaderni di Calabria Ora) ai novant’anni della “marcia su Roma”. A pagina 14, Quel che resta a 90 anni da quella marcia, articolo di Giuseppe Cantarano. A pagina 15, due interviste: la prima, di Marco Cribari, al presidente de “La Destra” Francesco Storace (“Negarla? È antistorico”); la seconda, di Camillo Giuliani, allo storico Giovanni De Luna (Fu vera rivolta solo nel ’25). Il capolavoro (si fa per dire) è però a pagina 16, interamente riservata alla ricostruzione della “marcia” (La capitale sotto tiro). Insospettito dalla mancanza della firma dell’autore in calce all’articolo, ho voluto prendermi la briga di fare una veloce verifica. Come sospettavo, l’articolo è tagliato/ copiato/ incollato dalla voce “marcia su Roma” presente su Wikipedia, “l’enciclopedia libera e collaborativa”, redatta sostanzialmente dagli internauti e cliccatissima sul web. Pezzi interi sono copiati e incollati, altri modificati soltanto nel raccordo tra un taglio e l’altro (l’articolo online è infatti più lungo di quello del quotidiano calabrese).
La deontologia, in questi casi, prevede la citazione della fonte e il virgolettato, ma per ragioni facilmente intuibili non “fa figo” citare Wikipedia, molto utilizzata (ahinoi) dagli studenti per le loro ricerche, ma sulla cui autorevolezza è bene non mettere la mano sul fuoco.
Il giornalismo copia-incolla è la metafora di un’epoca che ha messo sull’altare l’approssimazione, la superficialità e la strafottenza. Tempi tristi.
Epic Fail
Nel linguaggio dei social network, con Epic Fail (fallimento epico) s’intende un enorme sbaglio (qualcosa di simile a una figuraccia), immortalato in un video o in una foto. Ad esempio, certe scritte sgrammaticate che si leggono sui muri delle città.
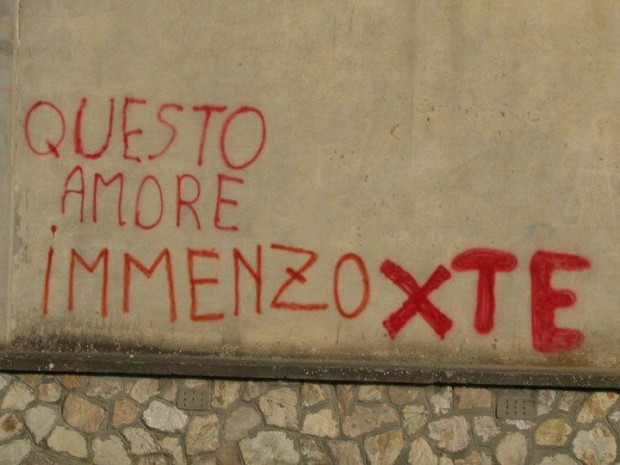
O immagini buffe, incredibili, che suscitano istintivamente una fragorosa risata.
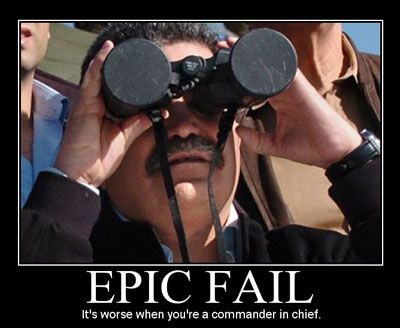
Qualcosa di simile è capitato con il post che ho pubblicato stamattina per rispondere a un fantomatico Rocco Cutrì. “Fantomatico” non perché Rocco non esista, ma perché non è lui l’autore del commento all’articolo Strettamente personale che aveva provocato la mia reazione.
Negli ultimi tempi sul blog registro, con maggiore frequenza rispetto al passato, incursioni incresciose. Per questo sono stato costretto a inserire la funzione “moderazione” nei commenti, che non pubblico se contengono attacchi o offese anonime nei confronti di chicchessia. In questa circostanza, sono stato tratto in inganno dal fatto che l’intervento era sottoscritto con nome e cognome, anche se per tutta la giornata di ieri ho avuto il dubbio che si trattasse di un troll (chi, su internet, pubblica messaggi provocatori).
Conosco Rocco, al quale ho pure avuto modo di esprimere (qui) il mio apprezzamento, ai tempi della sua esperienza amministrativa, e proprio per questo ero rimasto sorpreso e amareggiato. Purtroppo, non sono però riuscito a rintracciarlo, prima di postare l’articolo, per accertare al cento per cento che quelle parole fossero davvero roba sua. Errore da matita blu: mea culpa.
Ne hanno fatto le spese, involontariamente, anche Nino Creazzo e Carmen, intervenuti in mia difesa con parole abbastanza pesanti. Mea culpa, anche nei loro confronti.
Ho eliminato dal blog il post che avevo scritto stamattina e i commenti che hanno suscitato questo vespaio, a partire, ovviamente, da quello inviato dal simpatico usurpatore.
Nella foto sotto, eccomi nel momento in cui scopro di essere stato “trollato”, un attimo prima di sbattere contro la verità (è quella cosa di ferro orizzontale).

Siamo tutti Sallusti, ma anche no
Sul caso Sallusti, il direttore del “Giornale” condannato a 14 mesi di reclusione per un articolo fatto pubblicare nel 2007, quando dirigeva “Libero”, è stato detto tutto. Nel considerare il carcere una pena eccessiva, arrivo quindi buon ultimo. Concordo anche – e questo, seriamente, mi preoccupa – con Vittorio Feltri, quando dice che il giudice non ha alcuna colpa, poiché si è limitato ad applicare la legge: “se tu – il succo del suo ragionamento – gli metti in mano armi che vanno dal temperino al mitra e quello usa il mitra, bisogna prendersela con il legislatore che gli ha messo il mitra in mano, non con il magistrato che l’ha usato”.
La legge in questione, retaggio del codice Rocco, è sopravvissuta alla caduta del fascismo (immagino) perché, in fondo, al potere fa comodo anche soltanto adombrare la possibilità che si possa finire in galera per ciò che si pensa. Per cui, bisognerebbe cambiare la legge e stabilire che i reati a mezzo stampa sono perseguibili solo per via civile. Su questo, siamo (o dovremmo essere) tutti d’accordo.
Detto questo, si impone qualche precisazione. La prima, e sostanziale: confondere fatti e opinioni o fare di Sallusti un eroe risponde alla solita, insopportabile, logica strumentale cui tutto, in Italia, si riduce. Una cagnara utile per nascondere ciò che Alessandro Robecchi ha definito “un giornalismo sciatto, fatto male, truffaldino, che dà notizie false per sostenere una sua tesi”. Sì, perché il reato d’opinione, nel caso di Sallusti, non c’entra per niente: c’entra invece, il fatto che è reato “scrivere e stampare notizie false”, cioè diffamare. C’entra anche, per esempio, il dettaglio che un direttore responsabile, lo dice la parola stessa, è “responsabile” di ciò che viene pubblicato sul giornale che dirige, altrimenti qualcuno mi spieghi quale sia la sua funzione. C’entra, inoltre, con un principio etico elementare: quello di proibire che sia data ospitalità e offerta una tribuna a un giornalista radiato dall’Ordine (Renato Farina, deputato Pdl, già agente “Betulla”). E poi fare anche finta di non conoscere l’identità dell’autore dell’articolo incriminato: diversamente si incappa, come è successo al direttore del “Giornale”, anche nel reato di “omessa denuncia”. Che con la libertà d’opinione, è evidente, non ha alcuna relazione.
Non apprezzo Sallusti (eufemismo). Trovo odioso il suo modo di fare giornalismo, ammesso che sia giornalismo la faziosità e la distorsione della verità per fare l’interesse politico del proprio editore. Ritengo però che una pesantissima multa (superiore ai 5.000 euro di multa del primo grado di giudizio) e la radiazione dalla professione, per i giornalisti che facciano strame della deontologia, possa essere una pena congrua. Una soluzione che, tra l’altro, ci risparmierebbe il rischio di ritrovarci con un improponibile martire della libertà di stampa. In definitiva, è la pena che è ingiusta, perché non c’è proporzione tra reato e condanna, non la condanna in sé.
No al carcere, dunque. Certo. Ma #siamotuttiSallusti (l’hashtag che sta girando su twitter), no. Anche impegnandomi, turandomi qualsiasi cosa, non ce la potrei mai fare.
Per qualche copia in più
Non mi piace il giornalismo urlato. Non mi piacciono i titoloni sparati in prima pagina per vendere qualche copia in più. Lo stile de “Il Giornale” o di “Libero”, tanto per fare due esempi (non) a caso. Da un po’ di tempo, “Calabria Ora” sembra avere sposato il belpietrismo. L’ultimo cavallo di battaglia di Sansonetti è la difesa del Sud dagli stereotipi nordisti che dipingono, da Napoli in giù, una terra irredimibile. Territori in mano alla criminalità organizzata, popolazioni che attendono a bocca aperta la mammella dello Stato, barbari che fanno dell’abusivismo edilizio la regola e della difesa delle bellezze naturali e paesaggistiche l’eccezione. Oddio, i reportage di ispirazione quasi lombrosiana sono intollerabili, ma non credo che certe repliche siano un bene per il Sud. Di sicuro, non lo sono per il giornalismo.
Prendiamo la lunga e bella intervista di Alessia Principe a Paolo Villaggio, in tournée con il suo spettacolo teatrale. Foto centrale dell’attore genovese e un’apertura che istintivamente suscita un moto d’antipatia: “Il Sud? Un posto tremendo”. Ed è quel “posto tremendo”, decontestualizzato dal resto del colloquio (morte, storia della cristianità, omosessualità, Fantozzi, Angelo Rizzoli, Fabrizio De Andrè e Silvio Berlusconi) che ispira anche il titolo delle due pagine centrali del giornale: “Fantozzi story. Il Sud? è una cagata pazzesca”. Adattamento in chiave meridionalista dell’urlo liberatorio di Fantozzi nel dibattito al cineforum sulla “Corazzata Potemkin”. Quel “posto tremendo” diventa anche il calamaio nel quale il direttore di “Calabria Ora” intinge il pennino per argomentare (“Scusa, caro maestro, il Sud è un’altra cosa”) che “il degrado” del Sud “è il risultato della sopraffazione” del Nord sul Meridione e concludere, amaro e beffardo: “vede Villaggio, detto con affetto, la sua idea del Sud è un po’ una cagata”. Opinione legittima, per carità. Se però si va a leggere il passaggio incriminato, i conti non tornano. O tornano di meno. Virgolettato dell’intervista: “Il Sud è terribile. Ed è spaventoso come la cultura del voto di scambio, alimentata in tutti questi anni, lo abbia rovinato in questo modo. Come avete fatto? – pausa. Ma non abbassa lo sguardo. Ha le mani raccolte. Me lo chiede davvero. Lo vuole sapere. – La corruzione è cresciuta indisturbata. Mi è bastato vedere, appena arrivato in Calabria, il vostro litorale rovinato da costruzioni abbandonate, decadenti, obbrobriose. Ma perché… Perché?”.

Niente di eclatante e neanche di originale, ad essere sinceri. Considerazioni arcinote, che si leggono quotidianamente sulla stampa locale. Dunque, siamo alle solite: soltanto i calabresi possono muovere critiche ai calabresi. Quelle di un “forestiero” sono pregiudizi intollerabili. Certo, l’attacco a una celebrità è sempre un ottimo strumento per guadagnare visibilità, un’occasione da prendere al volo, anche a costo di qualche forzatura interpretativa. Oltretutto, in questi giorni, Paolo Villaggio è finito nell’occhio del ciclone per una dichiarazione infelice sulle paralimpiadi: “sono tristi” e “non fanno ridere”. Come se lo scopo delle paralimpiadi sia fare ridere qualcuno. Ecco, la richiesta di una precisazione su queste ben più gravi frasi non sarebbe dispiaciuta. E forse avrebbe consentito a “Calabria Ora” di fare un titolo più bello.