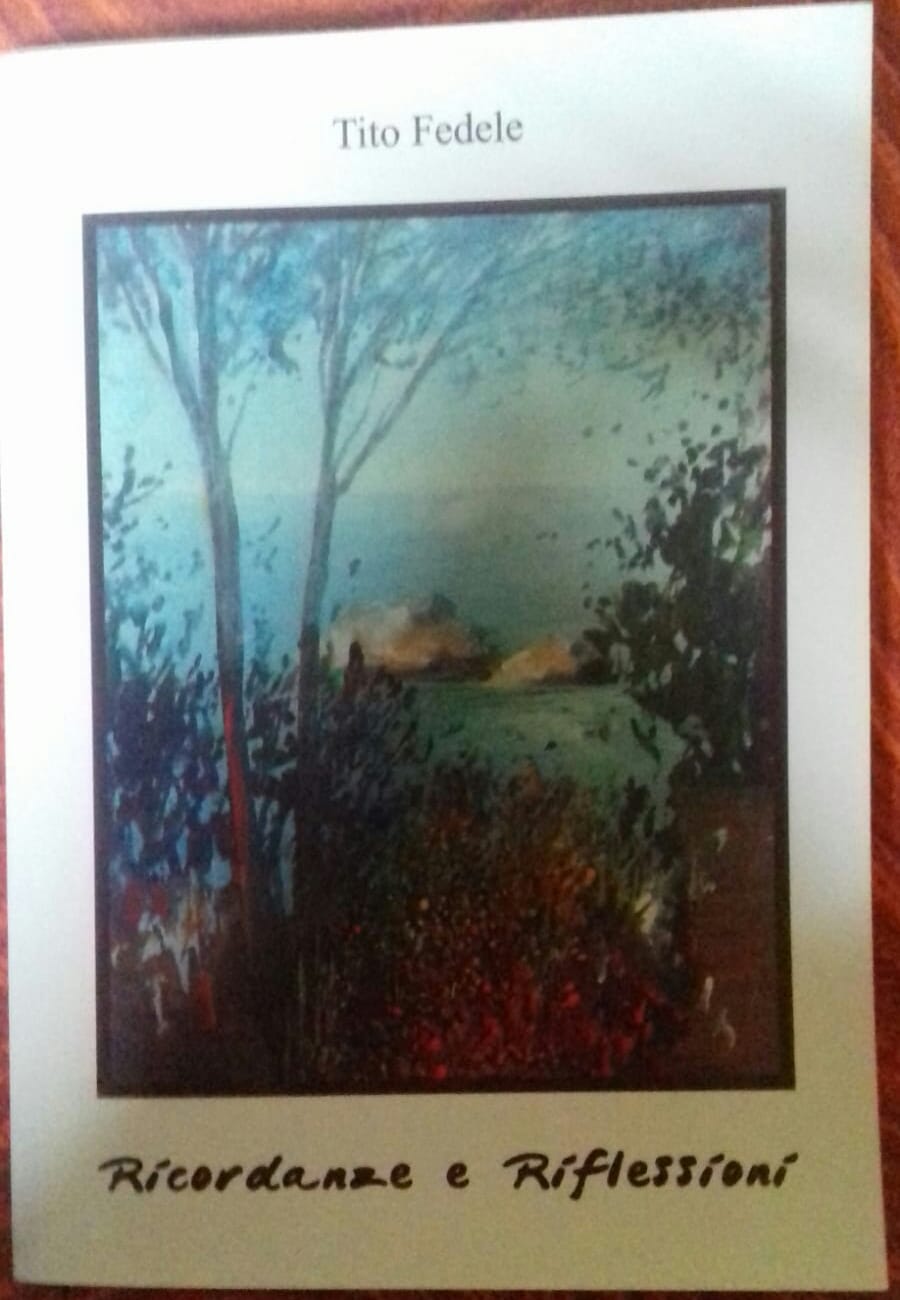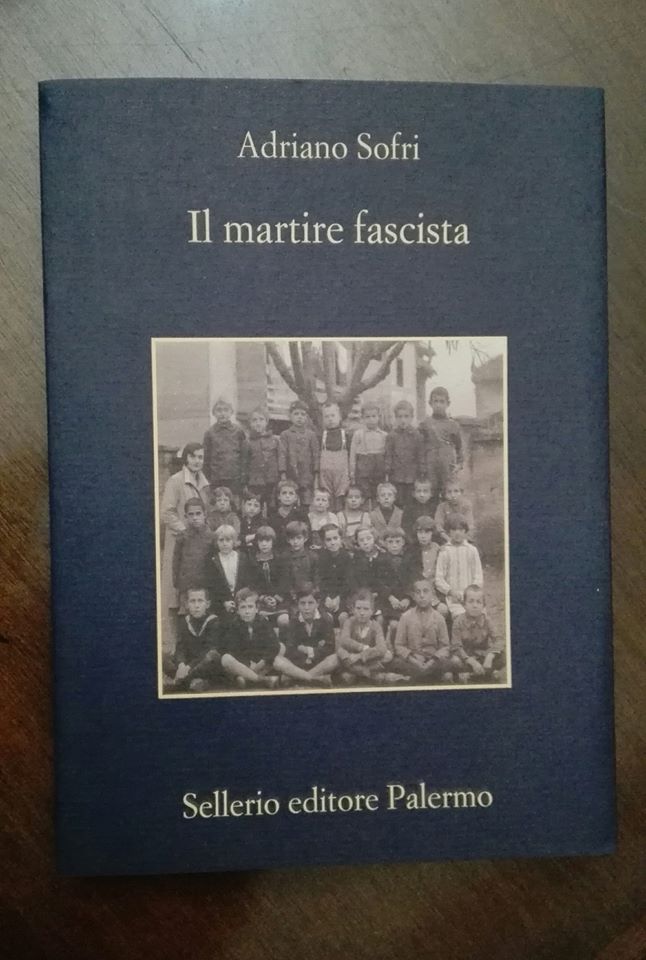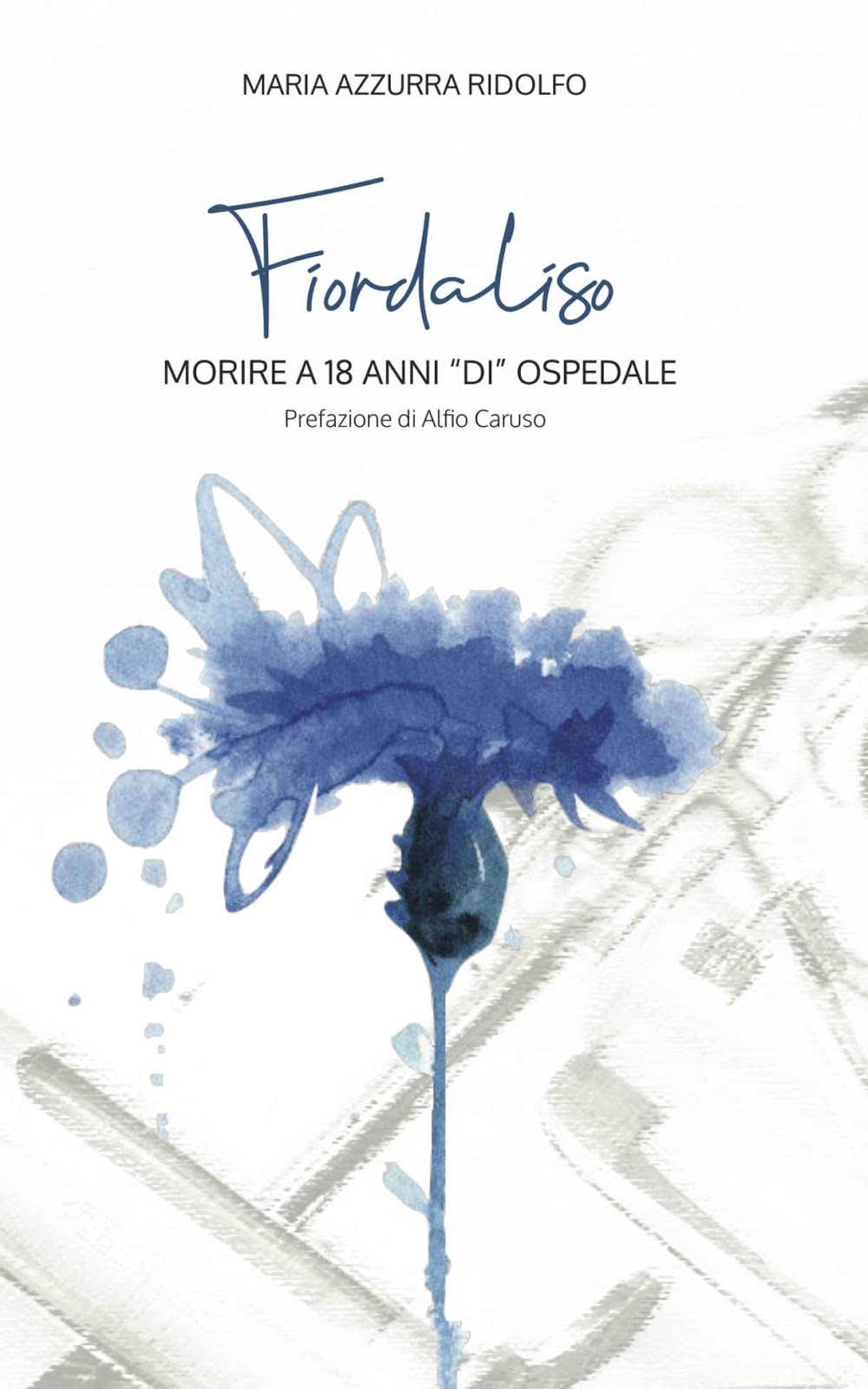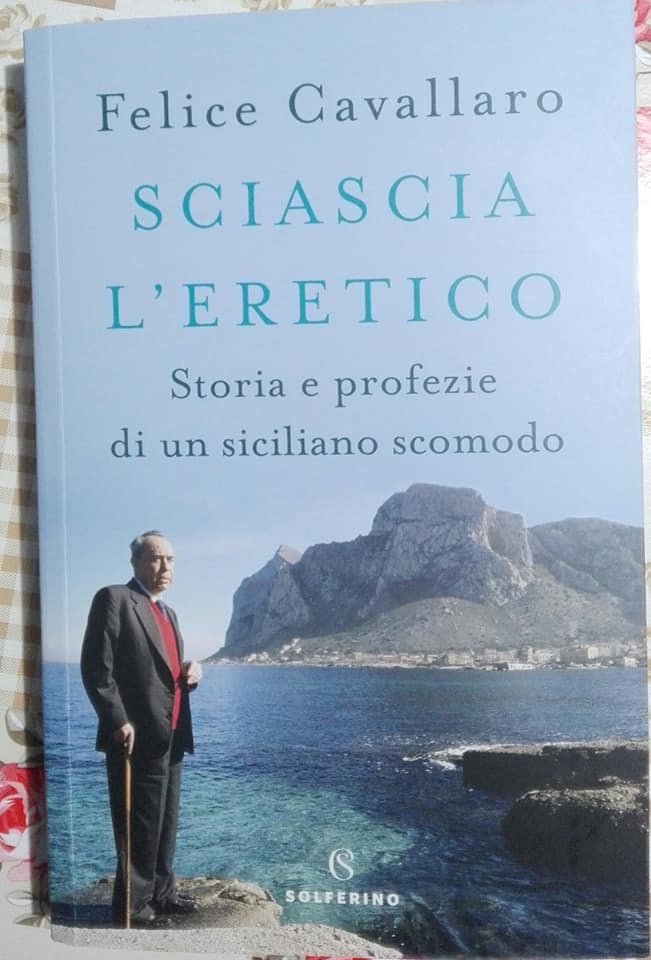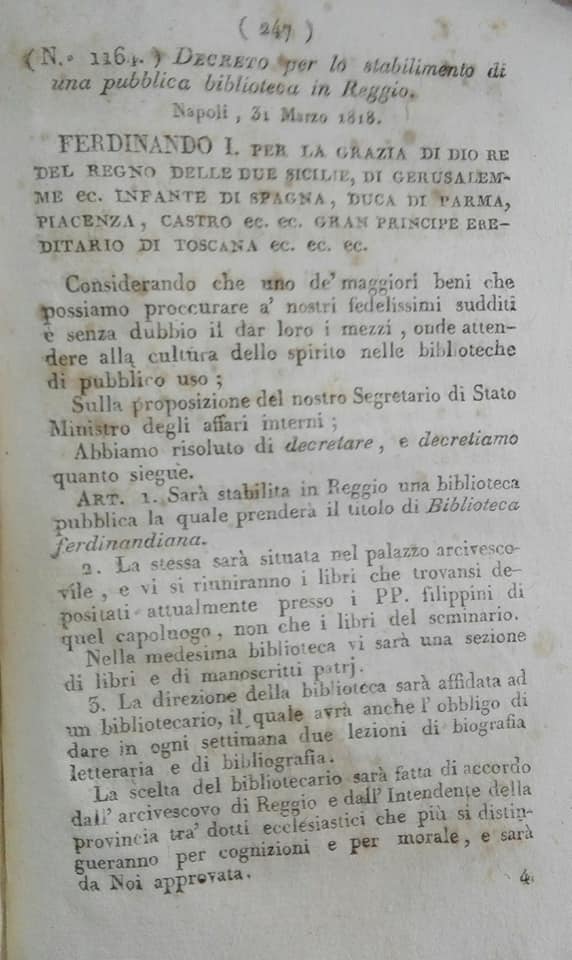La mia prefazione alla ristampa del libro di Tito Fedele: Ricordanze e riflessioni (2020)
A cosa servono i ricordi? Qual è la loro natura? Perché nascono e si incastonano
nella mente, a volte sfidando anche la nostra stessa volontà? Se ha ragione
Cesare Pavese nel considerare che delle nostre vite ricordiamo gli attimi, non
i giorni, può rivelarsi utile imitare il clown di Heinrich Böll e farne “collezione”.
È ciò che fa Annunziato Fedele in Ricordanze
e riflessioni, compiendo un’operazione che non sempre cede al rimpianto,
nemmeno quando prevale la nostalgia per persone, luoghi, storie lontane.
Esiste una sottile distinzione tra questi due sentimenti. Il rimpianto è causato da un
passato che opprime, un passato che è ancora presente perché avremmo voluto
fare qualcosa e vi abbiamo rinunciato o perché abbiamo compiuto un’azione che,
nel presente, consideriamo un errore. La nostalgia può invece avere anche un’accezione
positiva, nonostante la sua etimologia (nostos: ritorno; algos: sofferenza) indichi –
ad esempio in Milan Kundera – il dolore suscitato dal desiderio inesaudito di “ritornare”
ad una condizione di felicità perduta. È il caso dei ricordi piacevoli, che
provocano uno stato d’animo di serenità interiore.
I ricordi e le riflessioni di Fedele confermano l’immagine popolare, strettamente
connessa alla molteplicità dei rapporti interpersonali che comporta lo
svolgimento della professione di “medico di paese”, di un uomo dal vasto sapere
e dalla grande umiltà. La familiarità con la quale riesce a “colloquiare” con gli
scrittori classici conferisce alla sua formazione la solidità delle radici nodose
e robuste di quei vecchi ulivi più volte richiamati nel libro. Letture
preziose, certamente favorite dalla presenza, in casa, della fornitissima
libreria appartenuta allo zio sacerdote: tomi “pergamenati”, testi sacri, libri
di storia e di diritto ecclesiastico, grandi classici e poeti latini minori. Ma
anche Shakespeare, Goethe, Hugo: raffinatissimo il rimando a I miserabili per descrivere la malattia
che in gioventù lo tiene “stretto come Jean Valjean quando cadde in mano ai
vili Thenardier”.
I riferimenti letterari di Ricordanze e
riflessioni impreziosiscono i ricordi di Fedele rivestendoli di un’aurea nobile,
così come i ricorrenti “intermezzi musicali”, dotte citazioni da musicofilo con
la passione per le sinfonie dei grandi compositori, ereditata dal padre. Quel
padre che suona il violino in chiesa e che si diletta a pizzicare le corde del
suo mandolino per i figli raccolti attorno al braciere, la sera dopo avere
consumato la cena. Spesso sono proprio le melodie del grammofono a mettere in
moto la macchina dei ricordi, a fare da sottofondo musicale alle conversazioni
dell’autore con la propria anima e con la vita fuggita, a illuminare i visi degli
amati congiunti.
I ricordi di Fedele sono istantanee che fissano sul foglio immagini suggestive,
paradigmatiche della realtà eufemiese nella prima metà del XX secolo. Una
società rurale composta da uomini e donne semplici che vivono all’interno di un
sistema produttivo di pura sussistenza, fondato per lo più sull’autoconsumo e nel
quale il baratto svolge ancora una funzione economica rilevante. Quella in cui
Fedele nasce e cresce è la Sant’Eufemia della ricostruzione avvenuta dopo il
terremoto del 1908, caratterizzata dall’urbanizzazione degli anni Venti e
Trenta nell’area denominata “Pezzagrande”, che però mantiene il centro
propulsore nel vecchio sito (Paese Vecchio o Vecchio Abitato), dove continua a
risiedere il ceto storicamente dominante sotto il profilo culturale, politico
ed economico. Un universo popolato da gente umile, scomparsa tra le pieghe del
tempo, i cui “racconti costituivano meravigliose pagine di inedite storie”. Agricoltori,
pastori, lavoratori a giornata, calzolai, sarti, falegnami e artigiani che oggi
sopravvivono nei racconti di Nino Zucco e nella memoria collettiva.
Sono tempi di stalle, di asini e di muli: tempi di mercanti provenienti dai paesi
ionici della provincia reggina che pernottano a Sant’Eufemia, per poi ripartire
all’alba. Molte famiglie vivono nelle baracche senza acqua, prive di corrente
elettrica e dei servizi igienici. L’alimentazione è povera, la carne quasi
sconosciuta, mentre molto praticata è la tecnica dell’essicazione degli
alimenti. I fratelli piccoli ereditano gli indumenti dei fratelli più grandi,
ma può anche capitare che un cappotto passi dal figlio al padre. La mortalità
infantile è alta, così come il tasso di analfabetismo. La vita dei contadini è
duro lavoro dalla mattina alla sera, quando – scrive il poeta eufemiese
Domenico Cutrì – “seduti scalzi sull’acciottolato/ davanti alla porta di casa/
farfugliavano nel vuoto/ aspettando pensierosi il domani/ per chi riusciva a
vederlo”: loro unico svago, la cantina nei giorni di festa. Le donne sono
raccoglitrici di olive (“partivano molto presto la mattina, silenziose, mobili
ombre nel buio della notte”), braccianti agricole che a casa devono anche
badare a nidiate di figli affamati e sporchi.
In questo contesto socio-economico vanno inseriti i “brevi scritti” di Fedele, nei
quali le vicende familiari assurgono a paradigma della storia di un’intera
comunità. Nel libro scorrono i volti di congiunti e di conoscenti; si avverte
il respiro di un secolo trascorso troppo rapidamente, che induce alla
malinconia. Un po’ quel che accade leggendo i titoli di coda di un film che
affascina e che si desidererebbe non finisse mai: si vorrebbe riavvolgere il
nastro per farlo ripartire ancora, dall’inizio. Allo stesso modo, al tramonto
della propria esistenza, Fedele rimette in ordine pensieri, ricordi e persone che
hanno accompagnato il suo cammino, affinché volti e fatti siano cornice pregiata
del suo testamento spirituale: “gli anni seguirono agli anni, innumerevoli
tramonti ed altrettante aurore”.
Ricordanze e riflessioni
si compone di tre parti, che hanno come filo rosso l’attenzione bozzettistica
dell’autore, la precisione nella descrizione di paesaggi, colori e voci della
natura, sui quali posa uno sguardo indulgente e paterno. O delicato, come
quando “dipinge” l’amata dimora, edificata negli anni Trenta sopra i ruderi di
un’antica abitazione patrizia distrutta dai terremoti succedutisi nel tempo a
Sant’Eufemia.
Colpisce l’incastro del registro lirico con quello scientifico, che spesso convivono senza
stonare. Il linguaggio letterario, elegiaco e a tratti raro, caratterizzato da
un ampio ricorso alla figura retorica della similitudine, richiama lo spirito
di Omero, Virgilio, Lucrezio, Euripide, Eschilo, Tacito, Esiodo, Ovidio e di tutti
i grandi classici latini e greci. Così, il mare viene presentato come il “ponto
profondo” del mito greco e, per descriverlo, Fedele declama un repertorio inesauribile
di aggettivi qualificativi. A volte, è la stessa costruzione della frase a
riprodurre lo stile latino, in particolare nella posizione del complemento di specificazione,
posto dinanzi al sostantivo: “i cui rami pendenti lambivano del fiume le acque
loquaci”.
L’Arcadia di Fedele ha i suoni e i colori di “Campanella”, che egli paragona alla Pieria:
il luogo della mitologia greca dove, secondo Esiodo, furono generate le Muse. La
“ridente conca” nella quale il genitore costruisce una piccola casa, che
diventerà la residenza estiva della famiglia, è il suo posto delle fragole, il
luogo incantato della sua spensierata fanciullezza.
Tra la nebbia del tempo prendono forma e si fanno largo, squarciandola, le figure
dei propri cari. Il padre scampato al terremoto del 1908 soltanto perché alle
5.20 di quell’infausto 28 dicembre era già uscito di casa per recarsi negli
uliveti. La madre, originaria di Bagnara Calabra e figlia di un capitano di
lungo corso morto durante un viaggio verso l’Argentina. I fratelli: Nino, nella
seconda guerra mondiale tenente pilota e subito dopo emigrato negli Stati
Uniti, dove si afferma come critico musicale per “Il progresso italo-americano”,
il più diffuso quotidiano statunitense in lingua italiana nel Novecento. Mimì,
che sul fronte greco-albanese contrae una malattia pleuropolmonare che presto lo
porterà alla morte. Diego, più volte sindaco di Sant’Eufemia tra gli anni
Sessanta e gli anni Ottanta, con il quale ha un rapporto di affetto
particolare, definito dal ricorso alla similitudine con i Dioscuri: “Forse,
nell’infinito spazio percorrendo le eterne vie degli astri e delle comete, ci
accosteremo, brillando, con smarriti occhi, ai luoghi dove transitò, con la
durata di un sogno, la nostra vita, dove fuggirono le nostre stagioni”.
Celestina, che muore tra le sue braccia (“ho poggiato la mia mano sinistra
sulla tua fronte e la destra sulle tue mani diafane, per far fluire in te un poco
del mio calore e della mia stessa vita”). Sarino, con il quale da adolescente scavalca
la cinta del cimitero per portare fiori sulla tomba di Mimì. Marietta,
“modellatrice fine di antica oggettistica muraria dal sinistro aspetto”.
Ancora: lo zio Diego, “abile oratore” e podestà in epoca fascista: è lui, nel
1926, il gran cerimoniere dell’inaugurazione del nuovo palazzo comunale e
dell’acquedotto, alla presenza del gerarca e deputato di origine paolana
Maurizio Maraviglia, al quale viene conferita la cittadinanza onoraria; lo
scrittore, pittore e scultore Nino Zucco; il pittore Carmelo Tripodi e il
figlio Domenico Antonio, che “dipinge pure il soave” poiché è riuscito a
trasferire sulla tela i versi della Divina Commedia; Francesca, ragazza di
umilissime origini accolta in casa che, dopo la morte, viene tumulata nella
cappella di famiglia.
Le riflessioni di Fedele toccano gli arcani temi dell’esistenza, gli interrogativi
che gli uomini si pongono, spesso senza riuscire a darsi una risposta, sin
dalla notte dei tempi: contemplando la volta celeste o rimanendo incantati
davanti alle innumerevoli prove della perfezione del creato. Soltanto il mito e
la Bibbia (“ambedue storie sacre”) sono in grado di dare risposte al mistero
della vita e della morte, a rassicurare sull’esistenza dell’Aldilà, dove sarà
possibile rivivere in eterno i momenti felici della vita terrena.
I pensatori dell’inizio della civiltà alleviano la sete di conoscenza, stimolata
dalla consapevolezza dei limiti che gravano la condizione umana come pesante e
intollerabile fardello. Un esercizio emozionante e crudele nello stesso tempo,
che però consente all’autore di visitare le dimensioni più intime e arcane dell’esistenza
umana. Ad esempio, quella onirica: il sogno è il luogo dell’incontro metafisico
con i defunti, che si materializzano portando con sé messaggi che Fedele si
sforza di interpretare. E se la figura del padre svanisce come l’anima di
Patroclo alla vista di Achille, gonfi di lacrime sono gli occhi dei pazienti
che, da lontano, scrutano il loro vecchio medico curante.
I ricordi tengono insieme tutto: passato e presente, il senso stesso della vita.
Riscattano l’uomo dalle sue miserie quotidiane e lo elevano a un piano di
eternità. Quei ricordi che – ci insegna Enzo Biagi – sono la nostra fortuna,
perché contengono tutta la bellezza del mondo.
Ecco la ragione per la quale è necessario conservarli con cura e tramandarli:
affinché non svaniscano come le stelle alle quali Fedele li paragona, puntini
luminosi posti al di sotto della costellazione di Andromeda che nel volgere di
poco tempo si dissolvono nel mare.