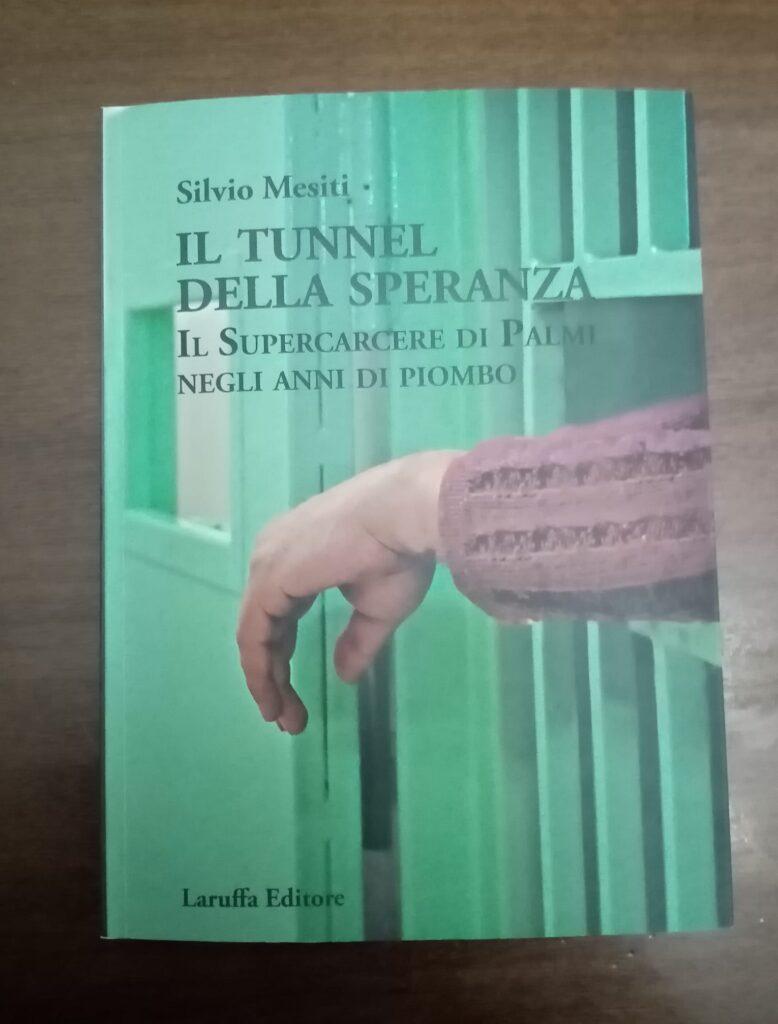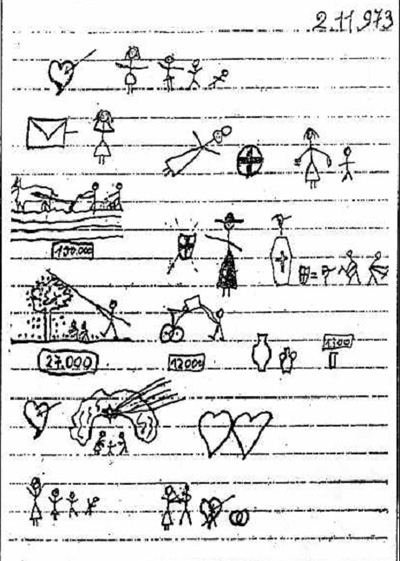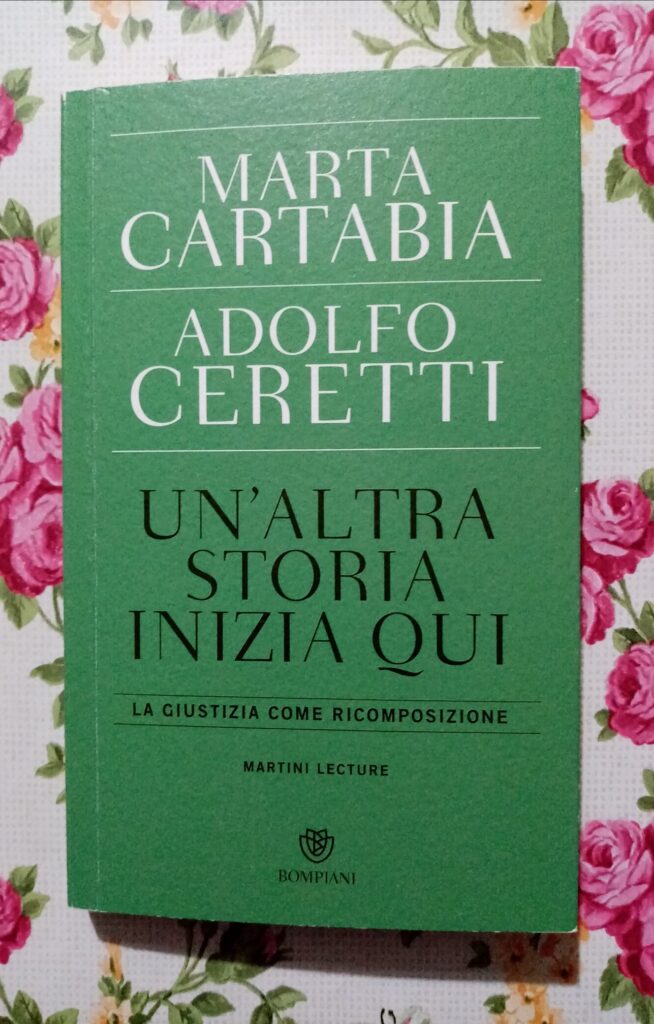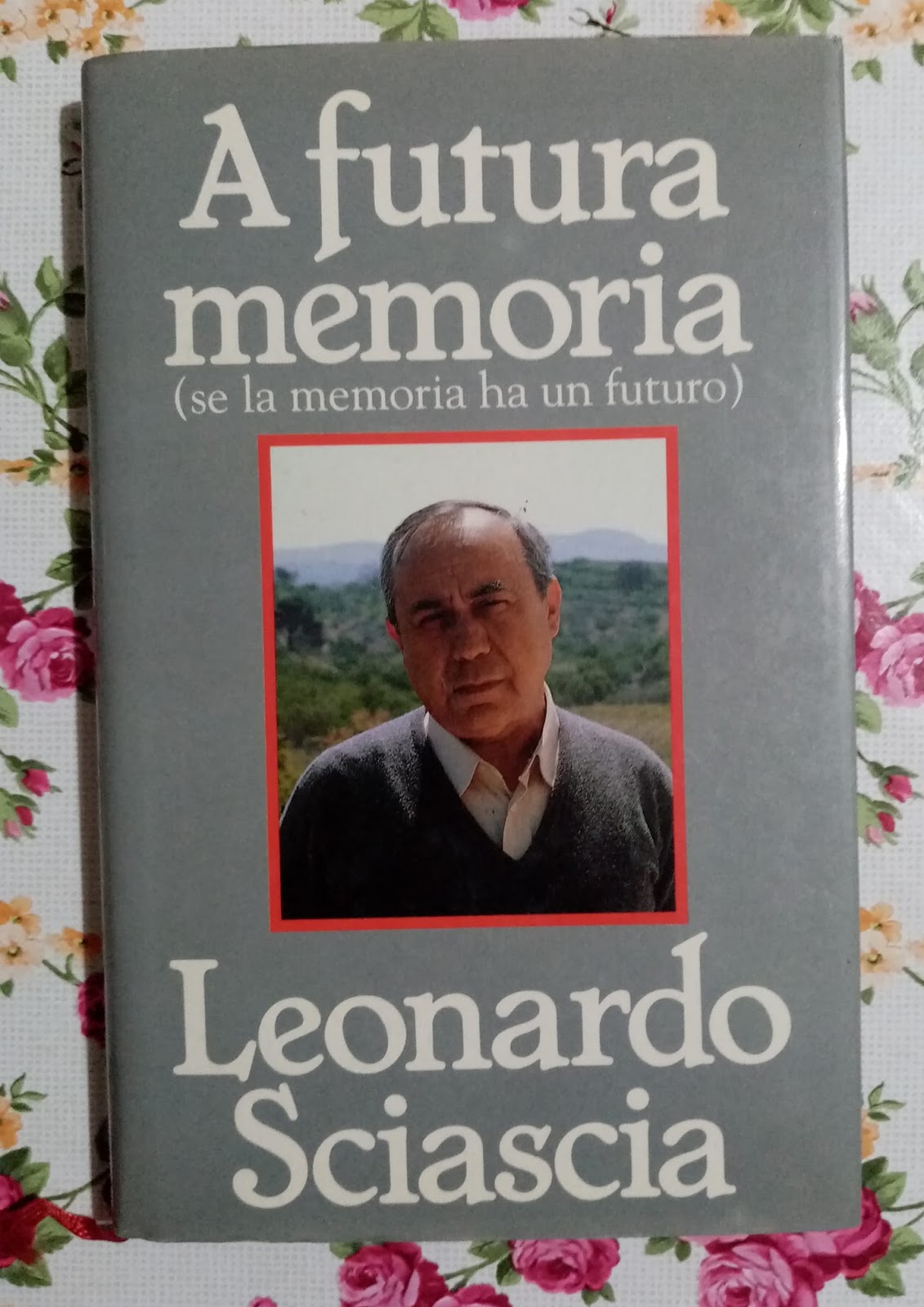Finalmente ci siamo: nei prossimi giorni sarà in vendita il mio nuovo libro. Avevo iniziato a lavorarci nel 2019, ma non avevo fatto i conti con l’imponderabile, per cui la sua pubblicazione è slittata di un anno. Ci tenevo a riprendere un discorso interrotto, a ricominciare dal mio personale “dove eravamo rimasti?”. Questi ultimi due anni non sono acqua passata, ma sono utili per ricordarmi che la vita, nel bene e nel male, riserva sorprese con le quali tutti siamo chiamati a fare i conti. Ora mi sento sollevato.
Non voglio aggiungere altro, se non ringraziare Katia Colica e Antonio Aprile (Il Rifugio Editore), per avermi supportato con affetto e professionalità, e Gresy Luppino, che ha realizzato graficamente una splendida copertina.
Un ultimo pensiero desidero rivolgerlo a due personaggi straordinari che purtroppo non ci sono più, ma che mi hanno donato la testimonianza di un secolo di vita vissuta a Sant’Eufemia: Carmela Cutrì e Nino Condina.
Dalla quarta di copertina:
Sant’Eufemia nell’età contemporanea presenta il risultato delle ricerche condotte dall’autore negli ultimi quindici anni. Le tre parti che compongono il volume affrontano per “quadri” gli eventi significativi della storia eufemiese dalla fine del 1700 ai giorni nostri. La storia “piccola” si intreccia con quella “grande”, nel contesto generale si inseriscono gli episodi particolari e le biografie dei protagonisti. Una cavalcata nei secoli che dà voce all’alto e al basso, al nobile e al popolano, facendo ricorso a fonti scritte, orali e bibliografiche: documenti dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, preziose testimonianze raccolte con le interviste, sconosciute pubblicazioni sepolte nelle biblioteche pubbliche o in possesso di privati. L’affresco di un’epoca affida così alle mani del lettore il filo rosso che, unendo il passato al presente, riscopre vicende personali e collettive paradigmatiche dello sviluppo storico e dell’evoluzione sociale di un paese dell’Aspromonte.
[Domenico Forgione: Sant’Eufemia nell’età contemporanea. Storia, società, biografie, Il Rifugio Editore, 2021, pp. 336]