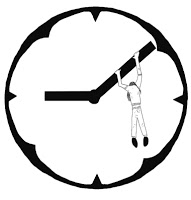Si è tenuta ieri, presso la sala consiliare del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, la presentazione del Vocabolario ragionato del dialetto femijotu, di Giuseppe Pentimalli. Positiva la risposta del pubblico, sia in termini numerici che sotto il profilo dell’interesse e dell’attenzione dimostrati per un’iniziativa partecipata da una confortante percentuale di giovani. In qualità di moderatore, ho svolto un breve intervento iniziale, al quale sono seguiti i saluti del sindaco Vincenzo Saccà, che si è soffermato sulle qualità umane e professionali dell’autore, apprezzate in anni di comune impegno politico e amministrativo. La relazione del professore Filippo Ascrizzi ha messo in rilievo la funzione e il significato di ribellione dell’uso del dialetto nei confronti della cultura dominante, mentre il professore Rosario Monterosso ha sottolineato l’importanza e l’attualità di un vocabolario dialettale nell’epoca di internet e del linguaggio sgrammaticato degli sms. Il glottologo e linguista Paolo Martino, della Lumsa di Roma, ha quindi confermato il valore scientifico e innovativo dell’opera, che “sarebbe più corretto definire dizionario etimologico”. In chiusura, l’appassionato intervento dell’autore: un’accorata difesa della cultura “bassa” nei confronti di una presunta cultura “alta”, tale per definizione, convenzione e imposizione dall’esterno. Quel che segue riproduce, più o meno, il mio intervento.
Ringrazio il professore Pentimalli per avermi coinvolto in un’iniziativa dall’elevato contenuto culturale. Relatori più competenti di me affronteranno gli aspetti tecnici e specialistici del volume. Il mio compito sarà invece quello del vigile. Quello cioè di dirigere il traffico e dare la parola ai relatori che si succederanno, provvedendo a tenere in caldo il microfono tra un intervento e l’altro.
Non essendo io un esperto della materia, credo che il professore Pentimalli abbia voluto la mia presenza per una questione di stima e di affetto, che sono reciproci. D’altronde, negli anni abbiamo avuto spesso modo di confrontarci su alcune questioni e ogni volta che ho pubblicato qualcosa, Pentimalli è stato tra i primi ad averne copia.
Ciò che penso di potere anche io sottolineare, da profano, è la caratteristica principale del vocabolario che, come dice il titolo stesso, è “ragionato”. Ciò ha comportato per l’autore, evidentemente, uno sforzo supplementare: per ogni lemma (quasi 10.000), viene spiegata l’etimologia, ma anche le trasformazioni che esso ha subito nel tempo e nella parlata comune, fino alla versione definitiva. Per questo motivo, consiglio ai fruitori del vocabolario di leggere attentamente la nota introduttiva, laddove sono contenute indicazioni preziose e fondamentali per districarsi in questa complessa materia, e rimandare ad un secondo momento la ricerca dei termini che la curiosità certamente alimenterà. Un’altra peculiarità di rilievo è la corposa Appendice, che non costituisce un riempitivo, bensì il tentativo di rinverdire una tradizione fatta di modi di dire, proverbi, locuzioni e frasi a doppio senso che vogliono contrastare il “lento e progressivo spegnimento dei dialetti” preconizzato da più parti.
Prima di cedere il microfono per il primo intervento, vorrei rubare qualche minuto per dire, fondamentalmente, due cose. La prima, sull’intellettuale “eufemiese” Giuseppe Pentimalli, quarant’anni di insegnamento, trentatré dei quali presso l’Istituto superiore “Nicola Pizi” di Palmi, come docente di latino e greco. Cultore raffinato dei classici latini e greci e della loro interpretazione, come si può apprezzare nella raccolta Le muse discinte (2006), ma anche attento studioso degli aspetti storico-sociali della storia calabrese, che hanno avuto una sistemazione organica nel libro La Calabria antica (2003), riguardante l’arco temporale che va dall’età della pietra al 1060 dopo Cristo.
Cito volutamente per ultimo il saggio La ricostruzione del paese dopo il terremoto del 1908, contenuto nel volume edito da Rubbettino nel 1997 che raccoglie gli Atti del convegno di studi per il bicentenario dell’autonomia, organizzato dall’Associazione culturale Sant’Ambrogio nel 1990. E mi accosto a questo lavoro con profondo rispetto, perché ha avuto su di me un’influenza particolare, come spunto e termine di paragone e confronto per il mio libro sulla storia politica e amministrativa di Sant’Eufemia d’Aspromonte.
Ma c’è ancora un altro aspetto della figura di Pentimalli che va messo in evidenza: l’impegno di un intellettuale calato nella sua realtà e nel suo tempo, protagonista di primo piano negli ambienti culturali eufemiesi, ma non solo, se si pensa agli anni in cui il professore ha avuto responsabilità politiche e amministrative, come sindaco del paese a più riprese (1976-79; 1985-90; 1990-92) e, più in generale, come esponente di punta della sezione locale del partito comunista italiano. In questo quadro d’insieme, va inoltre ricordato il decennio di direzione della rivista “Incontri” (1995-2005), edita dall’Associazione culturale Sant’Ambrogio, sulla quale per la prima volta, ai tempi ormai lontani del liceo, io stesso vidi pubblicato il mio primo articolo e della quale, personalmente, avverto parecchio la mancanza.
Questo è per me “Peppino” Pentimalli, uno dei migliori figli della comunità eufemiese. Riporto – vox populi, vox dei – quanto dichiarato da un mio amico quando ha saputo della pubblicazione del vocabolario: “Solo Pentimalli poteva scriverlo”. Io non lo so se poteva scriverlo solo lui. Di certo, però, l’ha fatto e credo tanto basti per tributargli un doveroso ringraziamento.