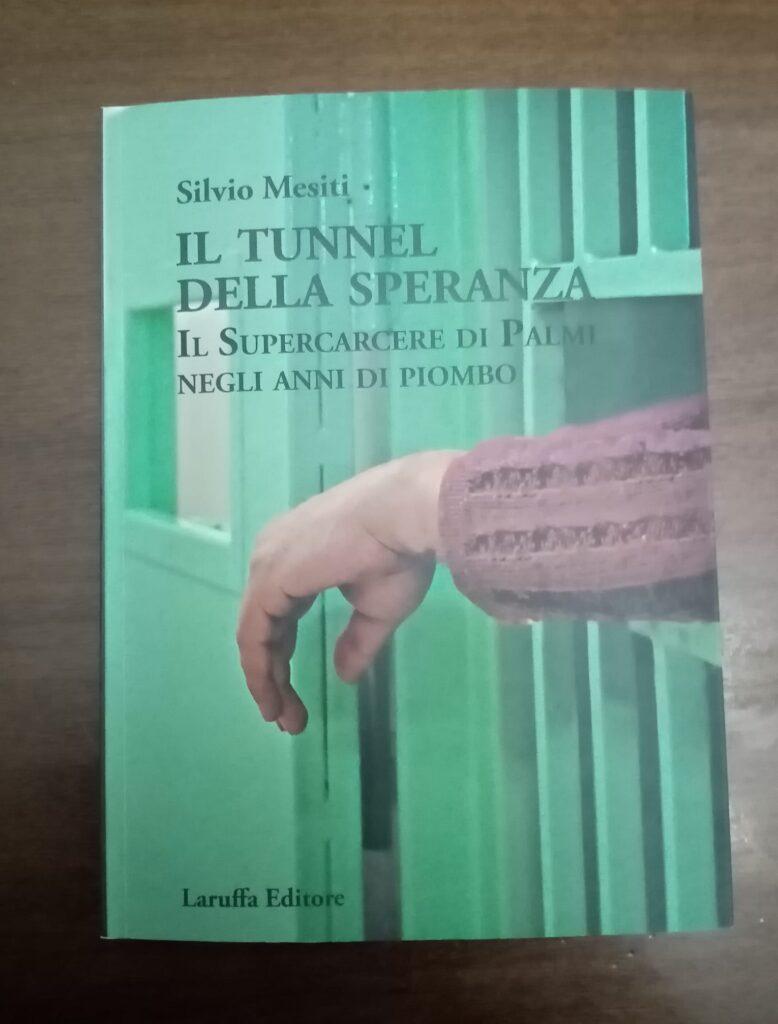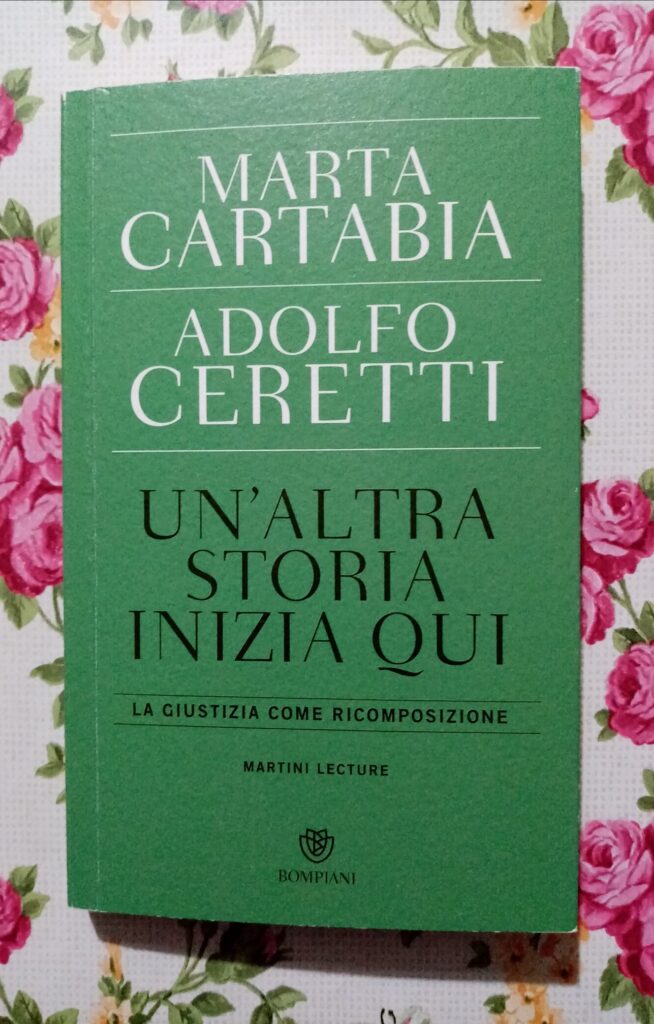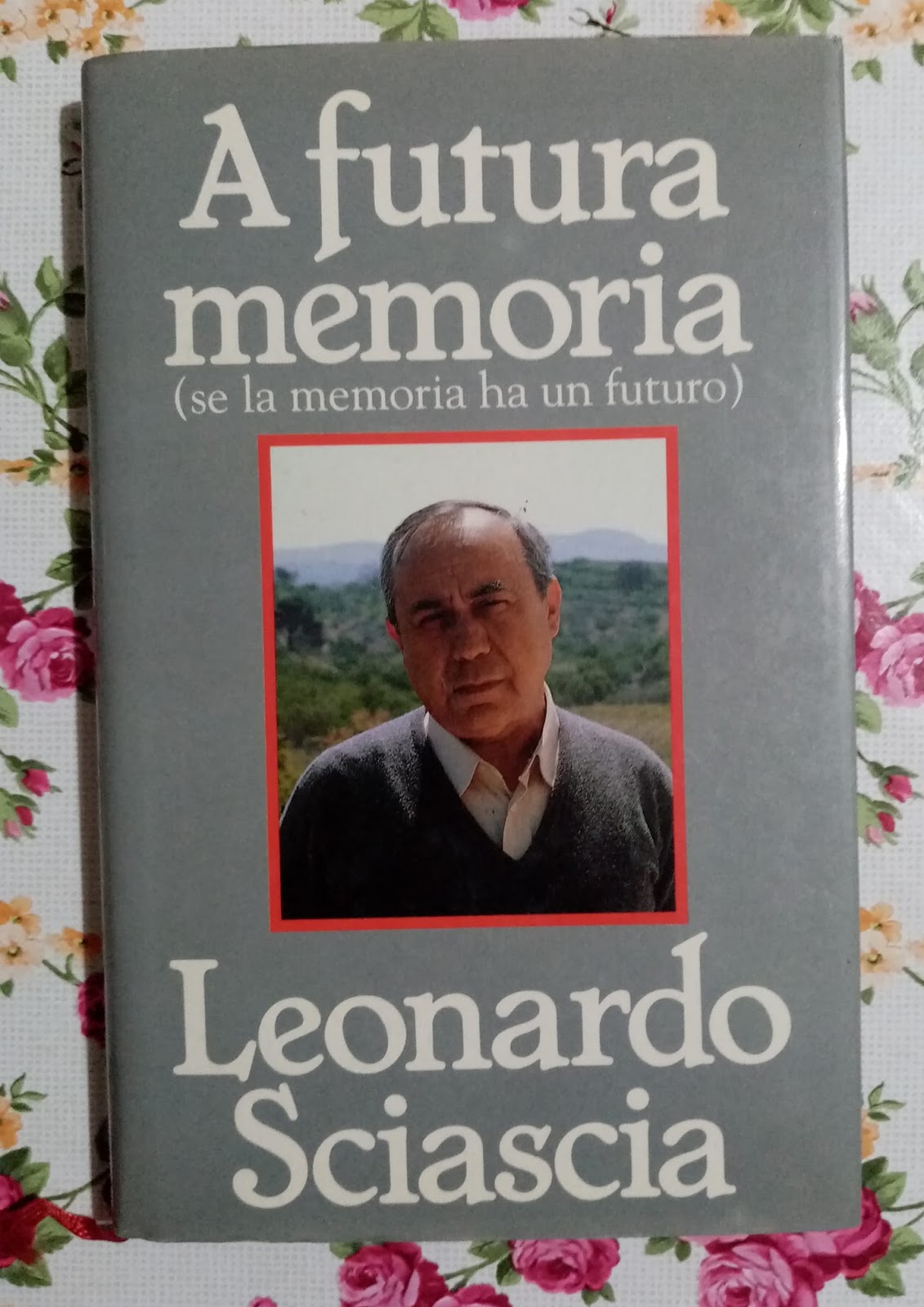Non sono il primo e non sarò l’ultimo caso di malagiustizia. Dovrei quasi ritenermi “fortunato”, visto che la mia posizione è stata archiviata e, pertanto, mi è stata almeno risparmiata l’ulteriore umiliazione di dovere affrontare un processo.
Sono soddisfatto? No. Arrabbiato? Neanche. Sono deluso. Nessuno dovrebbe essere privato della libertà ed essere scaraventato nel “cimitero dei vivi”, prima dell’accertamento della sua colpevolezza.
Non riesco a togliermi dalla testa le immagini di me che scendo per primo le scale della questura di Reggio Calabria il 25 febbraio 2020, giorno dell’operazione “Eyphemos”. Né le sentenze emesse da televisioni, giornali e quotidiani online, locali e nazionali. Sarebbe onesto che gli amanuensi delle procure che si annidano nelle redazioni giornalistiche ammettessero: «Ci siamo sbagliati perché, come sempre, abbiamo considerato dogma l’ipotesi investigativa degli inquirenti; perché, come sempre, abbiamo fatto carne di porco del principio della presunzione d’innocenza».
Non riesco a scacciare via la sensazione d’impotenza suscitata dalla constatazione dell’irrilevanza degli strumenti difensivi: rigetto della comparazione fonica di parte; inutilità delle argomentazioni a discolpa presentate, per me coerenti e logiche sin dal principio di questa assurda storia; mortificazione del diritto alla difesa, fino a quando la procura non ha deciso di affidare al RIS di Messina la perizia che a settembre, 205 giorni dopo l’arresto, ha finalmente portato alla mia scarcerazione poiché, essendo stato accertato lo scambio di persona, non sussistevano più i “gravi indizi di colpevolezza”.
Comprendo l’errore, ma non accetto l’accanimento. Questa amara sensazione ha accompagnato ogni giorno della mia detenzione, martellante come il sostantivo utilizzato dal pubblico ministero e avallato dal tribunale della libertà nel rigettare il ricorso: secondo l’accusa, contro di me risultava un “coacervo” di indizi. Ma io non dovevo giustificarmi per comportamenti o atti considerati penalmente rilevanti da chi ha condotto l’indagine. C’era una questione preliminare, sostanziale, decisiva che andava affrontata subito perché concerneva l’errata attribuzione alla mia persona dell’identità del soggetto intercettato. E invece ci sono voluti sette mesi per accertare quello che ho sostenuto sin dall’interrogatorio di garanzia, due giorni dopo l’ingresso in carcere, senza la necessità di ascoltare la registrazione: «Non sono io. Fate una perizia fonica, perché quella voce non può essere la mia». Sette mesi che ho trascorso in prigione: non a piede libero, né agli arresti domiciliari. Troppi, ritengo, per uno Stato di diritto appena appena decente.
Non ho fiducia nella giustizia italiana. Credo invece nella verità, una forza tenace come la goccia che scava la roccia.
Ora inizia il secondo tempo, che intendo come impegno per una battaglia di civiltà minoritaria e impopolare: contro la gogna del giustizialismo mediatico, contro l’aberrazione della carcerazione preventiva, contro la condizione disumana di molte carceri italiane.
Scarto il buono dal brutto: la presa di coscienza di questioni mai considerate nella loro complessa rilevanza, diventate ora ragione di studio e per le quali credo valga la pena spendersi. Da libero cittadino e da osservatore purtroppo privilegiato.