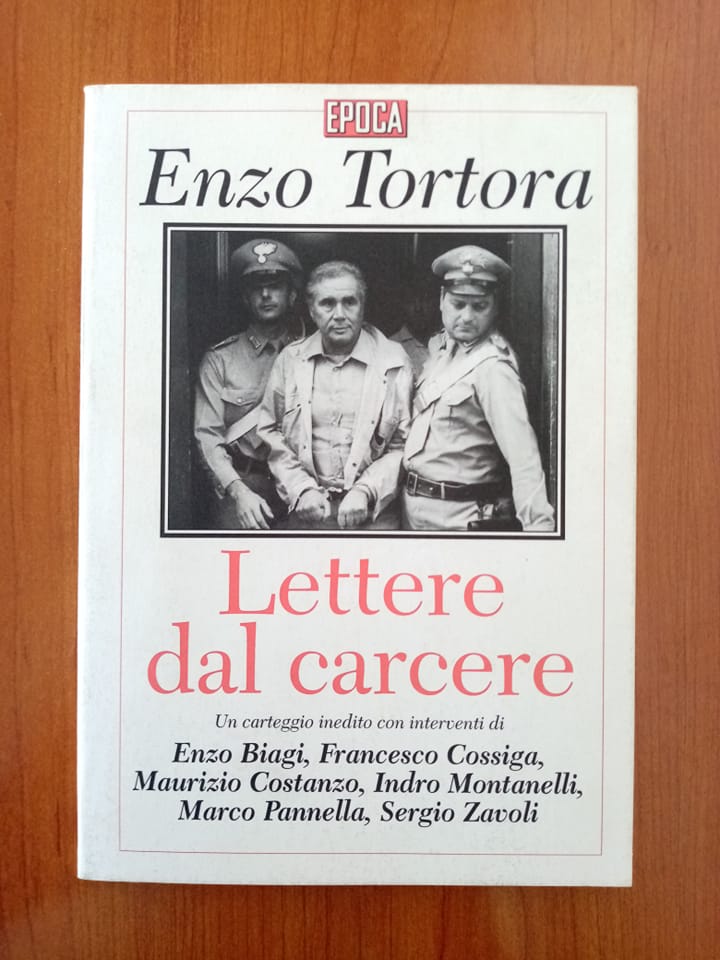“Io, arrestato ingiustamente, voterò sì al referendum Giustizia e vi spiego il perché”
Il referendum Giustizia è alle porte: “non si tratta di tifare per magistrati o garantisti, ma di creare le condizioni affinché la giustizia funzioni”
“La carcerazione preventiva è quella cosa per la quale tu finisci in carcere anche se forse non hai commesso il reato che ti viene contestato: accade così una volta su due. Uno dei motivi che giustifica la carcerazione preventiva è la possibilità che l’accusato possa commettere nuovamente lo stesso reato. Quel reato che una volta su due non è stato commesso. Cioè, resti in carcere (mesi, anni) perché potresti commettere nuovamente un reato che non hai mai commesso. Un’assurdità totale: si dovrebbe andare in carcere solo se colti in flagranza di reato o dopo l’accertamento processuale. Esiste un provvedimento più antidemocratico e liberticida, basato sul sospetto e sul pregiudizio? Il quesito referendario numero 2 abroga questa nefandezza giuridica. E francamente mi indigna che si debba ricorrere al referendum per cancellare una norma tipica dei regimi dittatoriali, non di uno Stato di diritto quale l’Italia dovrebbe essere”. E’ quanto scritto, sulla propria pagina Facebook, da Domenico Forgione, storico, ricercatore, ex consigliere comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte, finito suo malgrado in un calderone di arresti effettuati nel comune aspromontano nel febbraio del 2020, a seguito dell’operazione Eyphemos condotta dalla Procura di Reggio Calabria.
Forgione, che si era fin da subito dichiarato innocente e completamente estraneo ai fatti, era stato arrestato e aveva scontato buona parte della sua pena preventiva in Campania. La sua scarcerazione, come vi avevamo raccontato in un articolo del 18 gennaio 2021, era avvenuta dopo 7 mesi. La posizione di Domenico Forgione è completamente caduta: si è trattato di uno scambio di persona. Tutto qui, semplicemente, ma intanto il suo volto, il suo nome, la sua storia, erano finiti su tutti i giornali. E il suo caso non è l‘unico scambio di persona già appurato nel contesto dell’operazione Eyphemos.
Data la vicenda, dato il vissuto personale, dati i tanti nodi ancora da sciogliere sull’operazione che ha visto in manette parte dell’amministrazione comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte e che è costata lo scioglimento del comune e il conseguente commissariamento, abbiamo chiesto proprio a Domenico Forgione le sue personali ragioni del Sì, in vista del prossimo referendum Giustizia per il quale saremo chiamati a votare domenica 12 giugno.
“Il referendum in questione va considerato non in contrapposizione alla magistratura, ma come una spinta al Parlamento e alla politica italiana affinché si intraprenda una riforma sostanziale per la quale questo referendum è anche insufficiente, se vogliamo, ma è pur sempre un inizio per provare almeno a spronare una classe politica inerte: l’Italia è il Paese che più volte è stato richiamato dall’Unione Europea proprio per la cattiva amministrazione della giustizia”, spiega Domenico Forgione ai microfoni di StrettoWeb.
Nello specifico, in merito al quesito che andrebbe a modificare gli effetti della Legge Severino, Forgione precisa come il quesito stesso sia stato posto in maniera piuttosto equivoca: “se dovesse vincere il sì non avremo amministratori corrotti legittimati ad amministrare. Tocca alla discrezionalità del giudice stabilire se un amministratore debba decadere o meno. Chi viene condannato in primo grado di giudizio, per la Costituzione Italiana, non è ancora un colpevole, ma per i pubblici amministratori di fatto non è così. In sostanza la presunzione di innocenza, per un amministratore, attualmente non esiste. E il punto è proprio questo: c’è disparità di trattamento tra cittadino comune e amministratore”. Una stortura, questa, che va necessariamente limata secondo i sostenitori del Sì.
Forgione ha anche precisato le ragioni per cui voterà Sì al quesito numero 2, ovvero quello che ha lo scopo di limitare gli abusi della custodia cautelare. “I motivi per cui viene applicata la custodia cautelare – ci spiega il ricercatore storico – sono tre: pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Il referendum si concentra su quest’ultimo punto”. La propaganda a favore del no fa leva, anche in questo caso, su un equivoco: se abroghi questo articolo vedrai i delinquenti a spasso. Di fatto, anche in questo caso non è così. “Intanto – precisa Forgione – i reati gravi vengono tenuti fuori da tutto questo, perché stiamo parlando solo di reati che prevedono pene al di sotto dei 4 anni. Inoltre c’è il discorso del pregiudizio: siamo ancora in un momento in cui non è accertata la responsabilità del reato, e siamo quindi in presenza di un paradosso; la legge va a incidere sul fatto che un imputato, il quale forse ha commesso un reato, lo possa ricommettere. E il tutto senza aver ancora appurato se il reato sia stato commesso o meno”.
“Anche i promotori del referendum – spiega Forgione – si guardano bene dall’andare a fondo sul discorso delle ingiuste detenzioni, le quali sono a livelli esorbitanti nel nostro Paese: si parla di 1000 casi in un anno, ma questa cifra riguarda solo quelle già risarcite”. Dal 1992 al 31 dicembre 2021, infatti, si sono registrati 30.017 casi di ingiuste detenzioni: vuol dire che, in media, si sono registrati poco più di 1000 innocenti in custodia cautelare ogni anno. Alla base della piramide, però, c’è ancora tutto un ‘sommerso’ che non è tenuto in considerazione in questo conteggio. “Inoltre – precisa Domenico – il referendum non tocca quel reato per cui si viene arrestati più ingiustamente, ovvero l’associazione mafiosa. Per lo più, infatti, le ingiuste detenzioni riguardano reati afferenti al 416bis. Ciò però non significa che chi evidenzia questo problema sia a favore della criminalità. E’ solo un modo per dire che evidentemente la legislazione emergenziale non funziona, visto che abbiamo tutti questi casi di innocenti arrestati, e quindi forse andrebbe rivista. Ma questa, purtroppo, non è materia che entra nel referendum. Chissà, forse viene messo in conto che in distretti giudiziari come la Calabria è normale che vi siano situazioni di questo genere”, chiosa Forgione con amara ironia.
In verità, secondo Domenico Forgione e non solo, queste riforme avrebbe dovuto attuarle il Parlamento. “Se avesse voluto (il Parlamento, ndr) avrebbe affrontato direttamente le questioni, ma da ‘Mani pulite’ in poi nel nostro Paese regna un clima di facile giustizialismo che non consente un dibattito sereno. Perché qua non si tratta di tifare per magistrati o garantisti, ma di creare le condizioni affinché la giustizia funzioni. E attualmente in Italia non funziona, tanto che negli ultimi anni l’indice di gradimento si è abbassato notevolmente. Toccare questo tema pubblicamente, però, è impopolare, perché il parlamentare o il gruppo politico che si fa carico di queste battaglie viene percepito male da un’opinione pubblica avvelenata da 30 anni di giustizialismo. Basti pensare che anche per il prossimo referendum il quesito più importante, ovvero quello della responsabilità civile dei magistrati, è stato cassato”, conclude Forgione.
Intervista realizzata da Monia Sangermano per StrettoWeb, 9 giugno 2022 (qui per il link originale)