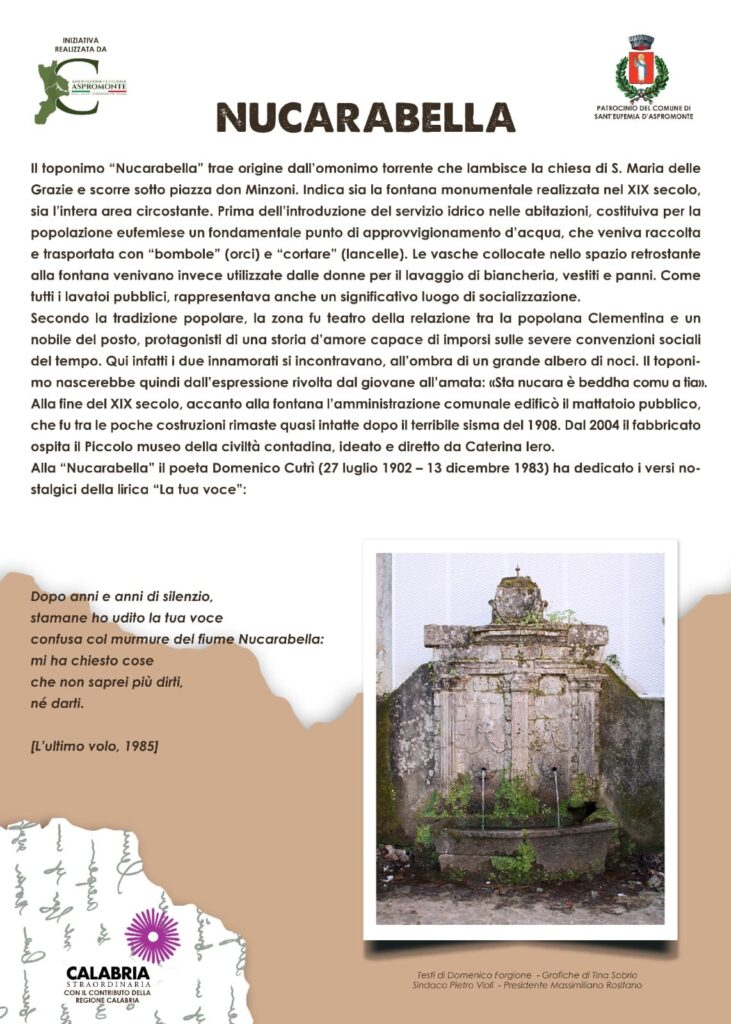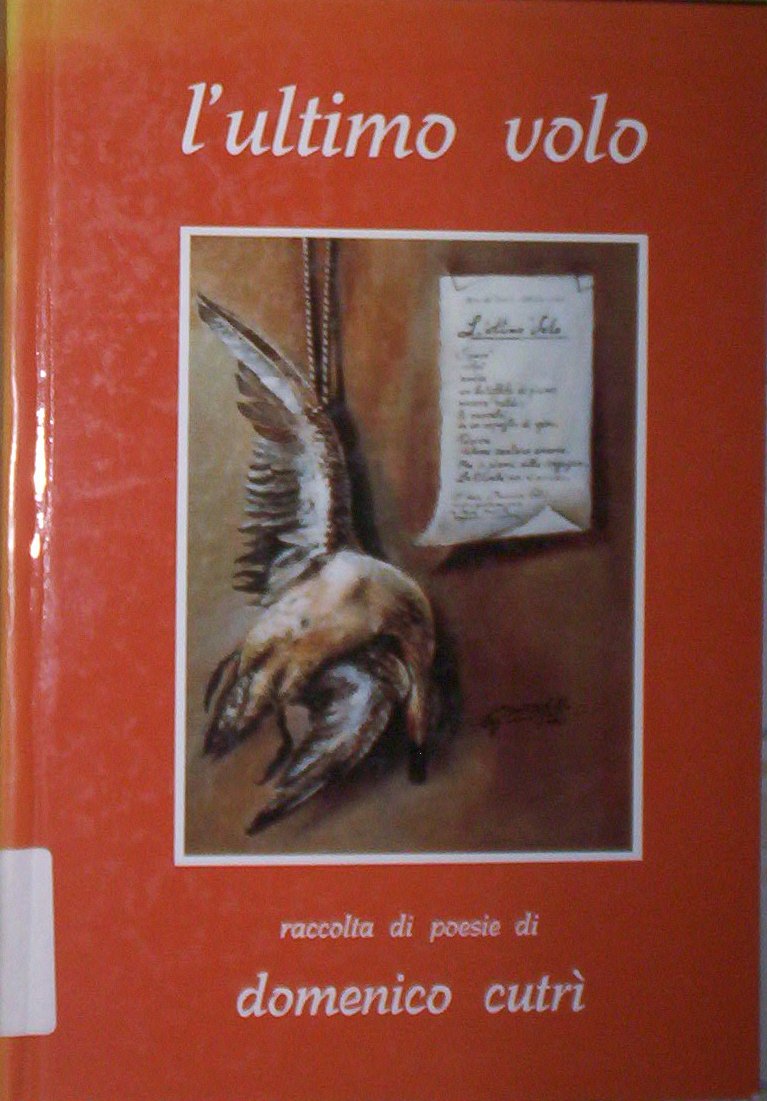Per giungere alla terza fermata occorre inerpicarsi lungo la ripida salita che collega il “Paese Vecchio” all’area denominata “Petto del Principe” (più comunemente: “Petto”). La sosta, a poche decine di metri dalla vetta, consente al viandante di prendere fiato prima dello strappo finale.
PANNELLO 3: IL CALVARIO
Il “Calvario” (via Roma) collega il “Vecchio Abitato” con il “Petto del Principe”, il pianoro che si estende verso la “Pezza Grande”. Lo sviluppo urbanistico successivo al terremoto del 5 febbraio 1783 interessò il “Petto” e la zona alta del paese, dove alcuni notabili costruirono la propria abitazione. In cima al “Calvario” dominava Palazzo Fimmanò, mentre a metà strada si trovava Palazzo Capoferro, i cui ruderi sono ancora oggi visibili. La denominazione popolare trae origine dal monumento che riproduce la scena delle Tre Croci. Realizzato nella metà del XIX secolo, dalla relazione redatta il 25 marzo 1846 dall’ingegnere Gaetano Oliverio (autore del progetto, su incarico del sindaco Paolo Capoferro), si apprende che un’opera simile, preesistente, era andata distrutta nel corso degli anni.
Luogo dalle mille suggestioni, al “Calvario” il poeta Domenico Cutrì (27 luglio 1902 – 13 dicembre 1983) ha dedicato due liriche:
Lu Carvariu
«Quantu voti passandu di sta via
m’indinucchiai vicinu a stu carvariu
sgranandu cu la menti nu rusariu
’nsuffraggiu di la morta mamma mia.
E mentri ch’iu pregava cu fervuri,
ogni divotu chi di ccà passava
cu fidi na candila ci ddumava
sutta li pedi di nostru Signuri.
St’artari misu ’mmenzu a ddù paisi
d’ogni fidili canusci li peni,
pari ca dici: «vulitivi beni
senz’odiu, senza chianti, ma surrisi».
O vecchiaredda cu la testa janca
chi ’nchiani pe la strata purvirusa,
avvicinati, o matri dulurusa,
dammi la manu si ti senti stanca…
… e quandu simu ni lu crucivia
ogn’unu pigghia pe lu so’ caminu,
s’abbrazza lu so’ pallidu Destinu,
lu bagagghiu pisanti e… Cusì sia!
[Cascami. Poesie dialettali, 1965]
Sulla strada del Calvario
Lasciatemi salire
arrancare ancora una volta
per questa pietraia.
Lasciatemi baciare ancora
la croce arrugginita
dell’icona.
Sarà l’ultima volta.
[L’eterno sentire. Liriche, 1974]