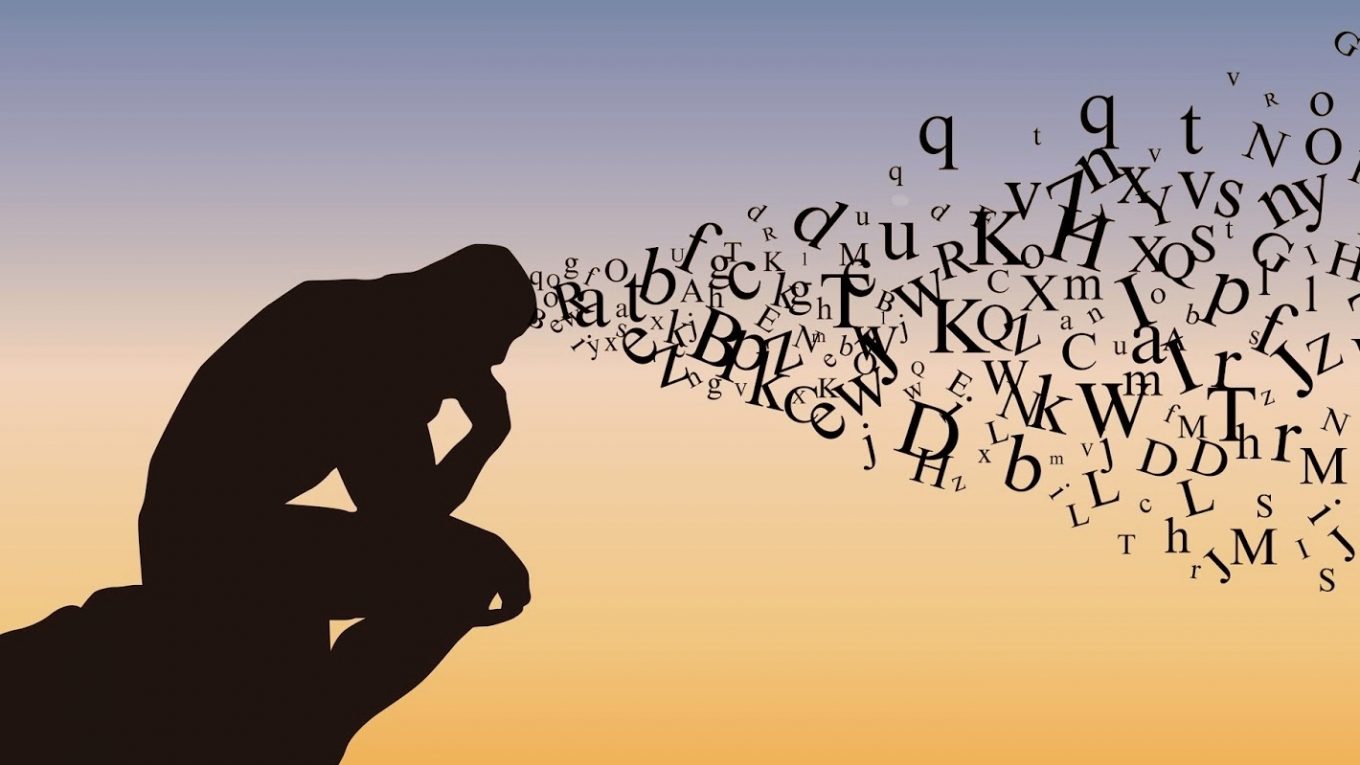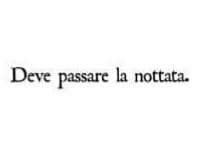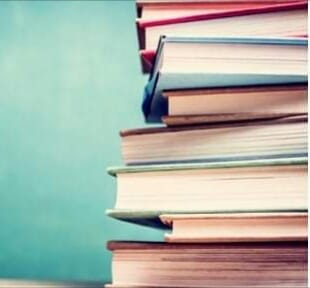LIBRI – Libri letti. Devo ad André Malraux, tratta da “La condizione umana”, la più efficace definizione di prigione: «il luogo in cui si arresta il tempo che altrove continua». Giorni sempre uguali a sé stessi, ripetitivi e interminabili. I libri sono distrazione e allenamento: ho avuto come coach Borges, Voltaire, Tabucchi, Carlo Levi, Vittorini, Sciascia, Sofri, Balestrini, Consolo, Bufalino, Hosseini e tanti altri. Libri da scrivere. Come quello interrotto il 25 febbraio, ora ripreso e quasi completato.
LASAGNE – Ricky Albertosi dichiarò di avere mangiato in cella i bucatini all’amatriciana più buoni della sua vita, probabilmente esagerando per non uscire dal suo ruolo di guascone. Io ho invece provato tanta tenerezza nel vedere l’impegno e la pazienza di chi cucina le lasagne, così come la pizza, le torte e tutto ciò che va cotto al forno… senza avere il forno, sopra un fornellino da campeggio. Lasagne che si condividono: un modo per farle viaggiare da un lato all’altro della sezione si trova sempre, se necessario anche con il metodo della canna da pesca.
LUNA – «Nei mari della luna i tuffi non si fanno»: a volte è grandissima e ti ci vorresti tuffare lo stesso, a dispetto dei Mercanti di Liquore. Ma nelle notti infinite è un puntino che forse ti guarda, forse no. Sta là, tutta compresa dentro un quadratino della rete della finestra. Stretta, stretta, come noi in sei passi avanti e sei indietro. Il blindo è un coperchio di bara fino al mattino successivo. A fendere la notte, la luce della torcia come un lampo o l’interruttore carogna, mentre dormi.
LOTTA – Lotta impari, contro un “dominio assoluto” che incredibilmente ha la faccia dello Stato. Lotta per avere riconosciuto anche il diritto di telefonare, quando ti viene negato con pretesti assurdi. Mentre le domandine vengono ignorate, oppure non si trovano e ogni giorno bisogna ripresentarle. Si aspetta, si aspetta, in una realtà nella quale nessuno è responsabile e tutti “eseguono degli ordini”. Eppure non si arretra, anche a costo di una punizione, per non perdere l’ultimo briciolo di dignità.
LUCE E LUTTO – Tra i libri letti, ho molto apprezzato “La luce e il lutto” di Gesualdo Bufalino, il cui intento è proporre emozioni, più che esporre ragioni: «Lusingandomi – precisa – che quelle sappiano non meno di queste spiegarci agli altri e, prima che agli altri, a noi stessi». A pagina 124 ho cerchiato di rosso una frase, definitiva: «Qualunque violenza inflitta a un innocente in nome d’un interesse o principio o puntiglio (uno dei tanti che volubilmente di secolo in secolo appassionano i potenti) è altrettanto empia che inutile».
LENZUOLO – Il rumore della battitura mette i brividi. Sgabelli, brande e pentole contro finestre e cancelli. Le voci sono una babilonia di rabbia: «Vergogna! Vergogna!». Vergogna per un suicidio annunciato, già tentato qualche giorno prima. Il lenzuolo come un cappio, annodato alle sbarre della finestra. Finalmente libero. Non è il primo e non sarà l’ultimo, tra questa umanità dannata, stordita da un consumo spropositato e incontrollato di psicofarmaci, purché sia sonno.
LIBERTÀ – La libertà violentata nel cuore della notte ha la voce sorda di colpi violenti sulla porta, come tonfi nell’anima. I polsi fanno male, ma non quanto gli scatti delle macchine fotografiche, schierate come un plotone d’esecuzione che mitraglia contro la scalinata della questura. Non c’era nessuno sette mesi dopo, quando le porte si sono aperte. Nessuno a fotografare la valigetta di plastica e la borsa con cerniera a quadretti rossi e neri. Nessuno nel chilometro di strada percorso a piedi come un profugo, fino al bar più vicino.
LETTERE – Lettere ricevute e lettere scritte, tantissime e provvidenziali: pacca sulle spalle e terapia. Per volare con il pensiero oltre il filo spinato. Per ingannare la routine concentrazionaria che mina quotidianamente la dignità di un detenuto attraverso il controllo del suo corpo. Per continuare a vivere, con la speranza che pulsa dentro il petto all’avvicinarsi della guardia. Per trovare nella solidarietà altrui la conferma alle parole di Camus: «Nella profondità dell’inverno, ho imparato alla fine che dentro di me c’è un’estate invincibile». La verità è un’estate invincibile.