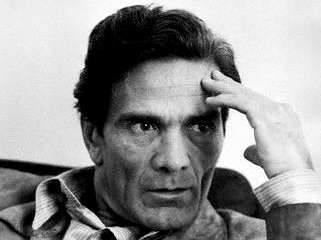A volte la vita è il primo piano di Enrico Ghezzi e le sue parole fuori sincrono. Mentre parli, mentre scrivi, mentre vivi, scorre altrove. Scorre altra. E non sei nemmeno quello che appari. È uno stadio successivo all’intuizione di Pirandello: siamo come gli altri ci vedono. No, non siamo neanche quello. Siamo in perenne lotta con l’immagine che gli altri hanno di noi. Ogni singolo individuo incarna il mistero della vita. E della morte. Consumiamo i nostri giorni affannandoci a capire qualcosa, di noi e degli altri. Inutilmente. Perché quando arriva il momento di capire, scopriamo la nostra inadeguatezza. Pietrificati, ci auguriamo soltanto che le lancette scorrano veloci, per non pensarci più.
Abbiamo combattuto la nostra fottutissima guerra per arrivare a questo punto. Per ritrovarci col cuore a pezzi e non poterlo neanche mostrare. Perché nessuno capirebbe. Ognuno dirà che è colpa dell’altro. Come se la vita sia questo. Non penso che sia così. E mi fa orrore ridurre tutto a una guerra che non avrà mai un vincitore, ma soltanto vittime più o meno consapevoli. L’orgoglio ferito è capace di qualsiasi cosa. Purtroppo.
Ragione e torto. Mi sono seduto dalla parte del torto perché gli altri posti erano già tutti occupati. Ma chi lo stabilisce qual è la parte del torto? E chi può sapere se ci è dato scegliercelo un posto? Ci si ritrova su una sedia. Aspettando che le lancette scorrano veloci. Perché domani arriverà presto. Ma niente potrà più essere come prima. Neanche la speranza.
Una regina di nome Ciccia
La corona di Ciccia non era d’oro. Era fatta di capelli. Non aveva pietre preziose incastonate, ma tanti ferretti. Quelli che tenevano arrotolata sulla sua testa una lunga treccia, d’inverno nascosta sotto un foulard prima a fiori, poi nero.
Da bambina Ciccia non era stata una principessa, anche se era riuscita a completare la scuola elementare. Una rarità, in un paesino dell’Aspromonte negli anni ’20 del secolo scorso. Tempi in cui si diventava presto donne, soprattutto se si avevano due sorelle e un fratello più piccoli. A 12 anni si era già mamme. Non erano tempi di amori da feuilleton. Se uno zio acquisito, Micu, rimaneva prematuramente vedovo perché la moglie era morta di parto, era quasi naturale che toccasse alla nipote più grande allevare, assieme ai fratelli, i due cuginetti. Non di rado, capitava di andare in sposa allo zio. Quattordici anni di differenza non sono pochi, ma questa era l’ultima delle preoccupazioni. I problemi si risolvevano in famiglia.
Quando iniziava la primavera, Micu si trasferiva sull’Aspromonte, mesi e mesi senza tornare a casa, giorni interi a tagliare legna e, di notte, a sorvegliare la carbonaia. Poi la guerra nel teatro libico, la prigionia e il rientro a casa. Un carbonaio analfabeta, spedito dal Duce a difendere la Quarta Sponda, doveva per forza diventare comunista. E così fu per Micu, tessera del Pci nel portafogli e sul comodino i ritratti di Stalin e Togliatti, accanto al rosario e al libro di preghiere della moglie.
Il mondo di Ciccia era un cucinino, un gabinetto e due stanze. Per qualche tempo, una. Da dividere con mamma, marito, uno dei due cugini e due figli (un maschio e una femmina), per il periodo in cui nell’altra camera si accampò un parente con tutta la famiglia, una sistemazione “provvisoria” durata diversi anni. Sempre meglio dei molti che, ancora negli anni ’60, vivevano nelle baracche in legno del dopo terremoto, monolocali affollatissimi privi di acqua, servizi igienici, corrente elettrica. Attaccato al suo mondo c’era l’Eden, raggiungibile varcando l’uscita sul retro. Un piccolissimo ma ricco giardino, curato con amore e applicazione: rose bianche e rosse, calle, fior d’angelo, biancospino, gladioli, begonie, garofani, tulipani, dalie, un cespuglio di margherite, un albero di camelie, due di mele del paradiso, un mandarino, un arancio.
Nel suo mondo c’erano soprattutto due figli da accudire, in particolare la piccola di casa, alla quale portava ogni mattina una tazza di latte e fette di pane nel letto. Ai piedi, a mo’ di borsa dell’acqua calda, un mattone riscaldato nel braciere; in caso di mal di gola, anche un calzino pieno di cenere viva da tenere arrotolato al collo come una sciarpa.
La stessa attenzione usata più avanti nei confronti dei nipoti, le cui date di nascita teneva appuntate su un quaderno di prima elementare: 10.000 lire al festeggiato, 5.000 agli altri. A Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, uguale trattamento per tutti.
A cavallo degli anni ’80, si stava bene da Ciccia. Stretti stretti, il calore aumentava. La porta era sempre aperta e i bambini entravano di corsa dal cortile per bere, accaldatissimi e sporchi. Si faceva merenda con pane, sale e olio. D’estate, l’orzata. Dolcissima, nel bicchiere che portava stampate sul vetro macchinine d’epoca. L’idrolitina del cavalier Gazzoni, no: quella la beveva soltanto lei. Per i gelati bastava andare in uno dei due alimentari della ruga: i putijari segnavano nella libretta, poi passava Ciccia. Si dormiva nello stesso letto e, appena svegli, la colazione era baldoria, con la scatola dei biscotti Doria da tre chilogrammi al centro della tavola e tutti attorno cinque piccole pesti pronte a sfidare enormi tazze arancione. La domenica tutti a messa: al momento dell’offerta, nella mano di ogni bambino scivolava una moneta da deporre nel cestino. Subito dopo, la cucina sprigionava l’odore del sugo con le polpette che avrebbe condito i maccheroni fatti in casa e stesi sul letto matrimoniale, sopra un lenzuolo bianchissimo. Ed era festa.
I miei Pink Floyd
Girovagando nel web, mi sono imbattuto in una votazione sugli album dei Pink Floyd, la band inglese composta in origine da Syd Barret (chitarra e voce), Roger Waters (basso e voce), Nick Mason (batteria) e Richard Wrigth (tastiera), ai quali quasi immediatamente si unì David Gilmour (chitarra e voce) per supportare e infine sostituire Barrett, annientato dai propri demoni e dall’LSD. Un passaggio fulmineo e sfavillante nella storia del rock psichedelico che in seguito ispirò ai Pink Floyd l’album Wish you were here – in particolare, la canzone Shine on you crazy diamond – e, in parte (essendo prevalente l’autobiografia di Waters), il personaggio Pink nel monumentale The wall, “concept album” diventato anche film (regia di Alan Parker, con Bob Geldof nel ruolo del protagonista).
Devo però mettere le mani avanti. Non sono un esperto di musica. Quello che so sui Pink Floyd l’ho appreso quasi passivamente e senza accorgermene, come aria che si respira. Merito di mio fratello Luis, “pinkfloydologo” d’eccezione: tutto quello che è stato scritto, tutti i dischi (poi cd), tutte le videocassette (poi dvd), persino due tatuaggi, uno tratto dalle immagini dell’album The wall, l’altro da The division bell. Un giubbotto di jeans, che credo ancora conservi, sul quale ai tempi del liceo fece ricamare la copertina di The wall. Ecco, lui può dibattere indifferentemente e con rara competenza degli inizi psichedelici e degli anni della maturità; conosce le biografie di ogni singolo componente; sa tutto sulla genesi di ogni canzone e album; di tutte è in grado di recitarne il testo, in inglese e in italiano. Sa indicare con esattezza l’ingresso della batteria di Mason in Atom hearth mother (9.09: “ascolta ora 50 secondi di perfezione”), quella batteria che nella canzone In the flesh? diventa una raffica. Sa tutto, ma proprio tutto, sugli assoli di Gilmour, sublimati nella straordinaria Comfortably numb. Può anche fare una lezione su una canzone strumentale mai incisa ed eseguita soltanto dal vivo (Reaction in G), che forse gli stessi Pink Floyd non ricordano. I suoi dischi sono cimeli, suonati soltanto una volta per essere copiati sulle musicassette (all’epoca non esistevano cd). Poi sono stati idealmente messi dietro una teca, con il divieto assoluto, per chiunque, di toccarli.
Io non so scegliere tra The dark side of the moon e The wall. E anche a costo di andare controcorrente, penso che The final cut (l’ultimo prima dell’uscita di Waters, 1983) sia un grandissimo album.
Per me la musica è soprattutto pelle d’oca. È l’emozione di Time, che cantavo con mio fratello sotto la doccia (lui le strofe di Gilmour; io quelle di Wright); oppure la pace di Marooned, pezzo strumentale che ascolto quando devo prendere una decisione importante o raggiungere il massimo della concentrazione (ai tempi dell’università, prima di un esame). È l’emozione del concerto a Cinecittà, il 20 settembre 1994, al quale non potevamo mancare. Soprattutto dopo che, ancora minorenni, ci eravamo persi quello di Venezia, nella tournée del 1989. Prendemmo il treno insieme al nostro amico Cosimo e arrivammo di primo mattino davanti ai cancelli, ancora chiusi. Non c’era nessuno. Mio fratello ci proibì di muoverci, perché “dovevamo” entrare per primi e arrivare sotto il palco. E così fu. Tredici ore di attesa per un’esperienza straordinaria, condensata dalla sua battuta al sacerdote-professore di religione del liceo: “ha presente uno che prega, prega e di colpo gli appare la Madonna? Ecco, quando sul palco è spuntato Gilmour, credo di avere provato una cosa del genere!”.
Trentasei anni senza P.P.P.
Sono arrivato a Pier Paolo Pasolini da solo. O quasi. Ai tempi del liceo, lo sfiorai tra la prima e la seconda classe, quando la professoressa di lettere ci assegnò alcuni libri da leggere durante le vacanze estive. Conobbi così Pasolini, Cesare Pavese, Italo Calvino, Primo Levi e qualcun altro autore del Novecento. Le fortune dei ragazzi passano spesso dagli insegnanti che incontrano lungo il cammino scolastico. A me è andata bene. Nel biennio, un rapporto splendido, anche sotto il profilo umano, con la professoressa Paino; nel triennio, quello decisivo per la mia formazione con il professore Monterosso (storia e filosofia). In quinta, però, studiammo poco o niente gli autori del Novecento. Di sicuro, non li leggemmo. E anche se il professore di lettere avesse avuto questa intenzione, non credo che ci avrebbe fatto leggere Pasolini. Troppo distante dal suo mondo.
Per vie traverse ci sono però arrivato ugualmente. Mi capita spesso di leggere qualcosa che rimanda ad altri autori. E così è stato. Mi sono “imbattuto” nella raccolta di poesie Le ceneri di Gramsci e così ho prima approfondito il poeta, quindi sono passato alla lucidità del pensiero degli Scritti corsari, all’intellettuale scomodo, scandaloso e affascinante per chi si rifiuta di sottostare alle logiche e ai valori propagandati dal consumismo e dall’edonismo dominanti. Nessuno meglio di Pasolini ha saputo leggere i cambiamenti della società italiana nel secondo dopoguerra. Nessuno è stato così profetico e coraggioso nel mettere in guardia, con quarant’anni d’anticipo, dal baratro verso il quale l’umanità stava (e sta) precipitando. Le denunce contro il Palazzo, il ruolo e la funzione della televisione in una società di massa, l’omologazione culturale, la trasformazione antropologica della società sono temi drammaticamente attuali.
Domani ricorre il trentaseiesimo anniversario dell’assassinio di Pasolini. Una vicenda che presenta ancora molti lati oscuri. L’ennesimo mistero della storia d’Italia. Nella sua appassionata orazione funebre, Alberto Moravia pronunciò parole forti e condivisibili: “abbiamo perso prima di tutto un poeta, e poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono soltanto tre o quattro in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta: il poeta dovrebbe essere sacro!”.
Ti saluto così
Tra i tanti ricordi, mi piace associarti alla tua grande passione: il volo degli uccelli. Chissà, forse più in là dirò altro. Ora mi piace pensarti con gli occhiali da sole dalle lenti spesse per potere meglio osservare senza rimanere accecato dalla luce, e il binocolo che tenevi sempre sulla macchina, pronto ad accostare appena scorgevi un punto sull’orizzonte. Spesso non riuscivi a capacitarti di come non riuscissimo a vederlo pure noi, che non avevamo l’occhio allenato come il tuo.
“Guarda quanto è bello l’adorno in volo!”, esclamavi innamorato.
Ciao, “zio” Pino
Saluti da Londra/ bis
Anche l’ammiraglio Nelson ci teneva a salutare. A proposito, dice Mario che un suo amico, arrivato a Trafalgar Square abbia esclamato: “ma quello e’ Napoleone?”

Da Piccadilly Circus, invece, il saluto di Cupido. Domanda: secondo voi, il buontempone che ha “lasciato” una mano dentro le mutande del dio dell’amore e’ londinese?!

Oscar Wilde ci ricorda che “siamo tutti nel fango, ma alcuni di noi stanno guardando le stelle”.
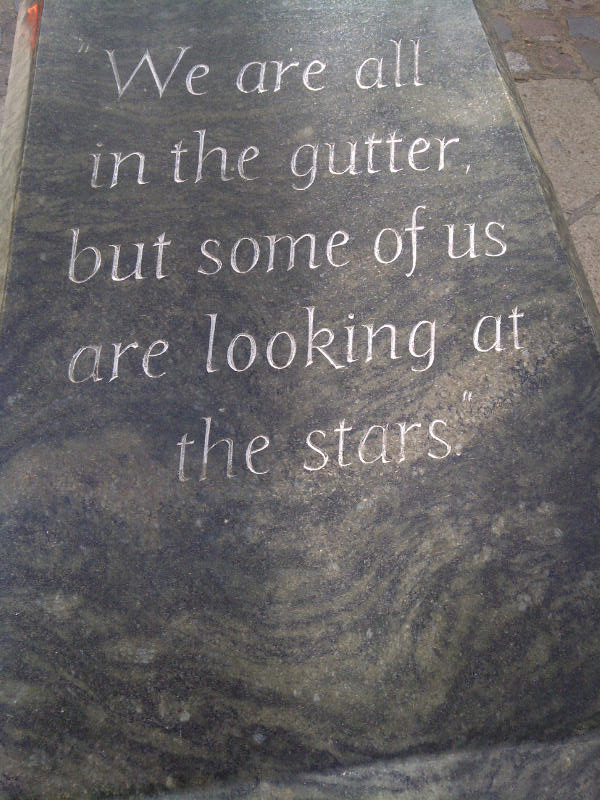
“Mentre attraversavo London Bridge”, non ho potuto fare a meno di canticchiare “Geordie”.

Ancora: Tower Bridge…

… e London Tower.

Possibile che ci sia tutto questo vento?!

Ma no, va tutto bene. Garantisce Mr “cool” Britannia!

Saluti da Londra

Pronto? Mi sentite? La “perfida Albione” non e’ come dicono. Per esempio, non e’ vero che a Londra piove sempre. E’ un luogo comune messo in giro dai francesi…


… pero’ e’ vero che mangiano da cani! Il cornetto farcito con il salame piccante non l’avevo mai visto…

… e neanche la seppia fluorescente! Dall’espressione perplessa di mio fratello Mario riflessa sul vetro, suppongo si tratti di una novita’ della cucina cinese a Soho.

Il Big Ben non ha detto stop…

… purtroppo, neanche i cannoni, come si evince dal presidio pacifista davanti alla House of Commons.

Se ti scappa e ti trovi da “Costa”, serve lo scontrino della consumazione, su cui si trova stampato il codice da digitare per aprire la porta della toilette. Se non paghi, te la puoi fare addosso…

… anche se ti chiami Elisabetta!!
La notte più bella della mia vita
La notte più bella della mia vita era dicembre, ma non era ancora Natale. L’aria era gelida, la sentivo sul naso e sulle orecchie mentre aspettavo di potere andare da Lei. Un lettino da dividere in due, in una stanza che da letto non era.
La colonna sonora del nostro incontro la intonò Patti Smith: Because the night, la sigla di Fuori orario che ci sorprese sotto le lenzuola. L’ascoltammo fino all’ultima parola, perché “l’amore è un banchetto sul quale ci sfamiamo” e perché “la notte appartiene agli amanti”.
Ci sussurrammo le nostre vite passate, quasi volessimo azzerare la storia e fare ripartire il cronometro da noi, con il racconto del tempo che non avevamo vissuto insieme.
Ci separammo all’alba. Percorsi a piedi la strada deserta del ritorno, in un’aria di vetro. Ero il re del mondo e, mentre una luna pallida e infreddolita mi scrutava, camminavo in pace, sotto le ultime stelle mute. Non avevo bisogno di niente.
La notte più bella della mia vita è stata un battito d’ali.
Frank il mongolo
A prima vista poteva sembrare un incrocio tra una maschera dei film di Carlo Verdone e Nichi Nardozza, l’eccessivo ed eccentrico personaggio di Volare basso, romanzo di successo scritto da Gaetano Cappelli. Anche se di Nardozza non aveva la propensione a raccontare balle colossali. La similitudine riguarda l’aspetto esteriore, l’abbigliamento e lo stile di vita un po’ naif che lo rendevano, agli occhi di una piccola comunità come quella eufemiese, personaggio singolare e stravagante.
Cuoco sulle navi da crociera. Era stata questa la sua professione, negli anni Sessanta e Settanta. Un giramondo sciupafemmine e single impenitente. Francesco Gioffrè, detto “Frank il mongolo” per quei baffi (e il pizzetto) alla Gengis Khan, era un personaggio da film. Romanzesco e simpaticissimo. Il sorriso sempre stampato sul viso, tranne quando perdeva a biliardo. A boccette, per l’esattezza, ché con la stecca si è sempre rifiutato di giocare. Superstizioso, portava attaccato al collo un corno di corallo rosso infuocato e, per sconfiggere il malocchio di chi assisteva alla partita, bocciava tenendo la pallina incastrata tra indice e mignolo. Indossava camicie incredibili sotto il gilet da cow-boy di vacchetta e stivaletti da rock star. Stretto tra i denti, spesso, un sigaro dalle dimensioni spropositate. Al polso, bracciali delle più svariate fogge. Milanista sfegatato, entrava al bar cantando una personalissima rivisitazione – non so quanto consapevole – del coro più celebre del Napoli alla fine degli anni Ottanta: Oh mamma, sai perché mi batte il corazón? Oh Cristo (invece di: ho visto), Maradona!
Ogni tanto dalla sala biliardi giungeva al bancone del bar un urlo: “un baaaby!” (mezzo whiskey), cui seguiva un bestemmione irripetibile. Fuori, parcheggiata, la macchina dei nostri sogni di ragazzini: un’Alfa Triumph Spitfire IV diventata rossonera dopo un restyling realizzato con il pennello, il cui interno era tutto un programma. Coprisedili con pelliccia, clacson a trombetta, un corno enorme, due cuscini del Milan e musicassette di Elvis Presley e Julio Iglesias sparse ovunque.
Quando l’ho conosciuto, da tempo non lavorava più sulle navi. Ritornato in paese, aveva aperto un genere alimentari che durò pochissimo. Costretto a chiudere prima di rovinarsi completamente, dato che offriva pezzetti di formaggi e salumi a chiunque entrasse e si faceva pagare la spesa una volta sì e una no, mentre per i ragazzini delle scuole il più delle volte il panino imbottito era “omaggio della ditta”. Tornò quindi alla sua vecchia professione di cuoco, questa volta sulla terraferma, negli alberghi, da dove periodicamente tornava, sempre atteso dai frequentatori della sala biliardi e soprattutto da mio fratello Luis, dodicenne o giù di lì, al quale aveva regalato un braccialetto di occhio di bue e promesso, con largo anticipo, che avrebbe fatto da compare d’anello al matrimonio.
L’ha tradito il cuore a 55 anni, una notte di aprile del 1992, in una stanza d’albergo a Soverato, dove alloggiava e lavorava. Non fui presente al suo funerale e la cosa mi dispiacque molto. Nutro un affetto particolare per tutte le persone che, dal 1982 in poi, sono transitate dal “bar Mario”, una delle mie palestre di vita, insieme alla strada e alla scuola. Quando passo per salutarlo, guardando quella camicia insolita per una foto sulla lapide, il sorriso è inevitabile. Come tanti anni fa. Ciao, Frank.
Con le buone maniere si ottiene tutto
Nuntio vobis gaudium magnum: habemus tesseram! Ebbene sì, ce l’ho fatta. L’Ordine dei giornalisti ha finalmente partorito il mio tesserino. Un travaglio lunghissimo, ma il bimbo sta bene. Me lo sto coccolando quasi sbalordito. Quando ieri ho telefonato al sindacato dei giornalisti della Calabria per avere aggiornamenti sulla situazione, quasi non credevo alle mie orecchie. Il piccolo era là, nel cassetto di Carlo Parisi e attendeva soltanto che uno della famiglia andasse a ritirarlo.
Il segretario del sindacato, tra il serio e il divertito, mi ha però rimproverato. Oggi è anche apparsa su CALABRIA ORA una sua replica al mio intervento di inizio settembre, che riproponeva l’articolo di denuncia postato sul blog il 31 agosto. Da quel che ho compreso, Parisi è rimasto infastidito da alcune telefonate scherzose (“ma glielo volete dare questo tesserino?”) e perché l’unico nome presente nel pezzo, a parte quello del commissario Cembran, era il suo. In realtà, il mio articolo non era “contro” di lui, né “contro” il sindacato, che anzi mi è stato di grande aiuto, sia nel dipanare una questione parecchio ingarbugliata, sia nel pungolare l’Ordine per il rilascio del tesserino. Probabilmente, il titolo scelto dal giornale (“L’Ordine dei giornalisti mi snobba da otto anni”) non sintetizzava al meglio il contenuto della mia lamentela. Ma come ben sa Parisi, i titoli non li scrivono gli autori degli articoli.
Riguardo alla precisazione di oggi (“Snobbato dall’Ordine? No, ed ecco il perché”), devo segnalare una piccola inesattezza, che però è sostanziale. Nel 2003, la tessera l’avevo richiesta. Lo so benissimo che esiste una procedura a parte rispetto a quella di iscrizione all’Albo. Non “me ne sono dimenticato”, come egli ipotizza con un pizzico di ironia. Né penso di avere trasgredito la saggia norma di raccontare “i fatti senza omissioni di sorta”. Tant’è vero che avevo ammesso di non avere seguito la pratica per anni, dopo la richiesta, e di avere dovuto saldare diverse quote annuali.
L’incidente è comunque chiuso, con reciproca soddisfazione. Abbiamo anzi scherzato su questa querelle. Una considerazione però va fatta. Neanche il tempo di leggere sul giornale la mia lettera e ho avuto il tesserino. Davvero una singolare coincidenza.