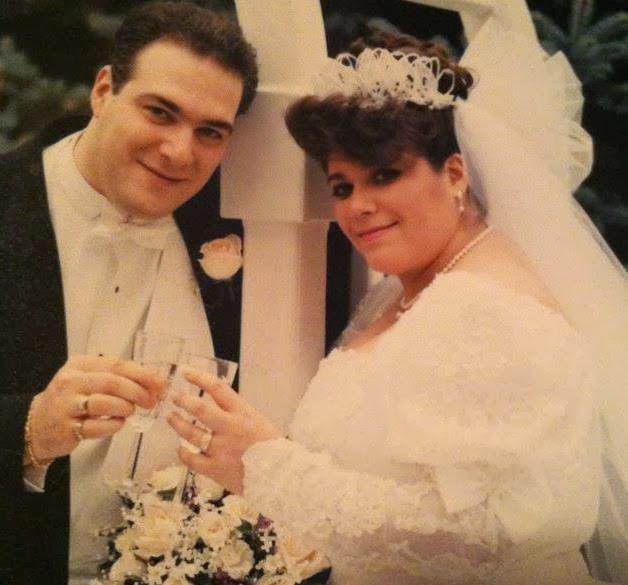Chissà in quale nascosto cassetto della memoria si trovavano sepolte quelle parole. Emerse all’improvviso dai fondali dei ricordi, come quella foto in bianco e nero tra le lenzuola del corredo da sposa della nonna, gli occhi di suo padre sbarrati per il bagliore del magnesio, nel vecchio baule che raccoglie quel che è rimasto dei suoi ottantadue anni.
Rivedo il sorriso di mio padre ad addolcire il tono secco di un rimprovero che era solamente apprensione per le due bolle spuntate in un attimo su pollice e indice della mia mano destra.
– Ma come fai ad essere così stupido? Come ti è saltato in testa di toccare le dieci lire che coprono il buco del piano cottura della stufa a legna?
E poi quel rimedio antico e improbabile. Ché non ci ho mai creduto potesse realmente essere efficace, ma sono molte le cose in cui non ho mai creduto. Nonostante l’età.
La proprietà disinfettante della pipì sulle escoriazioni, ad esempio. O il prodigio del latte degli scartagnoli per fare crescere le dimensioni dell’uccello. Cose così.
Eccomi allora con le due dita immerse dentro un bicchiere di vino. Quel rosso che nel tempo sarebbe diventato il mio migliore amico. E che ora è accomodato accanto a me, lato passeggero di questa vecchia auto scassata. Lo berrò fino all’ultima goccia, mi servirà.
Che buffo questo ricordo, ora. Nello specchietto retrovisore intravedo un ghigno che riconosco e al quale tento di aggrapparmi, prima di affondare. Nei film è tutto diverso, arrivati a questo punto il protagonista sfodera sempre la battuta memorabile che lo consegnerà alla storia. Che tutti ripeteranno come un mantra.
Io no. Con l’accendino in mano, i vestiti e il sedile inzuppati di benzina risento la voce di mio padre, saltata fuori da quel cassetto che non sapevo: devi averne preso da tua madre!
Non lo so da chi ne ho preso. Non so niente, ormai. Posso solo immaginare il puzzo di bruciato del mio futuro. Il rumore sordo dei sogni franati. Il sapore aspro delle promesse non mantenute. Come un limone che sei costretto a mandare giù, cercando di non fare neanche una smorfia.
Ho portato tutto con me, in questo autodafé finale che è la ragionevole condanna per i miei peccati. Il più grave, la fiducia nella mia forza di volontà e nel mio spirito di adattamento.
Eppure è volato un anno senza lavorare, senza portare un soldo a casa. Un anno di lacrime, quelle di mia moglie. Per le bollette scadute, l’assicurazione della macchina non pagata, lo sguardo scocciato del fruttivendolo, le parole sussurrate dai vicini al mio passaggio veloce a filo di muro, come un topo sfuggente agli occhi.
– Mi spiace, non posso più tenerti. Neanche in nero. Tra un po’ chiudo e mando tutti affanculo, non ha senso andare avanti così.
Spiace anche a me, cazzo. Dopo che ti ho fatto il servo per anni e mai ferie pagate, contributi, malattia. Niente di niente. Per seicento euro al mese. Farei lo stesso lavoro per metà stipendio, ora. Ma non si può, mi dici. E allora sono io a mandare tutti affanculo, anche se mi dispiacerà.
Eccome se mi dispiacerà. Restano sempre troppe cose da fare, troppe parole che non si è avuto il tempo di pronunciare. Troppe pagine di libri da leggere che mi avrebbero consolato, credo.
Un ultimo sorso e si va: l’inferno esiste solo per chi ne ha paura.
Forse sarà come molti anni fa sul letto di un ospedale. Il fuoco dentro il corpo e la perdita dei sensi, il materasso un buco nero che inghiotte tutto. Fallimenti compresi.
Deve essere proprio così la morte. Una discesa folle aggrappato a un cavallo impazzito.
Prosit.