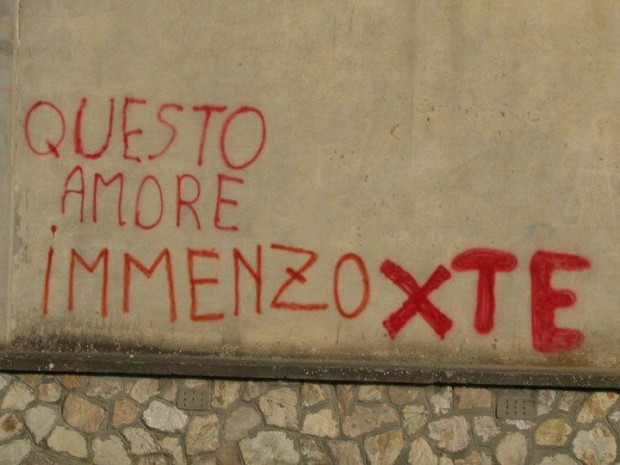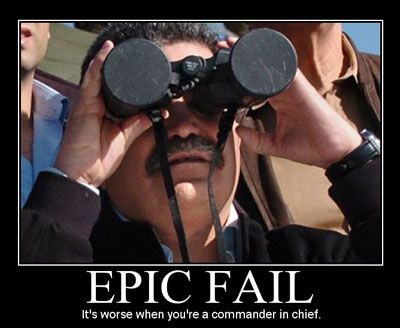– “No! Mannaja Ddena! Non ci voleva questa neve!” – Luigi, Pinuccio, Massimo e Domenic si guardarono, sconfortati. Da quasi un mese aspettavano la prima partita del campionato Esordienti e quel sabato il paese si era svegliato sotto una coltre bianca. Niente scuola, ovviamente, ché ne bastava ’na ddiccàta per scaraventare la cartella, lo zaino o la cinghia con due-tre libri sul divano, uscire fuori e dare inizio alla battaglia. Eppure, quel giorno non riuscivano ad essere allegri. Avrebbero preferito centomila volte entrare a scuola, perfino essere interrogati in latino: sì, alla scuola media il professore d’italiano aveva deciso di insegnare qualche rudimento di latino. “A chi deciderà di iscriversi al classico o allo scientifico, tornerà utile” – aveva osservato, per cercare di indorare la pillola.
Neve, neve e neve. Corsero al campo sportivo per un sopralluogo. Era come sospettavano. Una lunga e larga distesa bianca. Non che loro la temessero, né li impressionava il freddo. Il loro trainer godeva di una meritatissima fama di duro, conquistata grazie alle pesantissime sedute di allenamento che infliggeva ai ragazzi. Li faceva correre fino allo sfinimento e, non appena qualcuno sgarrava, veniva immediatamente spedito a casa. Qualche anno più tardi, quando esplose il fenomeno, i suoi stessi giocatori lo bollarono “Zeman”, il tecnico boemo del “Foggia dei miracoli”, una squadra di sconosciuti che riuscì a sorprendere l’Italia del calcio. Anche se il suo modello era Rinus Michels, l’inventore del calcio totale e profeta del modulo “a zona”, tutto pressing e fuorigioco a centrocampo. Luigi e Domenic, i meno dotati fisicamente, la voce del coach la sentivano anche di notte. Mentre agli altri, dopo un’ora abbondante di corsa, ripetute, scatti, progressioni ed esercizi, era finalmente consentito di toccare il pallone, per loro c’era un supplemento di giri di campo: “Dovete sopperire con la corsa”. Sopperire, un verbo che finirono per odiare, costretti a guardare gli altri divertirsi col pallone venti minuti prima di loro. Per anni si è raccontato di quella volta che si mise a grandinare ininterrottamente, mentre Esordienti e “prima squadra” si stavano allenando allo stesso orario, come capitava non di rado. I “grandi” si rifugiarono dentro gli spogliatoi: ogni tanto, qualche viso faceva capolino per osservare, stupito, tutti quei ragazzini sotto la bufera. “Non vi fermate, continuate a correre” – l’intimidazione del mister.
Figurarsi, quindi, se poteva spaventarli un po’ di neve.
Luigi era il mediano della squadra, il numero 4, quando ancora la numerazione della maglia aveva un senso. Un corpo esile che una folata di vento rischiava di far decollare, con due polmoni e una resistenza da fare invidia al migliore Furino. Anche se il suo soprannome era “Tardelli”. Dentro la divisa si perdeva. D’altronde, gli Esordienti utilizzavano quella della “prima squadra”. Maniche talmente lunghe da fare solamente intuire la presenza di braccia e mani al loro interno e pantaloncini che arrivavano fin sotto le ginocchia. Sul petto, la scritta dello sponsor, una stampa talmente rigida e pesante che finiva per ripiegarsi e appoggiarsi venti centimetri più in basso.
Pinuccio, lo stopper (numero 5): di quelli rudi, nel solco della tradizione italiana. Un morditore di caviglie implacabile, che all’avversario non dava respiro. Aveva adattato a borsone una piccola tracolla dell’Alitalia, rimediata da qualche parente venuto dall’Australia, e sosteneva una sua personalissima teoria sull’elasticità delle scarpe da gioco. Bastava calzarle dentro una bacinella di acqua bollente, per una mezzoretta, e quelle sarebbero scasciate. Leggenda metropolitana vuole che Pinuccio abbia utilizzato lo stesso paio di scarpe da calcio, dal 37 al 40 di piede.
Massimo, un’ala destra velocissima (numero 7). Poca tecnica, ma tantissimo fiato, ha realizzato i gol più “sporchi” della storia del calcio paesano: di ginocchio, di coscia, di stinco, con qualsiasi parte del corpo, che utilizzava come la pala di una ruspa, per spazzare tutto ciò che intralciava la sua corsa. A fine partita, era il più temuto dello spogliatoio. Mai serrare le palpebre, quando c’era lui nei pressi delle docce: il bruciore agli occhi, causato dal sapone, era di gran lunga preferibile ai suoi scherzi terrificanti.
Domenic era invece l’ala sinistra (numero 11, che ogni tanto diventava 10, quando veniva spostato nel ruolo di “regista”), tutto mancino – la scarpa destra praticamente nuova – e portava annodato al braccio sinistro, al posto della fascia di capitano, un vecchio calzettone strappato. Tanta corsa anche per lui, con ai piedi le “Kevin Keegan” regalategli da un suo zio emigrato in Francia, e un fisico che non voleva saperne di crescere, nonostante l’uovo sbattuto consumato ogni mattina a colazione.
Tutti e quattro avevano una passione smisurata per il calcio, che praticavano per strada, nelle piazze, in pineta. Finivano gli allenamenti e continuavano a giocare ovunque si imbattessero in altri ragazzini con un pallone sotto il braccio. Ogni giorno, interminabili partite, che d’estate iniziavano la mattina e proseguivano, dopo la pausa pranzo, fino al tramonto.
Fosse stato per loro, dubbi non ce n’erano. La partita andava disputata, neve o non neve. Ma toccava all’arbitro decidere, non ai ragazzi.
Un sole pallido alimentava un flebile ottimismo: sentivano che qualcosa poteva ancora accadere e che, forse, si poteva tentare di raddrizzare il corso di quella giornata.
Luigi ebbe un’idea geniale, che sia stata sua o presa in prestito dopo averla ascoltata, chissà quando e dove, da qualcuno più esperto, non importa. Il sale squaglia la neve. “Ve l’assicuro, fidatevi” – con quello sguardo furbo che i suoi compagni conoscevano bene, soddisfatto per la trovata. Detto, fatto. Misero insieme i pochi spiccioli che si ritrovarono nelle tasche e li investirono in pacchi di sale grosso da un chilogrammo. La putijara neppure si chiese cosa mai avrebbero dovuto fare con tutto quel sale quei ragazzini, che fecero immediatamente ritorno al campo per cercare di spargerne su quanta più superficie possibile.
Il sale e il sole di marzo resero il terreno di gioco un’immensa pozzanghera. Eppure si giocò. Né l’arbitro, né gli avversari avevano intenzione di farsi di nuovo tutti quei chilometri, per disputare l’incontro un paio di settimane dopo. A fine partita, tanti piccoli pulcini inzuppati fin nelle mutande si tuffarono sotto le docce caldissime, contenti per avere giocato e, ancor di più, felici per il clacson di una vecchia Fiat 500 che una mamma scatenata faceva suonare all’impazzata ogni volta che la squadra segnava. Sei strombazzate soltanto in quel pomeriggio. E tante altre fino alla fine del campionato, concluso trionfalmente un paio di mesi più tardi.