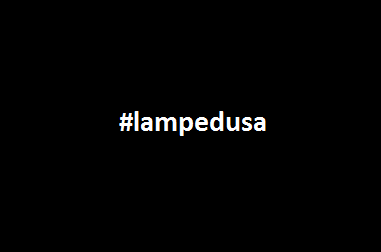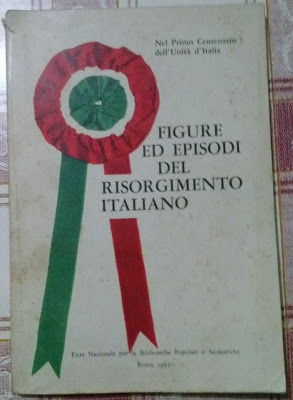In questi giorni, su L’Ora della Calabria, si è sviluppato un dibattito innescato dal corsivo di Francesco Ferro, pubblicato il 31 agosto: “Una terra senza futuro. Non resta che scappare”. Il quotidiano diretto da Piero Sansonetti ha poi ospitato le testimonianze di alcuni calabresi emigrati, mentre Aldo Varano, direttore di Zoomsud.it, è intervenuto con l’editoriale “Calabria. La grande fuga di chi può alla ricerca di un’altra vita”.
Avendo in casa la possibilità di una testimonianza diretta, ho chiesto a mio fratello Mario (che vive a Londra da sedici anni) di raccontare la sua esperienza. Ciò che salta agli occhi è il confronto tra una realtà che offre delle opportunità, beninteso senza regalare niente (si pensi alle periodiche valutazioni alle quali è sottoposto il lavoratore), e un’altra che non dà a tutti le stesse possibilità. Per cui l’ingresso nel mondo del lavoro è un sei al superenalotto o un umiliante questuare davanti alla porta di chi può fare il miracolo. Senza girarci troppo attorno, dalle nostre parti politica o criminalità organizzata.
(D. F.)
Da bambino, la mia materia preferita era la geografia, e l’Atlante Mondadori il volume al quale ero più legato. Mi affascinavano le mappe e le foto di quei luoghi lontani e sconosciuti. Sognavo di andarci in quei posti, visitarli tutti per poi poter dire – alla fine dei miei giorni – che sì, il mondo è stato veramente la mia ostrica.
Col senno di poi, penso che la voglia di viaggiare ed evadere, scoprire, capire e vivere a contatto con diverse culture mi abbia salvato da un’esistenza grigia e da una realtà, quella calabrese (che poi è un riflesso di quella italiana), che a me è stata sempre stretta.
Ricordo che mentre i miei compagni di liceo si chiedevano che facoltà universitaria scegliere una volta raggiunta la maturità, io pianificavo la fuga, una fuga a tutti i costi. Ero incoraggiato dalla mia professoressa di italiano, la quale spesso – dopo avermi dato del fetente e del lavativo – mi diceva che avevo il potenziale ed il cervello per riuscire in qualsiasi cosa avessi deciso di fare.
La mia prima esperienza lavorativa in Italia sono stati quindici mesi nell’esercito italiano: sottotenente ufficiale di complemento. Mi ero arruolato per denaro. Avevo 20 anni e lo stipendio mi procurò quella indipendenza economica alla quale, in seguito, non avrei saputo più rinunciare. Oltre ad essere valsa il titolo di Nobiluomo a vita (e che mio fratello il dottore schiatti di invidia!), quell’esperienza mi convinse che chiedere favori e raccomandazioni non fa per me. Inizialmente ero stato infatti scartato alla visita medica ma poi, con una telefonata, il mio torace si sviluppò magicamente di 5 centimetri! Superai la visita, ma mi sentì sporco.
Una volta congedato, spesi otto mesi a Palermo, giusto il tempo per verificare che l’Università non era il mio forte. All’insaputa dei miei, dopo aver risposto all’annuncio letto su un giornale, mi trasferii a Milano, dove trascorsi tre mesi facendo il porta a porta per i prodotti più impensabili.
Un giorno lessi un articolo sull’Inghilterra. Il pezzo parlava di come fosse facile trovarvi lavoro ed anche imparare la lingua. Con gli ultimi risparmi, due giorni dopo comprai un biglietto per Londra. Avevo 22 anni. Non avevo mai preso un aereo in vita mia, a parte quello che mi aveva portato dall’Australia in Italia, a neanche tre anni. Ricordo che a bordo non chiesi nemmeno un bicchiere d’acqua e rifiutai il cibo che mi offrirono. Avevo paura che mi chiedessero il conto. Arrivai a Londra il 16 giugno 1997, con in tasca i soldi per pagare la stanza di un ostello per due settimane (da dividere con tre estranei), quattro sterline e TANTA fame. Trovai lavoro in un McDonalds due giorni dopo. Una manna: mangiavo gratis per 8 ore al giorno!
Londra non l’ho più lasciata. Ho cambiato occupazione mano a mano che il mio inglese è migliorato. Negli anni ho lavorato in vari bar, ottenendo promozioni e arrivando persino a dirigerne uno. Per tre anni sono stato consulente bancario per una multinazionale del calibro di HSBC, per altri due agente della Polizia metropolitana londinese. Ora lavoro come steward di volo per la Virgin Atlantic, un’occupazione che settimanalmente mi porta in giro per il mondo, facendomi rivivere i miei sogni di bambino.
Mi ritengo fortunato, perché so che ogni volta tutto dipende dalle mie forze. Questo vuol dire vivere in una realtà meritocratica. Qui non si chiedono favori, a nessuno. Ci si prepara e ci si presenta ai colloqui. Punto. Il lavoro te lo offrono se sei qualificato, o se individuano in te del potenziale.
In banca ero stato assunto nonostante i miei stiracchiati 42/60 di maturità scientifica, dopo tre settimane di training retribuite (!): alla fine del periodo di formazione mi fu offerto un posto in prova e, dopo sei mesi di valutazioni mensili, un contratto a tempo indeterminato. Quando ho realizzato che avrei voluto fare altro, ho lasciato quel lavoro: chi, in Italia, abbandonerebbe un posto in banca?
Negli anni mi sono lasciato alle spalle tre contratti a tempo indeterminato, e non ho mai avuto paura di non riuscire a trovarne un altro. Londra mi ha insegnato che il lavoro attuale serve per migliorarsi e creare delle opportunità per il lavoro successivo, e poi per il prossimo ancora. Così ci si costruisce un curriculum ed una carriera, e magari un giorno ci si sveglia con la sensazione di stare vivendo, e non soltanto sopravvivendo.
A distanza di sedici anni e dopo aver acquistato un appartamento, Londra è diventata la mia casa e Sant’Eufemia il paese in cui sono cresciuto. Va bene così.
Talvolta mi mancano i sapori e gli affetti, ma non ho rimpianti. Se fossi rimasto in Calabria sarei vissuto solo a metà, o forse neanche.
Sono contento per chi è in pace. Soprattutto ammiro e rispetto chi ha avuto il coraggio di rimanere e lottare in una realtà che offre poco o niente. Chissà, anche se non sembra, forse io ho scelto la strada in discesa. Ho solo un’amara certezza: la tristezza che provo per chi è rimasto ed ha lasciato che la nostra terra divorasse tutto, non solo talento ed ambizioni, ma con il tempo anche i sogni.
Mario Forgione