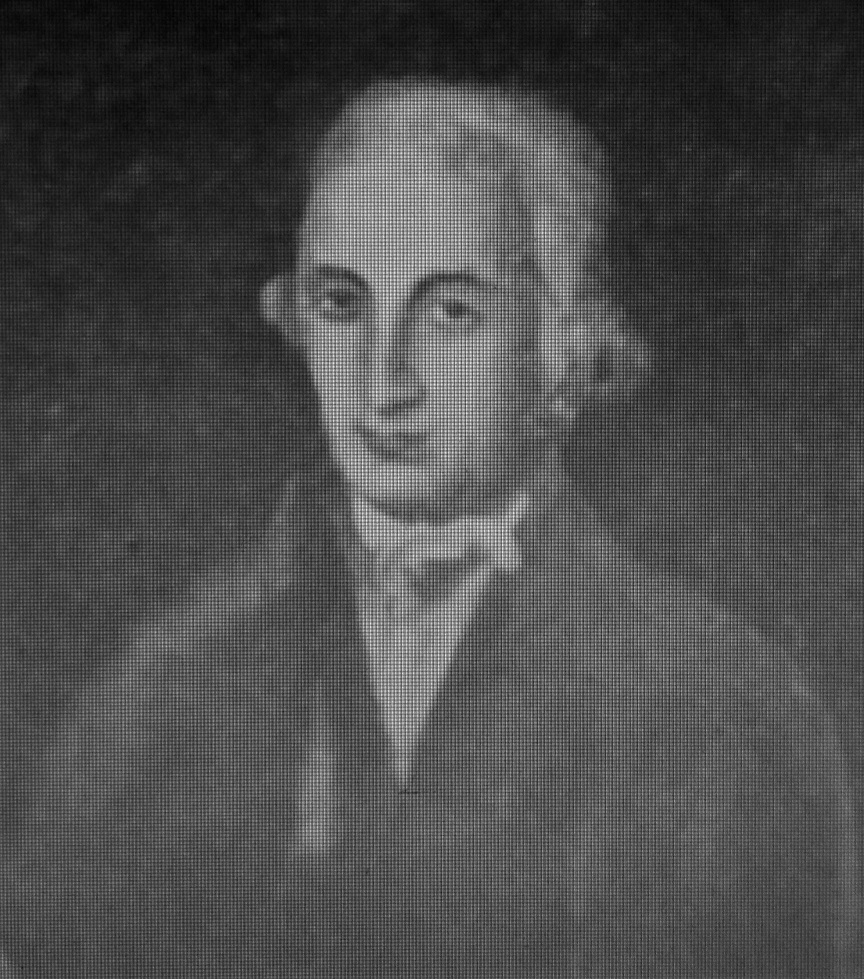Da sempre ho un debole per il pettirosso. Minuscolo e imponente con quella macchia rossa al centro che lo fa sembrare un soldato a petto in fuori. In questi giorni il gelo lo spinge dai boschi alla porte delle abitazioni o sulle ringhiere dei balconi, in cerca di cibo. Mi piace pensare che sia sempre lo stesso: quello di venti o trent’anni fa, e che torni da me perché già allora le briciole dei biscotti o del pane erano a lui destinate. A lui che, poveretto, chissà che freddo soffriva ma con dignità. A lui che forse era triste, nella sua gelata solitudine.
Forse è proprio quello che disegnai alle scuole elementari su un cartellone che poi rimase attaccato alla parete tutto l’anno, insieme alla vendemmia o alla primavera realizzate da altri miei compagni. Un pettirosso enorme su un ramo troppo piccolo per poterne reggere il peso, ma che importava.
Molto dopo sarebbe arrivato Fabrizio De André: un furibondo bisogno di domande più che di risposte, di dubbi più che di certezze, di una prospettiva umana che fosse in grado di regalare una “goccia di splendore” anche all’ultimo della terra. E con lui il “pettirosso da combattimento” dell’apocalittica Domenica delle salme, che si salva dall’incendio della barba del “poeta della Baggina” e indica nella lotta uno strumento di giustizia.
Situazioni distanti che forse non casualmente riaffiorano nella mente, come tessere di un mosaico più grande e misterioso. La ricerca delle radici, il senso della storia e delle storie che Maurizio Maggiani sublima nelle pagine del suggestivo romanzo Il coraggio del pettirosso; il lancinante album di Loredana Bertè (Un pettirosso da combattimento), impreziosito dalla straziante traccia Zona Venerdì, in morte di Mia Martini.
Il pettirosso è il sogno impossibile, deciso nell’inverno che una dolorosa perdita familiare aveva reso più freddo degli altri, per consolare e riscaldare – lui che arriva con il gelo – le anime nostalgiche.
Chissà come e perché sono arrivato fin qua. In fondo volevo soltanto scrivere due parole di augurio per l’anno che stanotte accoglieremo con la stessa identica speranza dell’anno scorso e per salutare quello che in qualche modo sta per finire. Consapevoli di avere fatto ciò che cuore e raziocinio hanno comandato. Senza l’urgenza di un bilancio che forse altri in questi stessi minuti stanno già facendo, disponendo sui piatti felicità e dolore, rimpianti e sogni. Quei sogni che soli possono rendere affascinante l’incognito e che ci spingono ad agire. Che ci fanno uscire dal bosco e danzare nel freddo, per continuare a vivere e per affrontare con coraggio ciò che il futuro ci riserverà.
Suonala ancora
Ogni ricorrenza è un termometro che misura la febbre del tempo. Scotta quando seduti a tavola qualche sorriso manca e, proprio in quei momenti che dovrebbero essere di allegria, il vuoto nella pancia segnala assenze pesanti. Sentimenti che la quotidianità della vita riesce a tenere sopiti, nascosti dal fardello delle troppe cose da fare, si rivelano nudi. Innocenti, fieri, finalmente liberi.
Non si scappa dalle feste e dal loro carico di inevitabile malinconia. Da bilanci personali più o meno definitivi, rabberciati di anno in anno. Dalla speranza che matura i germi del futuro. Dal bisogno di darsi progetti, scadenze, altri traguardi nella corsa senza freni che scava sui volti rughe più profonde, curva le schiene, spruzza neve sui capelli.
Scrutiamo pensierosi l’orizzonte, come i reduci che vi vedono scorrere i fotogrammi di mille battaglie. In cerca di risposte – o soltanto di consolazione – al nostro andare incomprensibile e sorprendente. Un gorgo di dubbi che inghiotte anche il presente, a volere a tutti i costi svelarne il fascino. Domande che sfuggono da ogni parte, come l’aria di un pallone bucato che si cerca invano di tappare con la mano.
Si dirà che non si può vivere ripiegati su se stessi, e probabilmente è vero. D’altronde la solitudine è spesso una conquista effimera, raccattata, che non riesce a tenere a bada l’ansia di risposte definitive agli ostinati “chi siamo”, ai prorompenti “cosa vogliamo”. Siamo troppo impegnati a vivere, per fortuna. Consapevoli del fatto che una vita non basta e che un’altra non ci è data. Una condanna e un’opportunità, a pensarci bene. Perché l’urgenza costringe all’azione: domani potrebbe essere troppo tardi.
Una filosofia che il ragazzino sembra già conoscere quando viene aiutato ad alzarsi dalla sediolina; quando spinge le gambe con tutta la forza che ha in corpo per arrivare faticosamente alla pianola. Un passo dopo l’altro, in una moviola accorata che scaccia via ogni dubbio rendendoci piccoli davanti al sogno impossibile di fare andare con gli occhi quelle leve esitanti.
Lo sa, deve saperlo per forza mentre suona Jingle bells sorretto da mani sicure, tra il silenzio e l’emozione della sala, tutta concentrata sulle sue dita che battono i tasti bianchi e neri: «Suonate campane, suonate tutto il tempo».
E suona anche tu. Per te e per noi. Per la vita che insegni.
Il trovatello Giuseppe Silvani, sconosciuto eroe di Sant’Eufemia
Della prima guerra mondiale si è detto tutto. Fiumi d’inchiostro versati dagli storici per ricostruire le battaglie ed elaborare le statistiche dell’inutile strage. Eppure qualcosa di nuovo, se si continua a cercare, ancora salta fuori. Storie minime, piccole storie dentro la storia grande. Quelle sconosciute dei tantissimi giovani anonimi catapultati dai posti più sperduti dell’Italia nelle trincee del Carso, per combattere una guerra di posizione della quale niente sapevano. Costretti, nel nome della Patria, a patire il freddo e la neve, a lottare con il fango e con i pidocchi, a soffrire la fame e le malattie. Nelle narici il fetore nauseabondo dei corpi in decomposizione dell’orrenda carneficina voluta dalla follia dei comandi militari, il costo umano di poche decine di metri di linea del fronte guadagnate ad ogni offensiva e puntualmente perse nel volgere di pochi giorni.
Di questi eroi per caso poco si sa, soldati analfabeti che non hanno lasciato diari, testimonianze, tracce delle loro esistenze. Per immaginare qualcosa della loro esperienza bellica occorre pertanto affidarsi alle scarne informazioni riportate sulle schede dell’Ufficio notizie e nei ruoli militari. Può capitare così di imbattersi in soldati che, prima di essere spediti al fronte, dovettero subire un processo per diserzione: giovani emigrati all’estero che non avevano risposto per tempo alla chiamata alle armi, ma che rientrarono in Italia e regolarizzarono la propria posizione, svolgendo prima l’addestramento e poi finendo nelle zone dichiarate in stato di guerra.
Anche tra i soldati eufemiesi vi fu chi rimpatriò per servire il Paese “con fedeltà ed onore”. Sfogliando le carte dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, in particolare una storia mi ha colpito più di altre: quella di Giuseppe Silvani, numero di matricola 42357. Un cognome mai udito a queste latitudini ha una sola spiegazione, riportata nel ruolo: “figlio di N.N. e di N.N”. Insomma, un trovatello per il quale la semplice verifica presso lo stato civile del comune fuga il dubbio di un possibile errore nell’indicazione della provenienza.
Giuseppe Silvani nasce proprio a Sant’Eufemia, il 20 febbraio 1893. Dopo qualche giorno sarà Grazia Borrello (“di anni quaranta, pia ricevitrice dei trovatelli”) a raccoglierlo dalla “ruota” del comune, dove presumibilmente la madre l’aveva lasciato. Fino ai primi anni del Novecento anche a Sant’Eufemia funzionò infatti la cosiddetta “ruota degli esposti”, che accoglieva i neonati abbandonati dai genitori per diverse ragioni: figli della vergogna o bimbi ai quali i genitori non erano in grado di garantire nemmeno la sussistenza. I neonati venivano portati di notte nella “ruota”: appena udita la campanella, chi si occupava del servizio la faceva girare verso l’interno, apriva lo sportello e prestava le prime cure all’innocente fagotto tratto in salvo.
Il bambino raccolto da Grazia Borrello – si legge nell’atto di nascita redatto dall’ufficiale di stato civile, nonché sindaco, Antonino Condina Occhiuto – “era avvolto in pochi pannilini [panni ottenuti da lenzuola, camicie, tovaglie] bianchi, con le braccia sciolte e col capo coperto da una cuffietta anche bianca. Fra i pannilini che l’avvolgevano fu trovato un biglietto colla scritta seguente: Questo trovatello si chiama Giuseppe. In vista di che ho imposto il nome Giuseppe ed il cognome Silvani. E poiché in questo Comune manca un pubblico ospizio pei fanciulli abbandonati, ho consegnato il predetto bambino alla locale Congregazione di Carità, la quale avrà cura di affidarlo a buona e onesta nutrice perché l’allevasse”.
Non sappiamo chi abbia allevato il piccolo Giuseppe. Sappiamo però che appena giovinetto egli prende la via del mare, come molti suoi coetanei in cerca di fortuna Oltreoceano. Ha appena vent’anni quando sbarca ad Ellis Island il 15 marzo 1913, dopo la traversata a bordo della “Madonna”, una nave a due alberi capace di trasportare 1364 passeggeri. La chiamata dell’esercito arriva proprio mentre si trova negli Stati Uniti, per cui Silvani non riesce a giungere nella caserma di destinazione entro il termine stabilito. Dichiarato disertore e denunziato al tribunale militare di Bari, una volta rientrato in Italia si costituisce presso il distretto di Reggio Calabria (11 dicembre 1914) e viene lasciato a piede libero in attesa di giudizio. A fine anno la commissione d’inchiesta dichiara il non luogo a procedere per inesistenza del reato, cosicché il 1° gennaio 1915 Silvani inizia l’addestramento nel 41° Reggimento Fanteria e, con l’entrata in guerra dell’Italia, si ritrova sul Carso. In prima linea nella decima battaglia dell’Isonzo con il 1° Reggimento Fanteria, viene ferito alla coscia destra da un colpo d’arma da fuoco sul monte San Marco (23 maggio 1917). Dopo la convalescenza è nuovamente nei campi di battaglia e, l’11 agosto 1918, è protagonista di un’operazione audace che gli vale la medaglia di bronzo al valor militare, con la seguente la motivazione: «Volontario in un’ardita pattuglia riusciva, con grande ardimento e sprezzo del pericolo, a raggiungere una forte posizione nemica e, dopo una violenta lotta corpo a corpo, cooperava alla cattura di alcuni prigionieri che trascinava nelle nostre linee. Monte Asolone quota 1440».
Una medaglia che Silvani mai riceverà, così come le altre due conferitegli alla fine del conflitto: quella “Commemorativa della Guerra 1915-18”, istituita con R.D. 1241 del 25 luglio 1920, e quella “Interalleata della Vittoria”, istituita con R.D. 1918 del 16 dicembre 1920.
Il 20 aprile 1920 Giuseppe Silvani è infatti già nuovamente negli Stati Uniti, appena sbarcato dalla nave “Pannonia”. Qui si perdono le sue tracce e in suolo americano, con ogni probabilità, Silvani morirà, figlio di nessuno ed eroe sconosciuto ai suoi stessi concittadini.
Il puzzle spezzato
Non abbiamo mai conosciuta un’ultima volta, il colpo secco della porta che scuote le pareti: io di qua e tu di là. Magari con l’orecchio attaccato all’anta per sentire i passi che si allontanano o il silenzio sospeso, incerto sul da farsi. Chissà. Neanche il basta altissimo e arduo da scalare a mani nude, le dita che cedono, si arrendono e non fanno andare oltre. Ci proviamo stavolta. Ci proviamo, sì.
L’angoscia dell’addio confonde momenti distanti in un flusso unico che mescola dolore e rabbia. Un fiume che precipita verso il mare e tutto travolge. Siamo due naufraghi che non hanno più la forza di aggrapparsi a un legno, sballottati dalla furia del troppo orgoglio.
Niente sembra più bastarci. Le tue risate e le mie. Il tuo naso freddo di tramontana. La rosa nella valigia accanto ai cioccolatini. Il sole rosso intascato dall’orizzonte, leggero come una carezza sulle guance. La libertà soffiata dalle onde sui nostri corpi profumati di battigia. La vita inventata giorno per giorno, messa insieme a fatica e ora sparpagliata per terra, come i cartoncini di un puzzle spezzato.
Ogni flashback è una discesa nel buco nero del passato. Ciò che per me è stato, dimenticato, confinato nell’angolo delle recriminazioni, degli errori, in fondo delle scelte. E che per te è presente ancora vivo e sanguinante. Sei rimasta là, intrappolata da ciò che poteva essere e non è stato. Un paesaggio di fiaba che avevi sognato e che ancora cerchi, stretta dentro un vestito di ricordi feriti.
Aspetti che io ritorni per prenderti e portarti via, dici. Che io entri nel sogno frantumato e da lì ti tiri fuori. Non so farlo. Avrebbe dovuto farlo quel ragazzo, non può farlo quest’uomo.
Il grido lanciato si spegne nel vuoto, impotente per quanto forte e disperato. L’attesa diventa un tempo circolare di rimpianti che dilatano i minuti della notte e trasformano il sogno in incubo. Notti che furono la magia di un tappeto di stelle srotolato sulle nostre teste, quando ogni respiro era felicità. Quando ci facevamo rapire dal mistero delle costellazioni cercando di decifrare nelle figure indovinate le tracce del destino.
Era nelle nostre mani. Ma il dolore ha bisogno di attenzione, non della rabbia urlata nel ping-pong estenuante delle accuse. Forse non siamo stati all’altezza del sogno. Forse il sogno era impossibile. O forse doveva semplicemente andare così, una vendetta degli dei irritati dalla pervicacia dei nostri sbagli. Mancano persino le parole, fiaccate dal corpo a corpo finale e avide di riposo. Desiderose soltanto di una tregua.
Che inganno il silenzio della notte ricamata di stelle, ora che il tempo è finito. Ora che le nostre facce camminano schiacciate sul marciapiedi, indifferenti all’illusione di bagliori lontani.
L’eufemiese Carlo Muscari, martire della rivoluzione napoletana del 1799
Carlo Muscari, figlio di Francesco e Lavinia Pugliatti, nacque a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 17 marzo 1770. Il ramo paterno apparteneva ad una ricca ed aristocratica famiglia di proprietari terrieri originaria di Melicuccà, che si era trasferita a Sant’Eufemia alla fine del XVII secolo, mentre la madre era una nobildonna reggina. Tra i suoi avi si segnalano un Mercurio Muscari laureatosi a Napoli in diritto pontificio e civile nel 1694 e Giuseppe Maria Muscari (1713-1793), “legato in affettuosa amicizia con Papa Braschi” (Pio VI), che fu procuratore generale dell’Ordine di San Basilio e rettore del convento eufemiese di San Bartolomeo, andato distrutto nel terremoto del 1783 (circostanza nella quale perì anche Francesco Muscari), quando già da due anni era abate perpetuo della chiesa di San Basilio a Roma. E proprio alle cure dello zio paterno fu affidato il giovane Carlo, che nella capitale pontificia compì gli studi umanistici prima di trasferirsi a Napoli, dove si laureò in legge e dove già si trovava il fratello maggiore, avvocato Giuseppe, che curò la formazione anche di un altro fratello, Gregorio: sia Giuseppe che Gregorio furono successivamente autori di opere di diritto molto apprezzate. Nella capitale partenopea, allo scoppio della rivoluzione, i tre furono raggiunti dal quarto dei fratelli, Mercurio.
Nel lavoro dedicato alla massoneria nel Regno delle Due Sicilie, Ruggiero Di Castiglione sottolinea l’adesione di Carlo a una delle logge massoniche fondate dall’abate Antonio Jerocades e il suo coinvolgimento in una congiura giacobina che nel 1794 gli procurò l’arresto e la reclusione nel carcere della Vicaria per “asportazione d’armi proibite, bestemmie, miscredenze, violenze ed altri eccessi”, oltre che per il possesso di “alcuni libri sediziosi francesi”.
Dopo la proclamazione della repubblica napoletana e la costituzione del governo provvisorio degli insorti, Carlo fu tra i sette membri della “Commissione pel piano delle Finanze” e capitano della II Compagnia della Guardia nazionale repubblicana, della quale faceva parte anche un altro eufemiese, il futuro medico Gaetano Capoferro, allora studente presso l’Università di Napoli. Il 20 gennaio 1799 partecipò alla presa del castello di Sant’Elmo, si distinse nelle operazioni che portarono all’arresto di numerosi seguaci del regime borbonico e infine fu trasferito alla Legione Bruzia. Con il fratello Gregorio fu componente della Commissione “degl’informi”, che si occupava dell’epurazione della burocrazia borbonica e della sua sostituzione con un personale fedele al nuovo corso.
Lo storico Vittorio Visalli riferisce che Carlo “combatté aspramente a Torre Annunziata contro Pandigrano e Sciarpa” (rispettivamente: Nicola Gualtieri, un criminale comune condannato all’ergastolo, scarcerato e arruolato nell’esercito sanfedista del cardinale Ruffo, e Gerardo Curcio, che guidò un esercito di sbandati al servizio della causa borbonica). Il fratello Gregorio fu, invece, “l’imperterrito duce” della Legione Calabra, circa duemila calabresi posti a presidio di Castelnuovo e del forte di Vigliena, che il 13 giugno 1799 fu fatto saltare in aria dai giacobini assediati dalle truppe sanfediste. Dopo la capitolazione i repubblicani sbandarono. Carlo, Gregorio e Giuseppe Muscari si asserragliarono nei Castelli. Mercurio, che inizialmente aveva trovato rifugio in un convento, da lì fu costretto a scappare. Carlo e Gregorio furono condannati a morte; Giuseppe e Mercurio all’esilio fuori dal regno. Per i loro beni fu disposta la confisca.
Il trattato di capitolazione sottoscritto il 19 giugno concedeva agli insorti la facoltà di trasferirsi in Francia. Carlo fu così imbarcato sul vascello inglese “Audace”, ma appena arrivato a Napoli l’ammiraglio Nelson ordinò la sospensione del trattato. Mentre Gregorio riuscì a scampare alla forca e a riparare in Francia con gli altri due fratelli, Carlo fu incarcerato e sottoposto a processo. Assolto dalla Giunta di Stato, si scontrò con la volontà del sovrano Ferdinando IV di Borbone, al quale spettava l’ultima parola. Vincenzo Cuoco indica nella condanna di Muscari il paradigma del clima giustizialista instauratosi con il ritorno dei Borboni: «Le sentenze erano fatte prima del giudizio. Chi era destinato alla morte doveva morire […]. Dal processo di Muscari nulla si rilevava che potesse farlo condannare; ma troppo zelo avea dimostrato Muscari per la Repubblica, e si voleva morto. La Giunta, dicesi, ebbe ordine di sospender la sentenza assolutoria e di non decidere la causa finché non si fosse trovata una causa di morte. A capo di due mesi è facile indovinare che questa causa si trovò».
Tra gli ultimi patrioti ad essere giustiziato, Carlo Muscari fu impiccato il 6 marzo 1800 a piazza Mercato e poi sepolto nella chiesa di Santa Caterina ai Funari.
A cent’anni dalla sua morte, l’amministrazione comunale di Sant’Eufemia ne onorò il sacrificio e la memoria: il consigliere provinciale Michele Fimmanò tenne il discorso commemorativo a conclusione del quale, all’interno del municipio, fu scoperta una lapide in marmo: «Tradita la fede dei patti/ da bieca voluttà di tiranni/ CARLO MUSCARI/ milite della Repubblica Partenopea/ moriva strangolato a Napoli/ il 6 marzo 1800/ I cittadini eufemiesi dopo 100 anni/ a ricordo ed esempio».
Andata distrutta dopo il terremoto del 1908, una riproduzione dell’iscrizione fu collocata alla fine degli anni Venti nel palazzo municipale da poco edificato. Purtroppo tra le macerie del palazzo demolito alla fine degli anni Ottanta, è incredibilmente finita anche la lastra di marmo che ricordava un grande eufemiese: nessuno ha pensato di salvarla, nessuno ha sentito il dovere di riprodurla.
*Fonti:
– Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Editore Laterza (1980)
– Ruggiero Di Castiglione, La massoneria nelle Due Sicilie e i “fratelli” meridionali del ’700, vol. III: Dal legittimismo alla cospirazione, Gangemi editore (2009)
– Michele Fimmanò, Carlo Muscari. Commemorazione nel centenario della sua morte, Tipografia Adamo D’Andrea (1900)
– Domenico Forgione, Il cavallo di Chiuminatto. Strade e storie di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Nuove edizioni Barbaro (2013)
– Rocco Liberti, Il nucleo familiare di un martire della repubblica napoletana: Carlo Muscari da Santa Eufemia, in “Rivoluzione e antirivoluzione in Calabria nel 1799”, Atti del IX Congresso storico calabrese, Laruffa editore (2003)
– Vincenzo Mezzatesta, Carlo Muscari di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Capolegione, in “Calabria Sconosciuta”, n. 30 (1985)
– Vittorio Visalli, I Calabresi nel Risorgimento italiano. Storia documentata delle rivoluzioni calabresi dal 1799 al 1862 , G. Tarizzo e figlio (1893)
Sant’Eufemia d’Aspromonte e il terremoto del 16 novembre 1894
Alle ore 19 circa del 16 novembre 1894 è ormai piena notte: se ne hanno la possibilità, le famiglie sono attorno al braciere, oppure già sotto le coperte per non soffrire troppo gli schiaffi dell’inverno. Qualcuno si attarda nelle cantine per un bicchiere di vino, ma la maggior parte della gente si sta per addormentare. Quella notte però non si dormirà, né a Sant’Eufemia, né in molti altri centri pre-aspromontani. E di freddo, nelle strade, ne raccoglieranno parecchio gli sfollati del terremoto che in soli sedici lunghissimi secondi rade al suolo cittadine e villaggi. Il bilancio finale conta 98 vittime e ingentissimi danni, con il triste primato di perdite di vite umane toccato a San Procopio: 48 e il paese ridotto in macerie. Ma è tutto il circondario di Palmi a piangere morte e distruzione: sette vittime a Bagnara (alle quali vanno aggiunte le sei della frazione Solano), otto a Seminara e altrettante a Palmi, epicentro del sisma del 6.1 grado della scala Richter, altre a Melicuccà, Sinopoli, Santa Cristina e Delianuova. Un numero che per Palmi sarebbe stato ben più elevato se in quei giorni la città non fosse stata teatro di un avvenimento che un anno dopo la Chiesa riconobbe come miracolo: il movimento degli occhi della statua della Madonna del Carmine, per oltre due settimane consecutive, che richiamò l’attenzione della stampa anche nazionale. Miracolo o caso, fu infatti proprio la processione organizzata il 16 novembre a fare sì che quasi tutta la popolazione si trovasse per strada quando la terra tremò e le case cominciarono a crollare.
Sant’Eufemia fu semidistrutta. Le vittime furono sette, cinque delle quali risiedevano nel Paese Vecchio, le altre due al Petto: Concetta Bagnato, 37 anni; Grazia Maria Monterosso, 72 anni; Antonino Condina, 36 anni; Maria Antonia Cutrì, 3 anni; Angela Nocito, 88 anni; Natale Occhiuto, 2 anni; Carmina Zagari, 95 anni. Più di 200 i feriti. La chiesa Matrice subì lesioni molto gravi, quella del Purgatorio rovinò parzialmente. Il quartiere Campanella (o “Rocca”) fu quello che subì danni minori insieme al Petto, dove però la chiesa crollò quasi completamente. Le case rimaste in piedi subirono danni talmente gravi da mettere in serio pericolo l’incolumità della popolazione, per cui in gran numero furono successivamente demolite: 212 abitazioni crollarono totalmente, 326 parzialmente, 432 furono gravemente danneggiate e 188 lesionate in modo lieve. I danni furono quantificati in circa due milioni di lire.
Sui luoghi colpiti dal disastro giunsero nei giorni successivi reparti di truppa e squadre di operai sottoposti agli ordini del maggiore del Genio civile Angelo Chiarle, i quali si occuparono della demolizione delle case diroccate, della rimozione delle macerie, del puntellamento della abitazioni recuperabili, della costruzione delle baracche, della distribuzione di indumenti e di alimenti, dello svolgimento di servizi di pubblica sicurezza. Del coordinamento con la prefettura per tutte le operazioni di soccorso si occupò invece il consigliere provinciale Michele Fimmanò, il politico eufemiese più influente dall’Unità d’Italia al primo decennio del Novecento.
A fine febbraio 1895 furono consegnate 64 baracche: la chiesa, l’ospedale, le scuole femminili, il municipio, l’ufficio telegrafico e l’ufficio postale, oltre alle “baracche varie”. Furono inoltre puntellate 32 case, demoliti totalmente 5 fabbricati e parzialmente 64. Un anno dopo, l’area denominata “Pezza Grande” risultava così occupata da un vasto baraccamento strutturato con strade, piazze, una chiesa e una rivendita di privativa, che ospitava più di 200 famiglie e che costituì il primo nucleo urbano dell’assetto che Sant’Eufemia avrebbe definitivamente assunto dopo il terremoto del 1908, quando fu edificato l’intero omonimo rione.



* Tutte le fotografie sono tratte da “Il terremoto del 16 novembre 1894 in Calabria e Sicilia. Relazione scientifica della Commissione incaricata degli studi dal Regio Governo”, Roma 1907. In apertura, il campanile diroccato della chiesa del Purgatorio; a fine articolo, nell’ordine: case rovinate; chiesa del Petto; chiesa del Purgatorio.
Ballando sotto la pioggia
Il mio recente post Impressioni di Londra ha convinto Mario a raccontare qualcosa della sua esperienza di giovane “scappato” dall’Italia quasi vent’anni fa e accolto da una città che gli ha dato la possibilità di non rimpiangere niente di quella scelta. Ho sempre pensato che ci vuole molto coraggio per abbandonare questa nostra martoriata terra, tanto quanto ne serve per restare. [D.F.]
La mia storia d’amore con Londra cominciò una piovosa notte di giugno del 1997. Era il 16 giugno, per essere esatti. Due settimane prima avevo comprato un biglietto di sola andata, così, d’impulso, dopo aver letto un articolo sulla capitale inglese dove, tra le altre cose, mi si assicurava che avrei trovato lavoro in due secondi.
Avevo 22 anni. Da marzo mi trovavo a Milano, dove ero giunto proveniente dalla Sicilia dopo un viaggio in treno di 23 ore, ovviamente senza biglietto, il mio posto tra il corridoio ed il bagno, in una nuvola di fumo di sigarette. Come un “vu cumprà” terrone senza vergogna, vendevo prodotti inutili porta a porta, mentre mamma pensava fossi a Palermo a studiare psicologia. Conseguentemente, mia madre non crede a ciò che le dico da 19 anni. In verità, la mia carriera universitaria durò quattro mesi, il tempo di capire che avrei avuto almeno 30 anni prima di riuscire a guadagnare qualche soldo. Cosa per me impensabile, avendo assaporato l’indipendenza economica già a vent’anni, quando guadagnavo uno stipendio giocando alla guerra come sottotenente dell’esercito.
Quando arrivai a Londra, tutto il mio mondo in una singola valigia, mi resi conto di non capire una parola di inglese. Subito dopo mi ricordai di non avere un biglietto di ritorno. Panico, per cinque minuti. Le mie preoccupazioni hanno sempre una vita breve. Giunsi al mio ostello dopo essermi perso due volte in Underground: almeno per un tetto avevo avuto il buon senso di prenotare tutto tramite un’agenzia italiana.
Avrei diviso una stanza con tre sconosciuti. Uno di loro sarebbe poi diventato uno dei miei migliori amici. La prima notte mi portò a Piccadilly Circus a ballare sotto la pioggia “perché a Londra puoi fare quello che ti pare, quando ti pare”: una frase che non ho mai dimenticato e che negli anni mi ha spinto ad osare, a tentare di riuscire in “altro”, cose che in Italia non avrei mai considerato.
Essere via ti libera. Per me è stato come stare di fronte ad una tela bianca, pennello in mano, e cominciare a dipingere la mia vita, come la volevo io e non come se la immaginavano ed aspettavano gli altri.
Il mio primo lavoro non lo trovai in due secondi ma in due giorni, giusto in tempo, perché non avevo più soldi. Il 1997 fu un attimo, terminato a Trafalgar Square, arrampicato su un monumento ad aspettare la mezzanotte sopra un mare umano. Lavoravo in un McDonald’s dalle 7 del mattino alle 15.00, poi in un Pub dalle 18.00 alle 23.00 ed infine in strada dalle 23.30 all’una di notte, a fare volantinaggio per una discoteca dove il sabato notte vi lavoravo come cubista(!). Poi si usciva in centro. Dormivo pochissimo ma non importava, perché non dovevo chiedere niente a nessuno. Finalmente libero, ero felice.
Per me la felicità è sapere che puoi contare sulle tue forze per “arrivare” da qualche parte, che si può vivere senza dover chiedere favori e che se ti va, puoi lottare per conquistare la tua parte di mondo, senza compromessi, perché se hai delle qualità ti verranno non solo riconosciute ma anche valorizzate. Negli anni ho fatto di tutto, da elfo nei magazzini Harrods a poliziotto nella polizia metropolitana, da manager in un locale ad impiegato bancario, oltre ad altro di cui non parlo per scaramanzia ma che amo.
Ho vissuto a Melbourne, a Malta, a Los Angeles; spendo tanto tempo ad Havana e giro il mondo per lavoro, ma solo a Londra mi sento completo. Solo a Londra mi sento a casa. A Londra sono maturato nell’uomo che sono. A Londra ho trovato me stesso.
Ecco, potrei morire domani e morirei in pace, senza rimpianti. Da quella prima notte a Piccadilly Circus, non ho mai smesso di ballare sotto la pioggia.
[Mario Forgione]
Un ricordo dell’alluvione del 1966
Le rievocazioni del cinquantesimo anniversario dell’alluvione che il 4 novembre 1966 devastò Firenze si sono concentrate per lo più sul ricordo dei danni prodotti dagli straripamenti dell’Arno. Le 35 vittime, gli sfollati, l’intervento degli “angeli del fango”, giovani di tutte le nazionalità accorsi a migliaia nel capoluogo toscano per strappare al fango i libri e i manoscritti della Biblioteca Nazionale o le opere d’arte dei depositi degli Uffizi rovinati dall’inondazione: su tutte il Crocifisso di Cimabue nella Basilica di Santa Croce, assurto a simbolo dell’alluvione.
In realtà, già da diverse settimane, diverse aree del Centro Italia e del Nord-Est registravano un’eccezionale ondata di maltempo, con esondazioni e frane che raggiunsero l’apice tra il 3 e il 4 novembre. Il bilancio finale, consultabile sulla pagina Polaris (popolazione a rischio da frana e da inondazione in Italia), a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, è impressionante: oltre 130 morti, quasi 400 feriti e poco meno di 78.000 tra sfollati e senzatetto, 1.000 miliardi di lire di danni. Non solo, quindi, gli 11 metri di livello raggiunti dall’Arno, ma anche il record d’acqua alta a Venezia (194 centimetri), l’esondazione del Piave, del Brenta e del Livenza nel Veneto, del Tagliamento nel Friuli e dell’Adige nel Trentino, dell’Ombrone nel Grossetano, di molti fiumi e canali dell’Emilia Romagna, in particolare nel Modenese.
Lo sforzo solidaristico degli angeli del fango e il lavoro incessante delle forze armate, giorno e notte, nelle aree colpite. Giovani che svolgevano il servizio militare e che nei giorni dell’alluvione diedero un contributo fondamentale per il salvataggio delle vite umane in pericolo. Tra i soldati del 18° Reggimento artiglieria contraerei – di stanza presso la caserma “Giulio Cesare” di Rimini – c’era anche mio padre. La sua compagnia fu destinata al soccorso delle popolazioni nelle aree attorno a Rimini e a Forlì: riempire sacchi di sabbia, trasportarli e accatastarli uno sull’altro per arginare le esondazioni dei fiumi; far muovere le barche piatte da fiume a fondo piatto puntando le pertiche contro il fondo, raggiungere i casolari isolati per trarre in salvo i feriti e coloro che si erano arrampicati sopra i tetti.
A tutti i militari impegnati nell’opera di soccorso fu successivamente consegnato un volumetto contenente i ringraziamenti inviati dalle istituzioni civili e religiose al Generale di corpo d’armata – Comandante la regione militare Nord-Est («Questi ringraziamenti e questi elogi vanno a Te, soldato d’Italia, che per i Tuoi fratelli colpiti dalla sventura hai duramente lavorato, con sacrificio e nel pericolo; e hai dato prova di profondo sentimento del dovere e di alta solidarietà umana») e un attestato di benemerenza firmato dal ministro della Difesa Roberto Tremelloni:
«In un’ora di dolorosi eventi suscitati dalla furia di forze della natura scatenate su vasta parte del territorio nazionale, soldati, marinai ed avieri d’Italia, memori del dovere che li vuole al costante servizio del Paese sia in pace che in guerra, hanno impegnato ogni loro risorsa ed energia per la salvezza delle vite in pericolo, la lotta contro l’epidemia e la rinascita delle speranze, in una umana gara di generosità, di dedizione e di sacrificio. Per questi combattenti di una lotta senza quartiere contro lo sfacelo apportato dalle acque, desidero unire al sentimento degli infelici che essi soccorsero, aiutarono ed incoraggiarono, la meritata calda lode delle Istituzioni Militari che tanto degnamente hanno rappresentato nell’adempimento del civico dovere».
Impressioni di Londra
Un viaggio è un puzzle di immagini spolverate sulla mente come zucchero a velo, che il tempo avrà cura di soffiare lontano, inevitabilmente. Restano le impressioni che lo spettacolo della vita concede a chi sa e vuole fermarsi un attimo, anche soltanto per rafforzare il ricordo facendolo vivere un po’ più a lungo. Conservare le emozioni del paesaggio, dei volti, della folla anonima che nella metropoli incede indistintamente, quasi sempre di fretta, fiumana umana in movimento verso mete che non sapremo. Per questo affascinanti.
Nel mio breve soggiorno londinese ho camminato. Ma proprio tanto. Dalla mattina alla sera, di notte. Il contapassi di Pasquale a un certo punto non smetteva più di congratularsi! Un cammino per lo più allegro, da turista, ma anche penoso e doloroso quando ha sbattuto contro la solitudine della morte, la vera ragione della nostra trasferta. Nelle scelte di vita bisogna entrarci in punta di piedi, con rispetto e discrezione, pertanto non scriverò di Peppino “Joe” Conte. E non perché il dolore degli altri è “dolore a metà”, ma perché so che la vita Joe l’ha gustata per intero – come l’ape con il fiore – e se n’è andato senza rimpianti, soddisfatto dei suoi 84 anni avventurosi, per certi versi cinematografici. Abbiamo bevuto alla sua salute e, se da qualche parte Joe ci stava osservando, sono certo che avrà sfoderato il suo inconfondibile e paffuto sorriso.
Volti che sfumano, dicevo. Dell’alcolista che alle due di notte chiede 40 penny per onorare il venerdì londinese. Del ragazzo con la lattina vuota che cerca l’elemosina davanti a una chiesa anglicana, accanto a un cimitero di sole croci rovinate dal tempo e di scritte annerite su rettangoli di marmo rotto. Della donna che dorme dentro al sacco a pelo, abbracciata al suo cane, in un riparo di strada trafficatissimo accanto a Westminster.
Ma anche le facce sorridenti dei cinque ragazzi di differenti etnie che arrivano a Piccadilly Circus, con una corda perimetrano una porzione di suolo all’uscita dell’Underground e per qualche ora replicano uno spettacolo di danze e salti acrobatici sulle note di “Gangnam Style” per un pubblico che si rinnova al ritmo scandito dagli arrivi della metro. Gli artisti di strada che a Covent Garden si esibiscono per centinaia e centinaia di bambini rapiti dalla magia e dall’abilità dei giocolieri, stupiti dall’impassibilità delle statue viventi color oro o argento che si animano come per incanto. I visi allegri dei frequentatori delle botteghe dei barbieri nigeriani, aperti anche di notte perché i “Barber Shop”, nella cultura centroafricana, sono veri e propri spazi ricreativi, nei quali c’è chi si ferma anche soltanto per assistere all’ultima puntata della telenovela del momento.
Le voci e gli accenti si accavallano ma sembrano fondersi in un linguaggio universale che tiene insieme le tessere di un mosaico fatto di volti colorati e allegri nel centesimo selfie della giornata. Il contrasto tra miseria e benessere fa riflettere su quanto l’uomo sia davvero artefice del proprio destino, in una città che comunque ha una marcia in più. Che a tutti, soprattutto ai giovani, sembra essere in grado di offrire una possibilità.
Quella maledetta domenica che si portò via il Sic
Per qualche anno ho gestito un secondo blog, nel quale scrivevo quasi esclusivamente di Inter: un blog da tifoso, con l’immancabile rubrica del commento alle partite e amenità varie, ma che ogni tanto utilizzavo anche per commentare eventi di altre discipline sportive. Oggi che ricorre il quinto anniversario della sua tragica morte sul circuito di Sepang voglio ricordare Marco Simoncelli con il post che scrissi allora.
Mentre ero in volo, di rientro da Londra, pensavo che sarebbe stata una delle poche domeniche in cui non avrei visto alla Tv la partita dell’Inter. Sarei riuscito ad ascoltare gli ultimi minuti di radiocronaca in macchina, di ritorno dall’aeroporto di Lamezia. Ed infatti è andata così. Proprio per questo motivo avevo pensato di scrivere qualcosa su questa esperienza inedita e antica allo stesso tempo. Sarebbe stato un tuffo nel passato, un amo lanciato nel mare dei ricordi dell’infanzia per ripescare un mondo senza Sky né Mediaset. Un tempo in cui del cartello delle partite, disputate tutte rigorosamente di domenica, riuscivamo a vedere – e con quale attesa! – soltanto la differita del secondo tempo dell’incontro di cartello su Rai 2 verso le 19.00, dopo i saluti di Paolo Valenti dietro la scrivania del suo “Novantesimo minuto”, su Rai 1.
Avrei raccontato di ragazzini attorno a una radiolina e dei “grandi” sulle auto parcheggiate davanti alla pineta comunale, al municipio, ai bordi delle piazze, accanto ai marciapiedi. Delle vecchie schedine del totocalcio con le matrici che andavano benissimo per aggiornare i risultati e che passavano di mano in mano, in una sorta di rito collettivo che dà l’idea di quanto il calcio fosse davvero un romanzo popolare.
Appena entrato in casa, invece, dopo i saluti è arrivata la domanda di mia mamma. Una domanda che nel tono delle parole e nell’espressione del viso conteneva già la risposta: «Hai saputo di Simoncelli?».
Stamattina, mentre preparavo le valigie, con un occhio seguivo nella televisione la gara di Moto2. C’era stato un incidente che aveva coinvolto lo spagnolo Axel Pons, con la conseguente sospensione della gara a due giri dal termine. «Pista pericolosa», mi ero detto.
Le parole di mia mamma sono state un déjà-vu, la mia mente è corsa all’incidente in cui perse la vita Ayrton Senna, nel Gran Premio di San Marino. Allora, durante le prove, era morto Roland Ratzenberger, mentre Rubens Barrichello si era salvato per miracolo. Incidenti premonitori, anche in quel caso, che anticiparono la morte di uno dei più grandi piloti di sempre. Un personaggio amatissimo, come lo era il Sic.
Mancano le parole per descrivere la tragedia che si porta via delle giovani vite. Da domani si parlerà di sicurezza, del gioco che forse non vale la candela, di ragazzi che hanno tutto – soldi, successo – e che ogni tanto perdono tutto in una curva maledetta o per un guasto meccanico.
Da domani si parlerà anche – ed è giusto che sia così – di Marco Simoncelli, del suo essere irregolare e solare: sempre con il sorriso, un po’ guascone, duro quanto serve per sgomitare in pista e staccare un secondo dopo l’avversario. Quel secondo che ti consente di passare davanti e di mandare il pubblico del tuo show in delirio. Un ragazzo che nel paddock era amato per la sua allegria, per i suoi scherzi, per il suo non prendersi mai troppo sul serio. Per essere, in fondo, un giovane innamorato della vita.
Ora però è bene che si fermi tutto. Ci sarà tempo per altri articoli. Ora è il tempo del dolore e del rimpianto per una vita spezzata nel fiore degli anni.
[23/10/2011]