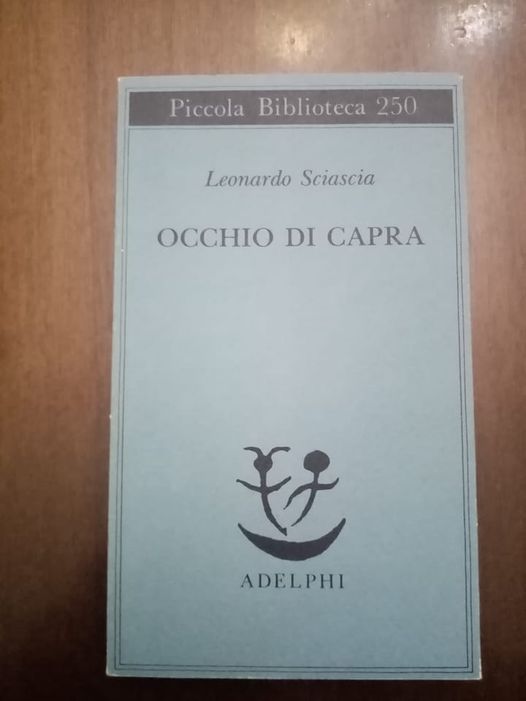Un murales realizzato dal celebre street artist Banksy raffigura l’evasione di un carcerato, che si cala dal muro di cinta dell’ex prigione di Reading utilizzando una corda di lenzuola annodate e legate, nel tratto finale, a una macchina da scrivere. L’opera fa riferimento alla reclusione dello scrittore Oscar Wilde nel carcere della cittadina del Berkshire tra il 1895 e il 1897, che ispirò il componimento “The Ballad of Reading Gaol”, incentrato sui temi della pena di morte e del senso di alienazione generato dalla ripetitività delle azioni compiute quotidianamente da un detenuto.
I carcerati vivono un tempo sospeso, regolato da orologi privi di lancette che scandiscono il nulla. Quando si esce, al termine di una detenzione più o meno lunga, ci si rende conto che non si è vissuto, che una mano ha lavorato di gomma sopra un tratto della propria vita. Che un blackout ha spento la luce. Dove c’era vita, resta un buco nero.
La scrittura è una forma di evasione, ma è soprattutto una strada che può portare alla salvezza. Nel carcere, scrive Erri De Luca in “A grandezza naturale”, «…si scrivono ancora le lettere, carta, penna, inchiostro, busta, francobollo e giorni di viaggio tra mittente e destinatario. Si farebbe prima coi piccioni viaggiatori. Al prigioniero serve almeno un indirizzo oltre le mura. Chi non ne ha sta in una penitenza più profonda. L’ora d’aria basta da sola a dire che le altre ventitré sono asfissia».
Le lettere prendono in braccio il detenuto e lo sollevano al di sopra della recinzione, sono un ponte di umanità tra il dentro e il fuori. Nella realtà odierna, caratterizzata dall’immediatezza della comunicazione e dell’interconnessione con gli altri, tutto ciò può sembrare anacronistico. Le relazioni sociali del carcerato conservano il ritmo lento di un’epoca che oggi ci appare lontanissima, con attese di giorni o di settimane per fare sapere come si sta e cosa si fa, per avere notizie su ciò che fuori accade.
Per tale ragione è meritorio il progetto natalizio “Parlami dentro”, della “Fondazione Vincenzo Casillo” e di “Liberi dentro – Eduradio&TV”: un invito (“una chiamata alle parole”) a scrivere entro l’11 dicembre una lettera ad una persona detenuta sconosciuta, indirizzandola all’indirizzo email parlamidentro@gmail.com.
Spesso si hanno delle remore a scrivere a soggetti carcerati, anche quando si tratta di familiari o di conoscenti. Per lo più perché non si sa “cosa” scrivere. In realtà non occorrerebbe un grande sforzo di fantasia. Il detenuto lotta per sentirsi ancora vivo e, pertanto, è della vita che bisogna scrivergli. Di quel progetto che si ha in animo di realizzare. Del libro letto e del film guardato. Dell’ultimo viaggio. Della corsa di un cane. Dei progressi di un bambino. Del paesaggio che muta al cambiare delle stagioni. Dei funghi trovati. Delle imprese sportive che ci hanno emozionato. Di una ricetta sperimentata con successo. Della rosa sbocciata nel giardino. Del nuovo taglio di capelli. Si potrebbe continuare all’infinito, con tutte le azioni e le emozioni che riempiono le nostre esistenze.
In galera i giorni più pesanti sono quelli festivi. Il recluso sa che non riceverà nessuna lettera, mentre negli altri giorni della settimana può sperare che qualcuno si sia ricordato di lui. Quando si avvicina l’orario della consegna delle lettere, viene preso da una sorta d’ansia (“chissà se c’è qualche lettera per me?”), attende il passaggio dell’agente con il cuore in gola, torna sconsolato sulla branda se il suo nome non viene chiamato.
Sentire che fuori c’è qualcuno che lo pensa è per il detenuto un’iniezione di forza e ragione di vita, antidoto potente contro lo scoramento che in alcuni casi può portare a gesti estremi, come purtroppo conferma il dato drammatico dei suicidi in carcere, 71 dall’inizio dell’anno.