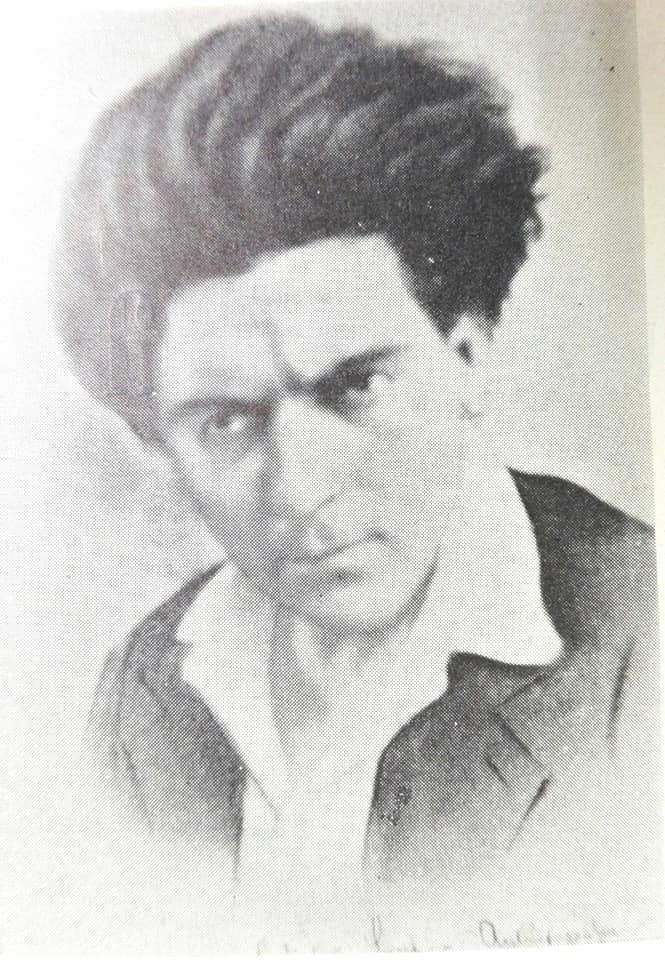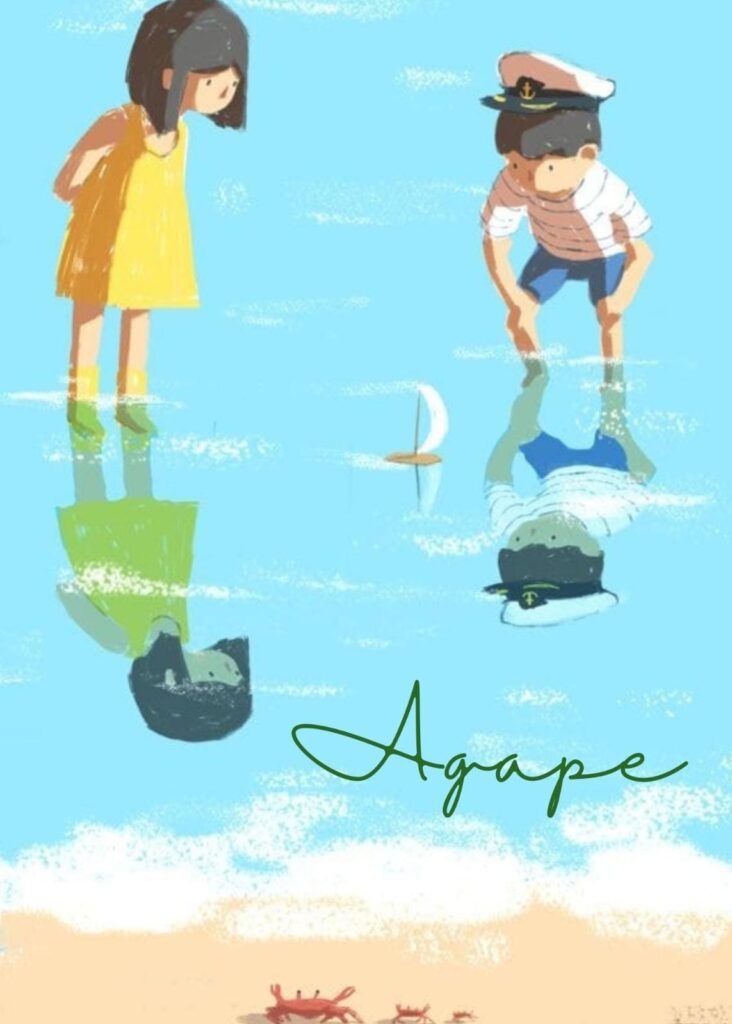
«No casa, no casa». Non sappiamo se il rientro dall’ultimo giorno di colonia dell’Agape sia stato più duro per il nostro nuovo amico o per i volontari. E pensare che l’impatto era stato quasi traumatico. Sì, perché N., otto anni e gli occhi di chi ne ha viste tante per la sua poca età, al mare non ci era mai andato. La sabbia dentro le ciabatte brucia, lui non conosce questa sensazione. Tocca ad un volontario caricarselo in braccio con tutta la ciambella e portarlo in acqua. Ma non vuole entrare perché ha paura, strilla. Occorre pazienza, sedersi sulla battigia e bagnarsi a malapena i piedi. Si calma, anche se lo spavento torna quando un’onda più lunga gli arriva sulle gambe e sale sul pancino. Piange nuovamente. I volontari sono testardi, sanno aspettare. Il bambino non conosce nessuno, è il loro primo incontro. Ci deve prendere confidenza, come con l’acqua del mare. La fiducia arriva piano piano, seduti sulla riva, fino a quando N. non si lascia prendere in braccio e fa ingresso nella vasta distesa blu aggrappato al collo del suo bagnino personale. È fatta. Ora il mare è uno spazio accogliente, N. addirittura imita il volontario che fa la fontana con la bocca e per tutti i restanti giorni sarà un’impresa riuscire a convincerlo, quando arriva il momento di uscire. Anche se fuori si diverte con paletta, secchiello e formine, il pallone di diversi colori.
La magia delle colonie estive dell’Agape è il moltiplicatore d’amore che si sviluppa tra volontari, ragazzi e chi “si trova a passare”: una compagnetta di giochi che non teme il mare agitato, la mamma che regala a N. lo zainetto di Spiderman, la coppia che dà una mano e che R. chiama “u papà” e “a mamma”. Proprio lui che quest’inverno ci aveva fatto tremare e aveva annuito quando, andando a fargli visita, lo avvisammo: «Vedi di riprenderti, che in estate dobbiamo andare al mare». È stato di parola.
Parlare di volontariato è importante: non è vanità, né una forma di autocompiacimento per dire “guardate quanto siamo belli, buoni e bravi”. Serve per attivare sinergie positive di fronte a situazioni di bisogno che esistono, ma che non si possono conoscere se non si ha un “gancio”, se non ci si sporca le mani, se non si entra nelle case. Ed è motivo di orgoglio, per tutti noi, constatare la fiducia delle famiglie che da venticinque anni ci affidano ragazzi da assistere con un’attenzione particolare. È ciò che è successo quest’anno con N., grazie alla segnalazione di un’insegnante della scuola elementare.
Il senso di “fare rete” sta nella collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità. Sta nella generosità della Scuola dell’infanzia paritaria “Padre Annibale Maria di Francia”, che ha messo a disposizione dell’associazione un mezzo di trasporto. Sta nel contributo di tutti coloro che partecipano alla raccolta di fondi nel tradizionale veglione di fine anno, grazie alla quale l’Agape finanzia la colonia estiva.
Ogni edizione ha la sua canzone. L’hit di quest’anno è stata “Supereroi” di Mr. Rain, intonata da grandi e piccoli lungo il tragitto che da Sant’Eufemia conduce a Bagnara: «Non ho molto da darti, ma ti giuro che camminerò a un passo da te».