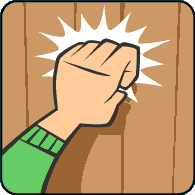Ci sono istantanee che fanno parte dell’album sentimentale di una nazione. Una di queste immortala – sull’aereo che, nel luglio del 1982, riportava in Italia gli eroi del Bernabeu – la partita a scopone tra il presidente della Repubblica Sandro Pertini e il capitano Dino Zoff contro il commissario tecnico Enzo Bearzot e il “barone” Franco Causio. Sul tavolo, la coppa del mondo conquistata a Madrid. Ora che il vecio se n’è andato, è inevitabile farsi prendere dalla nostalgia per quello che eravamo 28 anni fa. Per un bambino di nove anni, Bearzot era un nonno burbero, di quelli severi nell’educazione dei nipotini, pronti al rimprovero quando sentono una parolaccia o notano la mancanza di quel rispetto dovuto alle persone anziane. Me lo immaginavo così, Bearzot: stretto in quella giacchetta bianca e con l’inseparabile pipa in bocca.
Non era iniziato bene il mondiale degli azzurri. Tre pareggi striminziti contro Polonia (0-0), Perù (1-1, gol di Bruno Conti), Camerun (1-1, gol di Ciccio Graziani) e il passaggio al secondo turno, in un girone di ferro contro l’Argentina di Maradona e Ardiles e il Brasile di Falcao e Zico (ma anche di Socrates, Junior, Cerezo). La critica e gli italiani, al solito feroci con chi è in disgrazia (sempre pronti, di contro, “a soccorrere il vincitore”, come infieriva Ennio Flaiano) sparavano quotidianamente contro gli azzurri. Per la prima volta nella storia del calcio italiano fu adottato il silenzio stampa. A parlare con i giornalisti, soltanto Zoff e Bearzot, entrambi friulani, entrambi taciturni. Come spesso accade all’Italia quando è affacciata sul baratro, la squadra si compattò attorno al commissario tecnico e riuscì a realizzare l’impresa: 2-1 all’Argentina (Cabrini e Tardelli); 3-2 al favoritissimo Brasile (tripletta di Rossi); 2-0 alla Polonia in semifinale (doppietta di Rossi); apoteosi finale con il 3-1 alla Germania (ancora Rossi, l’urlo di Tardelli, il sigillo finale di “spillo” Altobelli, che per l’unica volta nella sua carriera esultò alzando entrambe le braccia, abbandonando la consueta compostezza del solo indice puntato verso il cielo).
L’epopea poetica di quel gruppo di eroi passa attraverso la cantilena della formazione, in un’epoca in cui ancora era possibile mandarla giù a memoria, visto che giocavano sempre gli stessi per anni: Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani. Ancora il binomio calciatore/velina non esisteva e gli atleti non somigliavano a modelli di Armani: non avevano acconciature strane (al massimo, il cespuglio di capelli di Collovati), non si facevano tatuaggi, non si tiravano le sopracciglia (indimenticabile il “sopracciglione Bergomi” di Teo Teocoli). Me li immaginavo come guerrieri omerici: il carisma del quarantenne Zoff, l’ardore di Gentile (chiedere a Maradona e Zico, in tempi in cui – va ammesso – gli arbitri estraevano i cartellini con parsimonia), l’eleganza di Collovati, la classe di Scirea, la modernità di Cabrini, l’universalità dell’insonne Tardelli, il genio di Conti (il più “brasiliano” degli azzurri), la cocciutaggine di Graziani, il fiuto di “Pablito” Rossi, le geometrie di Antognoni, i polmoni di Oriali (celebrati anche da Ligabue). E poi Marini, Causio, Altobelli, il diciottenne Bergomi, (lo “zio” che nascondeva la sua età dietro due incredibili baffoni neri), che disputò anche la finale al posto dell’infortunato Antognoni. Quell’11 luglio eravamo una cinquantina “da Mario”, i più piccoli a gambe incrociate per terra, gli altri dietro, seduti nelle sedie o in piedi. Il televisore, un Phonola 28 pollici issato a un metro e mezzo d’altezza, non consentiva la visione degli attuali 52 pollici hd a schermo piatto, soprattutto ai più distanti. Ma l’emozione e l’entusiasmo sono incancellabili. Pertini che, al suo solito, accantona l’aplomb istituzionale e fa il tifoso in tribuna, i minuti finali concessi al fedelissimo Causio, la commozione di Nando Martellini al triplice fischio con quel “campioni del mondo” ripetuto tre volte. Poi tutti di corsa fuori dal bar, a piedi verso piazza Municipio, con le bandiere e il cuore che andava a mille.
La prova di forza
Verrebbe da rispolverare il “rieccolo” affibbiato da Indro Montanelli ad Amintore Fanfani, l’esponente aretino della Democrazia Cristiana sei volte presidente del Consiglio, tre presidente del Senato, una sfilza di incarichi in mezzo secolo di carriera, reso celebre per la capacità di risorgere proprio quando appariva in declino e fuori dai giochi. Come la mitologica araba fenice, rinata dalle proprie ceneri dopo la morte. Da questo punto di vista, tralasciando le facili ironie sul comune aspetto “brevilineo”, la similitudine è calzante.
Appuntarsi il nome dei perfetti sconosciuti che con una piroetta magistrale hanno compiuto il salvataggio del governo può essere utile per contabilizzare il degrado morale di questa classe politica. Ma nulla più, considerati i molteplici precedenti storici. Semmai, ripropone più forte la questione della necessità di riformare l’attuale legge elettorale, per restituire al popolo il potere effettivo di scegliersi i propri rappresentanti: l’unico modo per potere così “punire” i Calearo, i Cesario, i Razzi, e gli Scilipoti di turno. Riposto nel cassetto il pallottoliere, occorre invece individuare il significato politico del voto di fiducia. La vittoria numerica di Berlusconi è incontestabile, così come sembrano decisamente mortificate le ambizioni di Fini. Ma una vittoria numerica non si trasforma necessariamente in vittoria politica. Lo si vedrà con chiarezza nei prossimi giorni, quando la Camera diventerà un campo minato per un governo senza maggioranza nelle Commissioni e che, di fatto, è “di minoranza”. Non soltanto perché la soglia dell’autosufficienza è a quota 316, ma soprattutto perché circa trenta parlamentari con incarichi nell’esecutivo raramente si fanno vedere a Montecitorio. In soldoni, ciò significa che l’approvazione di qualsiasi provvedimento legislativo sarà subordinato all’accordo con l’opposizione, che ne approfitterà per fare passare i propri emendamenti, indebolendo così di molto l’azione governativa.
Viene quindi da pensare che l’obiettivo reale della prova di forza voluta da Berlusconi non fosse il proseguimento di questa esperienza governativa, bensì la riaffermazione della propria leadership, per tenere il mazzo, distribuire le carte e non essere fatto fuori da una congiura di palazzo. Dalla posizione di forza acquisita, Berlusconi può ora condurre il gioco indirizzandolo verso le sole due ipotesi per lui accettabili: una crisi pilotata che conduca al suo reincarico e all’allargamento della maggioranza; in alternativa, le elezioni anticipate. Eppure, nonostante l’affermazione muscolare del premier, il ciclo storico e politico iniziato nel 1994 può ritenersi concluso. L’immagine che ci viene consegnata è quella di un leader barricato dentro il bunker, con a fianco il solo Bossi nel doppio ruolo di protettore e ispiratore, mentre all’esterno il paese “reale” non corrisponde più alle foto idilliache dei tanti opuscoli di propaganda giunti in questi anni nelle case degli Italiani. Come è stato da più parti osservato, quella di Berlusconi rischia di rivelarsi un’effimera vittoria di Pirro.
Una chiacchierata inattesa e salutare
I problemi delle associazioni sono risaputi: c’è la crisi delle “vocazioni”, poco ricambio e sempre gli stessi a tirare la carretta. Eppure l’associazionismo continua a rappresentare una straordinaria risorsa. Basti pensare a tutte le manifestazioni che annualmente vengono organizzate, all’aggregazione che si crea, a quel senso di appartenenza che fa sentire ognuno parte di una grande famiglia e protagonista di un progetto utile per la comunità. Come avviene da tantissimi anni, ad esempio, con l’Associazione culturale “Sant’Ambrogio”, della quale il 12 dicembre ricorreva il 35º anniversario, una data che sarebbe stato doveroso onorare e che è invece passata tra l’indifferenza generale. Sant’Eufemia deve tanto alla “Sant’Ambrogio” e a “Vincenzino” Fedele, un uomo minuto e tenace, costantemente occupato in qualche progetto a dispetto della non più verde età. Compagnia teatrale, gruppo folcloristico, mini festival, carnevale, sagre, esposizioni di lavori artigianali, manifestazioni sartoriali, festa della famiglia, gite, la rivista “Incontri”. La “Sant’Ambrogio” è stata tutto questo e, per alcune iniziative, lo è ancora. Non solo. È stata una fucina di volontari che poi hanno messo a disposizione di altre associazioni quell’esperienza. Se dovessi scegliere cosa riproporre, non avrei alcuna esitazione: “Incontri”. Per una questione sentimentale (vi scrissi il mio primo articolo, a diciotto anni), ma soprattutto perché sono convinto che al paese sia utile “quello” strumento di approfondimento e di crescita culturale.
Qualche giorno fa ho casualmente preso parte, insieme ad un gruppo di amici impegnati nell’associazionismo eufemiese, ad una conversazione con Rocco Cutrì, neo-assessore alla cultura, sport, spettacolo, turismo e protezione civile. Quale migliore interlocutore per discutere dei problemi delle associazioni e del rapporto con le istituzioni? Il confronto è stato piacevole e, ritengo, anche proficuo, perché la conversazione è sempre produttiva quando si è inclini all’ascolto. Sulla recente manifestazione svoltasi in paese (“Sant’Eufemia ti premia”), è emersa qualche critica, nonostante il riconoscimento della validità di un’iniziativa che, riproposta, potrà andare meglio se si correggeranno gli aspetti – soprattutto quello logistico – rivelatisi inadeguati in questa edizione.
Conoscevo l’uomo Rocco Cutrì e sulla sua serietà non credo sia possibile eccepire. Ho scoperto ora l’assessore: un amministratore aperto al dialogo e al confronto che ha delle idee, tanta voglia di fare e nessun timore di mettersi in gioco.
Non è piaggeria. Piuttosto, la rivendicazione di una libertà di pensiero che alcuni non riescono a comprendere, né ad accettare, annebbiati come sono da un miope manicheismo. Pare infatti che il mio articolo sull’ultimo consiglio comunale abbia provocato qualche bruciore di stomaco. Vorrei tranquillizzare chi non mi conosce. Le mie opinioni rispecchiano sempre il mio reale pensiero, al di là di simpatie e antipatie personali. Possono essere giuste o sbagliate, non ho difficoltà ad ammetterlo. Ma non sono mai preordinate, né strumentali.
Vent’anni d’amore
Sono passati quasi vent’anni da quel luglio del 1991, quando un gruppo di amici motivati e impegnati nel sociale, su impulso di don Benito Rugolino, sacerdote eufemiese che opera a Torino, diede vita all’associazione di volontariato cristiano “Agape”. Agape è l’amore disinteressato e gratuito, un dono al prossimo per il quale non si attende nulla in cambio. Agape è una lunghissima storia d’amore che fa parte della storia stessa di questo nostro paese. In due decenni, sono moltissimi coloro che a vario titolo si sono avvicinati all’associazione e con umiltà, in silenzio e lontano dai riflettori, hanno prestato e continuano a prestare la propria opera al servizio dei soggetti più emarginati della società.
Il primo direttivo, presidente l’avvocato Luigi Surace, diede impulso all’assistenza domiciliare agli anziani, all’assistenza scolastica e ricreativa per i minori disagiati, alla consulenza sociale e sanitaria in favore di nuclei familiari bisognosi. Risale invece alla fine degli anni Novanta la realizzazione di iniziative in favore dei disabili: tra tutte, la colonia estiva, da più di un decennio appuntamento fisso dell’associazione presieduta dal 2002 dall’avvocato Pasquale Condello. Per cercare di soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti (volontari e assistiti), nel corso degli anni sono cambiate le modalità e i tempi del suo svolgimento, ma immutati si sono mantenuti l’amore e l’impegno che consentono sempre un’ottima riuscita. Poiché la contiguità territoriale rappresenta una formidabile chiave di successo di questa iniziativa, per la terza volta consecutiva teatro dell’estate dell’Agape, nel 2010, è stata Bagnara. Per una settimana, una quindicina di volontari si sono alternati, con turni diurni e notturni, per fornire un’assistenza adeguata, costante e amorevole ai disabili che hanno convissuto con loro in un alloggio preso in affitto grazie ai proventi dell’autofinanziamento, delle offerte private e delle donazioni del 5 per mille. Altri soggetti disabili sono stati invece accompagnati ogni mattina da Sant’Eufemia a Bagnara e riaccompagnati la sera dai volontari che quotidianamente facevano la spola per risolvere eventuali problemi di natura logistica. Tra le altre iniziative dell’associazione vanno ricordati i pellegrinaggi (almeno uno l’anno), l’assistenza scolastica per minori svantaggiati, le iniziative periodiche in favore dei disabili, l’assistenza agli anziani, l’organizzazione della “giornata annuale del malato” (11 febbraio), “Natale (e Pasqua) di solidarietà”, la formazione dei volontari mediante la partecipazione a corsi come quello sul “Primo soccorso” tenuto dalla Croce Rossa Italiana e ai seminari di approfondimento, convegni e incontri organizzati dal MOVI (movimento organizzato volontari italiani).
In occasione del decennale, l’associazione si era posto come obiettivo l’acquisto di un pulmino per il trasporto di minori, anziani e disabili. Quel “sogno” è stato realizzato, grazie soprattutto alla generosità di quanti – e sono tanti – dimostrano con gesti concreti di apprezzare e sostenere sempre l’operato dell’Agape. Per il 2011, una data importante per l’associazione, che festeggerà vent’anni di attività, il sogno da realizzare è un pellegrinaggio a Lourdes con i disabili. Siamo sicuri che anche questo importante traguardo sarà raggiunto.
10 dicembre 2010
Fine della corsa
Forse non siamo nella Bisanzio “insondabile” cantata da Francesco Guccini, in bilico tra il vecchio che va scomparendo e il nuovo che non si è ancora manifestato (“qualcosa sta cambiando, ma è un debole presagio che non dice come e quando”), ma di certo un ciclo storico sta volgendo mestamente al tramonto. Al di là di ciò che accadrà il 14, niente sarà più come prima. Che Berlusconi riesca a rabberciare una maggioranza o che vada sotto, difficilmente questo governo porterà a termine la legislatura. Fatte salve le prerogative del presidente della Repubblica, resta da capire se è praticabile la strada del cosiddetto governo di “responsabilità nazionale” o se la crisi ci condurrà dritti alle urne. La prima ipotesi sarebbe saggia, ma bisogna fare i conti con Lega e PDL, per nulla disposti a farsi da parte dopo avere vinto le elezioni. La seconda sarebbe logica e coerente con il funzionamento delle moderne democrazie: quando c’è una crisi di governo, la parola torna agli elettori.
Una lettura dei fatti non faziosa induce però a riflettere su di una questione affatto secondaria. È probabile che la società italiana si stia riprendendo ciò che aveva dovuto cedere con Tangentopoli. Berlusconi ha rappresentato un’anomalia per lo più subita nella patria delle fazioni, dei particolarismi, del frazionamento degli interessi. Piaccia o no, in Italia sarà sempre impossibile ridurre tutto a due partiti, a due visioni. Esistono troppe differenze. Tra nord e sud, all’interno di ogni singola regione e persino a livello provinciale. Questo Paese può stare insieme soltanto se tutte le sue componenti hanno voce.
Occorre quindi spostare indietro le lancette? L’antitesi rappresentatività/governabilità è stata risolta, nella Prima Repubblica, a vantaggio esclusivo del primo corno del dilemma. Nel Parlamento era presente “tutta” la società italiana, in virtù di un sistema proporzionale che prevedeva il recupero quasi integrale dei resti. Conseguenza immediata della frammentazione politica era però la brevità della durata dei governi, una media di circa nove mesi dal 1948 al 1992. Troppo poco per dare continuità all’azione governativa. Di fatti, un sistema talmente ingessato si reggeva soltanto per l’impossibilità dell’alternanza, sancita dalla conventio ad excludendum. Nella Seconda Repubblica è stata invece privilegiata la governabilità, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: una classe politica praticamente assediata dentro il Palazzo. La ricerca di nuovi strumenti di pressione e di rappresentanza (Forum, class action, social network), al di fuori dei circuiti politici tradizionali, è dovuta proprio allo scollamento evidente dei partiti dalla società. E il corto circuito esplode perché il sacrificio di quote di potere in nome della governabilità si rivela del tutto vano. Di fatti, a parte il Berlusconi del 2001-2006, dal 1994 ad oggi nessun presidente del Consiglio è rimasto in sella per l’intera legislatura.
La fine dell’ “era Berlusconi” porterà ad un rimescolamento profondo di idee, metodi di governo, contenitori politici, alleanze e, si spera, ad una maggiore tutela degli interessi generali rispetto a questioni più personali che politiche. Ad una classe politica che si auspica rinnovata, toccherà il compito di riuscire finalmente a conciliare le ragioni della governabilità con quelle della rappresentatività.
C’è nessuno?
Nell’opera teatrale La cantatrice calva di Eugène Ionesco, il signor Martin sostiene che, quando si va in giro, si vedono cose straordinarie. Addirittura, si può incontrare un signore che legge beatamente il giornale sul tram. Il dilemma che non gli dà pace è però complicatissimo: quando bussano alla porta, c’è qualcuno oppure no? La risposta è tutt’altro che scontata: a volte sì e a volte no.
Lo spettacolo messo in scena nel consiglio comunale di ieri è stato davvero degno del teatro dell’assurdo. Ad un mese dalle dimissioni del vicesindaco, Pippo Ascrizzi, il sindaco ha ritenuto di dare delle “comunicazioni”. Meglio tardi che mai. Un’opposizione più attenta avrebbe dovuto incalzare l’amministrazione sulla questione, magari con un manifesto pubblico che sottolineasse l’anomalia di due dimissioni consecutive, quelle dell’ex presidente del consiglio comunale, Tonino Alati, e quelle, appunto, di Ascrizzi, entrambe “per motivi personali”.
Lo intuiscono anche i sassi che i motivi sono altri. Eppure, tutto tace. Il torpore più assoluto. D’altronde, la classe politica e amministrativa è espressione della cittadinanza. La quale, tanto per usare un eufemismo, non dimostra particolare interesse per le vicende del Comune. Altrimenti, ad un consiglio comunale convocato dopo le dimissioni del vicesindaco, avrebbero dovuto assistere più cittadini rispetto ai nove – compresi i dipendenti comunali – che non hanno certo faticato per trovare le poltroncine libere.
Nello specifico, il sindaco ha dato lettura delle dimissioni di Ascrizzi, chiosandole – e qui sta la demenzialità – con l’auspicio beffardo che il suo ex vice possa continuare a dare il proprio contributo all’amministrazione comunale per la crescita del paese. Invece dell’apertura di una discussione sul punto – le frecciatine di Creazzo e Papalia non possono considerarsi tale – abbiamo appreso dal sindaco che gli è stata proposta una collaborazione dal primo cittadino di un comune con 700.000 abitanti – a conferma dell’ormai notissimo “qua c’è scienza”, pronunciato in un precedente consiglio – e che il nostro ragioniere comunale non ha eguali in tutta la Calabria. Per carità, è giusto lodare chi lavora bene; sull’auto-elogio, invece, continuiamo a pensarla come il saggio (“chi si loda s’imbroda”): è decisamente poco elegante.
Non è un po’ inconsueto che in un consiglio si parli più della bravura di un dipendente comunale che delle dimissioni del vicesindaco? Il cattivissimo commissario d’esami interpretato da Alberto Sordi nel film Totò e i re di Roma, al cospetto della deludente performance del nostro consiglio comunale, non avrebbe avuto alcuna indulgenza e avrebbe cominciato a strillare: “Senz’altro bocciato! Senz’altro bocciato!”
Resto perché…
Resto perché sono nato in Australia, a più di sedicimila chilometri di distanza dal mio paese;
Resto perché i miei genitori sono andati via e dopo dodici anni sono ritornati: il tempo di fare i lavori più disparati e tre figli;
Resto perché mio fratello Luigi è andato via e dopo dieci anni è ritornato: il tempo di fare anche lui i lavori più disparati e, fortunatamente, nessun figlio;
Resto perché mio fratello Mario è andato via dodici anni fa e non è ancora ritornato, né credo mai lo farà. Ma lui “è figlio unico”;
Resto perché quasi tutti i miei parenti sono andati via e non sono ritornati;
Resto perché non sopporto gli occhi gonfi di ogni partenza;
Resto perché subito dopo la laurea un mio amico mi disse: “fossi in te scapperei di notte da questo paese di merda”. A tredici anni di distanza, per lui non sarebbe neanche una soddisfazione.
Resto perché noi calabresi “avimu a testa dura”.
Resto perché sono stato due mesi a New York, e mi è bastato;
Resto perché penso che qualsiasi lavoro è dignitoso, anche fare il barista con laurea, dottorato di ricerca e un paio di libri scritti;
Resto perché spero che prima o poi finiranno le amanti dei professori universitari da sistemare all’Università;
Resto perché, se andiamo tutti via, a chi lo lasciamo questo paese?
Buu…oni a nulla/bis
Nella rubrica che cura su “Il Quotidiano della Calabria”, il professore Pietro De Luca, rispondendo al mio intervento su razzismo e violenza negli stadi, scrive oggi:
Non sono proprio sicuro che privatizzando oggi questo e domani quello arriveremo a inscatolare da una parte i buoni e dall’altra i cattivi. E poi, come procedere? Magari con il portafogli in mano? Il privato costa di più, il pubblico di meno. Nel privato andrebbero i migliori, gli intelligenti, i beneducati solo perché portano denaro? È sotto gli occhi di tutti che questo assunto non corrisponde al vero. Direi piuttosto che non esiste propriamente un problema degli stadi che non sia anche problema di umanità. Ultimamente un po’ scesa di livello. Se non si urla, non si aggredisce, non si inveisce contro questi e quegli, quasi non si è: di un partito, di una squadra, di un colore, di una nazione. Siamo tutti un po’ troppo su di giri. Una buona virata verso uno stile di vita più a misura d’uomo non guasterebbe. Anche negli stadi.
Non posso che condividere le considerazioni sulla società attuale. “Urlo, dunque sono”, ha ormai soppiantato la celeberrima locuzione cartesiana. È indiscutibile la violenza di certi linguaggi e atteggiamenti. Esiste una difficoltà evidente nell’accettare il punto di vista dell’altro, anche perché il tono alto delle proprie parole impedisce di ascoltare quelle pronunciate dall’interlocutore. Certo: è una questione di umanità. O di cultura, come mi ha fatto notare un mio carissimo amico. Tutto vero. Però il mio discorso era meno generico. Ci sono settori della nostra società che devono essere “pubblici”. Penso all’istruzione, alla sanità, al welfare in generale. Questi sono campi in cui l’intervento dello Stato è indispensabile per affermare i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutti i cittadini. Nel caso degli stadi, penso che c’entrino meno i diritti costituzionali e più la civiltà e la sicurezza. Non si tratta di “inscatolare da una parte i buoni e dall’altra i cattivi”. Esiste un principio, quello di “responsabilità oggettiva” delle squadre di calcio, che non potrà mai essere affermato, fino a quando la sicurezza e il mantenimento dell’ordine all’interno degli impianti sportivi non saranno di competenza delle stesse società sportive. E questo accadrà fino a quando esse non diventeranno proprietarie degli stadi. Quanto poi al discorso puramente economico, non mi risulta che i prezzi dei biglietti allo stadio siano propriamente accessibili a tutti. Oggi costa meno guardare un partita in pay-tv che allo stadio. Segno che il calcio è nel bel mezzo di una mutazione genetica che lo sta facendo diventare (ahinoi) un fenomeno sempre più televisivo.
Buu…oni a nulla
Chissà cosa penserebbero i deficienti che hanno fatto largo sfoggio di idiozia, ululando contro un ragazzo di vent’anni “colpevole” di essere un italiano di colore, dei dirigenti del Colosimi, la società di Prima categoria del cosentino che ha tesserato e trovato un lavoro e una casa all’ivoriano Coulibaly Tiemoko, giunto in Calabria al termine di un’odissea costata la vita al padre, a piedi attraverso l’Africa e su un barcone sballottato dalle acque del Mediterraneo.
Pretendere dai sedicenti “Ultras Italia” che hanno fischiato Mario Balotelli l’acume di Albert Einstein alla domanda sulla razza di appartenenza (risposta: “umana”), sarebbe davvero troppo. Per chiarire meglio il pensiero elaborato dall’unico neurone attivo, hanno pure esposto due striscioni significativi: “No alla nazionale multietnica” e “Non ci sono neri italiani”.
Alla base del pregiudizio che alimenta le pulsioni più recondite e abiette dell’animo nei confronti del “diverso” (sia esso nero, omosessuale, ebreo, zingaro e così via), vi è spesso non la mera malvagità, quanto quella che Hannah Arendt ha definito la “banalità del male”, l’inconsapevolezza cioè del valore etico dei comportamenti individuali. Questa considerazione non deve però affatto spingere all’indulgenza. Così come non deve costituire un alibi per attenuare le responsabilità.
Il problema, gira e rigira, è sempre lo stesso: lo stadio è una terra di nessuno dove, nonostante gli innegabili progressi compiuti negli ultimi anni, si può violare la legge con buone probabilità di farla franca. Molte curve sono ormai diventate un covo di beceri che pretendono “onore” e “rispetto”, invece del disprezzo che a ragione va riservato a chi espone striscioni con svastiche e simboli runici, fischia i giocatori di colore, esprime solidarietà per dei delinquenti ai quali è stato giustamente proibito di andare allo stadio.
Da più parti si inneggia al “modello inglese”. D’accordissimo. Ma la repressione, da sola, non può funzionare in un Paese che fa della certezza della pena un optional. Ci vogliono stadi nuovi e privatizzati, con tutti i posti numerati e controllabili con facilità. Solo in questo modo le società sportive diventeranno realmente responsabili della propria tifoseria e gli stessi gruppi ultras sarebbero costretti ad una maggiore attenzione nell’accettare le adesioni, come accade in tutte le associazioni. È per l’insieme di questi motivi che, in Inghilterra, tutti si sentono responsabili di ciò che accade all’interno di uno stadio e se un tifoso urla un insulto, lancia un oggetto, o soltanto si alza dal proprio seggiolino, viene immediatamente bloccato dai suoi stessi vicini.