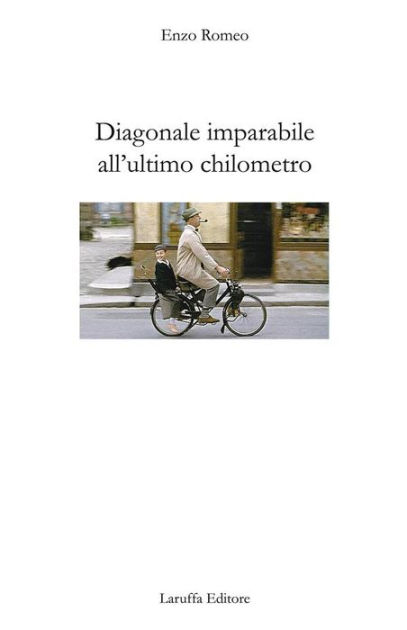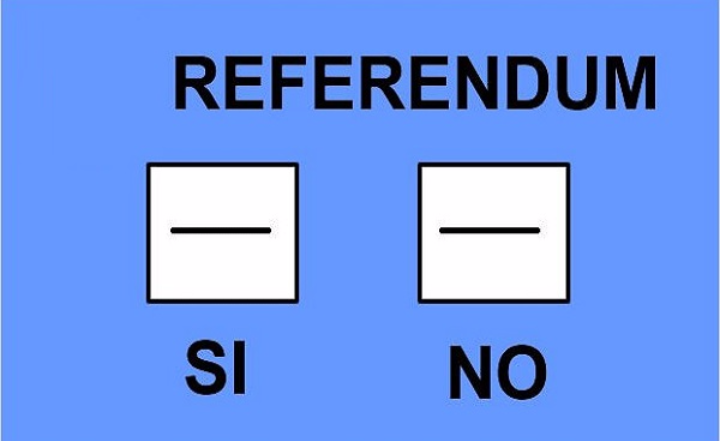Qualche giorno fa sono stato contattato da Francesco Martino, che da un anno gestisce insieme a un gruppo di ragazzi di Sant’Eufemia d’Aspromonte il blog Pont’i Carta: abbiamo fatto una chiacchierata sui temi scottanti del momento, toccando questioni nazionali ma anche locali. Pubblico di seguito il contenuto dell’intervista, consultabile nella sua versione originale cliccando sul link:
https://ponticarta.wordpress.com/2016/04/09/a-colloquio-con-domenico-forgione/
Nei giorni scorsi abbiamo incontrato Domenico Forgione, segretario del circolo PD “Sandro Pertini” del nostro Paese. Domenico è un grandissimo studioso della storia di Sant’Eufemia, oltre che dottore di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea, giornalista pubblicista, scrittore e autore di numerosi libri sulla storia eufemiese e non solo. E’ proprio per questo, insieme al suo impegno politico che lo vede protagonista nel PD cittadino, che ci ha spinto ad incontrarlo e a porgli delle questioni. In maniera particolare, la nostra breve intervista si è soffermata su un tema che abbiamo deciso di affrontare con decisione anche nei prossimi giorni. Si tratta del referendum del prossimo 17 Aprile, evento che come spesso accade rischia di passare sottobanco, ma sul quale cercheremo di sensibilizzare il più possibile. Dunque, affronteremo anche nei prossimi giorni la “questione referendum” in diversi articoli. Intanto, vi lascio alla nostra conversazione con Domenico, auspicando che da essa si possano trarre già molti elementi di riflessione e di analisi sia sul referendum in se’, sia soprattutto sul nostro modo di porci con il contesto che viviamo, possa essere esso lavorativo, sociale o ambientale. Buona lettura.
1) Partiamo subito entrando nel vivo della questione che vogliamo affrontare. Che idea si è fatto del referendum del prossimo 17 Aprile?
Sono dell’avviso che bisogna sempre andare a votare, si tratti di referendum o di elezioni, anche per rispetto di chi ha lottato contro la dittatura fascista e ha pagato con la prigione e con la vita per la conquista di un diritto che oggi ci consente di essere un popolo libero. Non condivido la posizione di chi invita all’astensione. Ricorda il celebre invito rivolto agli elettori da Bettino Craxi nel 1991 (“andate al mare”) in occasione del referendum sulla preferenza unica, che segnò l’inizio della fine della Prima Repubblica. Credo però, anche, che lo strumento referendario sia talmente importante per il funzionamento della nostra democrazia che andrebbe utilizzato con maggiore parsimonia e preferibilmente per questioni di carattere generale, non tecniche, che rischiano di presentarsi come materia ostica per chi non sia un esperto del settore. Il referendum “sulle trivelle” ha assunto un valore che va oltre gli effetti che produrrà: sia che a vincere siano i Sì, sia se dovessero prevalere i No o, addirittura, anche nel caso di non raggiungimento del quorum. Questo perché, grazie all’intesa raggiunta tra governo centrale e Regioni, nessuna compagnia potrà mai più, in ogni caso, trivellare il mare entro le 12 miglia marine. Tuttavia, il referendum pone una fondamentale questione di principio riguardo la politica energetica nazionale, che personalmente gradirei sempre più “verde” e rispettosa della natura. Da qui il mio Sì, convinto: in favore dello sviluppo delle energie alternative, per la salvaguardia dell’ecosistema marino e, per dirla con le parole di Roberto Speranza, per la promozione di un modello di sviluppo ecosostenibile nel nostro Paese.
2) All’interno del Partito Democratico sono tantissime e molto diverse le posizioni riguardo al referendum. Bersani si è espresso favorevolmente al voto senza però sbilanciarsi verso una preferenza. Guerini e la Serracchiani hanno sposato la linea renziana dell’astensione, mentre Prodi ha chiaramente fatto intendere di essere sulla linea del NO. Infine Speranza ed Emiliano, molto critici con la linea di Renzi e favorevoli al SI. Visto che il referendum è stato proposto da nove regioni, di cui sette governate proprio dal Pd, non crede che ci sia stata un po’ troppa confusione? E il Pd eufemiese, quale linea ha deciso di sposare? Ci saranno delle vostre indicazioni?
Concordo sulla confusione, che però è anche conseguenza del carattere pluralista del Partito Democratico. Una ricchezza (la presenza al suo interno di diverse sensibilità) che diventa un handicap quando non si riesce a trovare un punto di sintesi. L’errore più grave, per il partito, sarebbe però fare di ogni appuntamento elettorale una sorta di regolamento di conti, un prova muscolare che produce soltanto disaffezione e alimenta l’antipolitica. Lo sforzo di tutti dovrebbe invece essere rivolto a far convivere le posizioni di tutti, senza il ricorso ai diktat della maggioranza: penso, ad esempio, alle troppe volte che su un provvedimento legislativo viene posta la fiducia. E senza, d’altro canto, che la minoranza del partito minacci di fuoruscire dal partito ogni volta che “va sotto”. La democrazia funziona così e, alla fine, in politica contano i numeri: chi ce li ha, porta avanti la sua visione di società, all’interno di una cornice di valori intangibili che i padri costituenti hanno scolpito, in particolare, nella Prima parte della costituzione repubblicana.
Per l’insieme di queste ragioni, non credo sia utile alcuna “crociata”. Personalmente andrò a votare Sì, però ritengo opportuno lasciare libertà di voto agli iscritti del circolo di Sant’Eufemia.
3) Noi di Pont’i carta, come blog nato proprio dalla necessità di sensibilizzare su temi che molte volte non sono conosciuti o che vengono troppo facilmente liquidati, abbiamo interesse a mettere in luce non solo ciò che potrebbe interessare il nostro paese, ma anche più largamente il nostro territorio, la nostra Regione e anche tematiche nazionali come il referendum. A tal proposito abbiamo scelto il referendum come argomento proprio col chiaro intento di sensibilizzare sul rapporto uomo e natura, oltre che su dei modelli economici di sviluppo nuovi e sostenibili. Alla luce di ciò, cosa pensa degli accertamenti che la magistratura sta effettuando sullo sversamento illecito di rifiuti speciali a Gioia Tauro, sempre nell’ambito dello scandalo “Trivellopoli” scoppiato in Basilicata? Quanto questa inchiesta potrà incidere sull’andamento del referendum?
Sin dall’esordio, ho salutato con favore la nascita del vostro blog, perché credo che ogni luogo di discussione sia (meglio: debba essere) occasione di crescita per la realtà in cui si vive. Vale sia nel caso in cui l’agorà sia reale, sia quando il confronto è virtuale, come nel caso del vostro blog o dei social network. Mi ha fatto pertanto molto piacere il vostro invito a rilasciare questa intervista e vi esorto a continuare su questa strada, quella dell’impegno costruttivo, della ricerca del dialogo e dell’elaborazione di proposte utili per la crescita sociale e culturale di Sant’Eufemia. Per rispondere al merito della domanda, mi auguro che l’inchiesta in Basilicata produca “anche” l’effetto di sensibilizzare maggiormente i cittadini sui contenuti del referendum. Ad ogni modo, ritengo che il lavoro della magistratura finalizzato all’accertamento di eventuali irregolarità nel trattamento di rifiuti speciali nell’impianto di Gioia Tauro non solo è giusto, ma siamo noi cittadini a doverlo pretendere con forza. Sulla salute delle persone non si scherza e se qualcuno ha commesso un reato, attaccando un falso codice identificativo su 26 mila tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, deve pagare.
4) Recentemente, in un incontro avvenuto nel nostro comune, cui ha partecipato anche il presidente dell’associazione “Ferrovie in Calabria” Roberto Galati, si è nuovamente discusso della situazione del nostro ponte di ferro della vecchia stazione. Cosa pensa della situazione del nostro ponte? Crede che possa divenire in futuro il simbolo di quel nuovo sviluppo economico sostenibile di cui parlavamo prima? Oppure è destinato solamente ad una funzione simbolica di “memoria collettiva” da conservare?
Nella battaglia per scongiurare la demolizione del ponte della ferrovia il PD di Sant’Eufemia si è speso molto, promuovendo una sottoscrizione che ha raccolto poco meno di 1.100 firme. Lo ha fatto grazie alla collaborazione dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni, in un momento di grande unità che ha fatto onore a tutti i protagonisti di quella lotta. Il primo passo, salvare il ponte, è stato fatto. Bisogna ora attivarsi per ottenere altri due importanti risultati: 1) mettere in sicurezza tutta l’area su cui il ponte insiste, che è interessata da una situazione di gravissimo dissesto idrogeologico; 2) recuperare e ridare “vita” al ponte stesso. In proposito, le soluzioni possibili sono diverse: dal ripristino della vecchia linea taurense San Procopio/Sinopoli – Gioia Tauro per il trasporto locale o in funzione turistica, alla realizzazione sul vecchio tracciato di una pista ciclabile e di un percorso naturalistico, sul modello della politica di recupero delle linee ferroviarie dismesse attuata in molte regioni d’Italia: soluzione, quest’ultima, che personalmente preferisco, in funzione della valorizzazione delle bellezze e dei prodotti dei territori che la ferrovia attraversa.
5) A proposito di futuro, come ultima domanda, vorremmo andare un po’ fuori tema. In quanto segretario del circolo del Pd “Sandro Pertini”, e in quanto studioso e profondo conoscitore della storia di Sant’Eufemia, cosa pensa che riservi il futuro al nostro paese? E, secondo lei, cosa serve seriamente al nostro paese per costruire un avvenire migliore? In tal senso, il circolo, che obiettivi si pone?
“Il futuro è un’ipotesi”, cantava Enrico Ruggeri quasi trent’anni fa. Quindi non so, con certezza, cosa esso ci riserverà. Vedo, come tanti altri, i segni di un declino preoccupante: il lavoro che manca, l’isolamento anche fisico che il nostro paese ha subito con la soppressione dello svincolo autostradale, i troppi giovani costretti ad emigrare, che portano altrove le proprie competenze e vanno ad arricchire il tessuto sociale delle realtà che li accolgono e dove riescono ad affermarsi. Mentre qua la meritocrazia latita e i diritti vengono spesso cambiati per generose concessioni del potente di turno, del compare o di chi sfrutta il bisogno altrui per fare carriera. Sant’Eufemia ha la fortuna di avere al suo interno le “armi” per costruirsi un futuro migliore: realtà associative vivaci e molto attive sul territorio, professionalità riconosciute e un tessuto economico con straordinarie potenzialità, a cominciare dal settore agricolo e da quello dell’allevamento del bestiame. Si tratta di riuscire a capitalizzare questo vasto patrimonio, mettendo da parte l’egoismo dei singoli e pensando, finalmente, al bene comune. La politica non può considerarsi fuori da questo processo: è anzi chiamata a svolgere un compito di guida, in una prospettiva di sintesi delle soluzioni migliori proposte dalle esperienze amministrative maturate negli ultimi decenni. Un paese con poco più di 4.000 abitanti ha bisogno di una prospettiva il più unitaria possibile, che valorizzi al meglio il capitale umano di cui dispone.