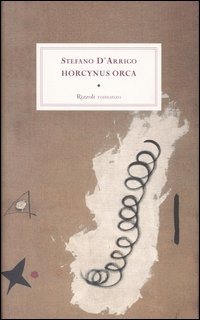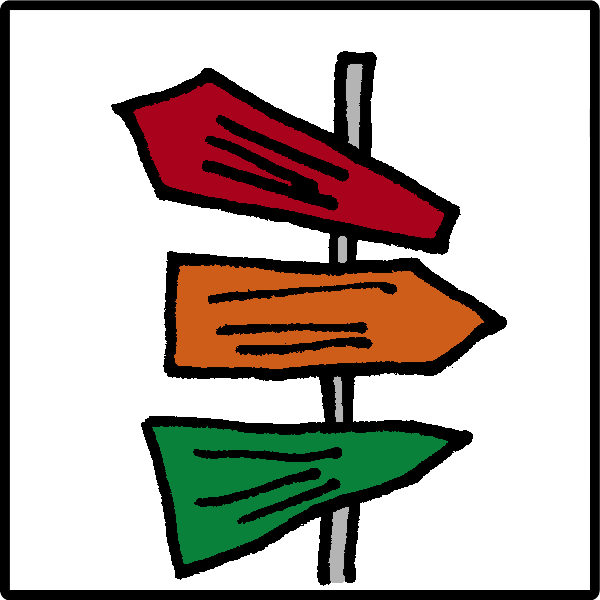Confesso la mia ignoranza: non sapevo chi fosse Vanni Oddera. L’ho scoperto stamattina leggendo «Buone Notizie. L’impresa del bene», l’inserto settimanale del Corriere della Sera che ogni martedì “dà voce alle buone notizie” proponendo le esperienze positive del Terzo settore, del volontariato, dell’impresa sociale.
Ho letto tre volte l’articolo di Fausta Chiesa (La sfida del centauro: «Vi porto tutti in moto»), poi sono andato a cercare altre informazioni su questa storia bellissima, commovente, entusiasmante, che un mese fa il suo protagonista ha anche raccontato in un libro: Il grande salto. Ovvero come ho capito che l’amore per gli altri rende felici (Ponte alle Grazie, 2017).
Di grandi salti Vanni Oddera è un grande specialista, essendo campione di motocross e freestyler di fama mondiale. Il “grande salto” del libro non è però una delle sue consuete e spericolate evoluzioni. Il centauro di Pontinvrea (piccolissimo paese dell’entroterra savonese) lo realizza nel 2009, dopo un incontro casuale con un “mezzo uomo” a Mosca, dove si trova per un’esibizione: «Mi preparo e mi metto in tasca un po’ di banconote, pronto a godermi una mega festa. Prendo un taxi e appena salgo sento una puzza orrenda. Infastidito, mi sporgo in avanti e vedo che il taxista non ha le gambe. Guida con l’aiuto di aggeggi sul volante ed è difficile per lui scendere per fare la pipì, ma anziché fare l’elemosina lavora. In quell’attimo capisco che io ho tutto, altri nulla».
Tornato in Liguria, racconta Oddera, “sentivo nello stomaco il verme che mi attraversava e non sapevo cosa fare”. Fino a quando non si ricorda di un amico (Chicco) che lavora in una casa per disabili ad Acqui Terme e decide di chiamarlo per proporgli di portare i ragazzi da lui: «Ricordo benissimo quella giornata. Prima mi sono messo a fare il buffone per rompere il ghiaccio, poi ho cominciato con la mia esibizione: salti, accelerazioni. Finito lo show, un ragazzo viene da me e mi dice: “mi fai provare?”. Per qualche secondo la frase mi martella, poi lo prendo in braccio, lo carico fra me e il manubrio e lo porto in giro per i campi. Lui urla, ride, piange. Quando ci fermiamo ha il volto trasfigurato: mi dice che era stata la cosa più bella che avesse mai fatto».
Vanni Oddera inventa così la “mototerapia”. A ogni esibizione si ferma sempre un po’ di più, piano piano altri amici si uniscono poi a lui e insieme costituiscono i “DaBoot”, circa venti motociclisti che gratuitamente fanno circa 50 date all’anno di show, in giro per il mondo: «Già quando accendo la moto e li faccio mettere vicino alle rampe sentono la botta dentro. Il rumore è mostruoso, l’aria si sposta. Quando finisco, li invito a salire con me. Così possono provare anche loro l’ebbrezza della velocità, la sensazione di libertà. Per ragazzi che passano la vita in sedia a rotelle salire in moto è una bomba».
La mototerapia ha effetti positivi: c’è il ragazzo bielorusso malato di tumore che riprende a comunicare con gli altri, dopo essersi chiuso in se stesso; ci sono i bambini dei reparti di ematologia e oncologia di alcuni ospedali italiani che letteralmente si esaltano; c’è la forza della “catena umana” che fa sì che un hotel metta a disposizione la propria struttura per le famiglie dei bambini ricoverati al Gaslini di Genova, gratuitamente.
«Che bello sentire il vento sulla faccia»: la frase che Vanni si sente ripetere più spesso. Il vento sulla faccia. Come le onde del mare o la neve per chi non le ha mai viste.
La felicità spesso è nelle piccole cose, nella routine distratta delle nostre vite: situazioni alle quali non diamo importanza perché sono a portata di mano, perché ci sono sempre state come l’aria che respiriamo.
La lezione di Vanni Oddera è che per fare del bene “basta che ognuno usi la sua passione come chiave per interagire”: «Non serve fare salti mortali». E se lo dice lui, ci crediamo.

*Le frasi riportate tra virgolette sono estratte dall’articolo di Fausta Chiesa: La sfida del centauro: «Vi porto tutti in moto», contenuto in “Buone Notizie”, inserto del Corriere della Sera, 7 novembre 2017)