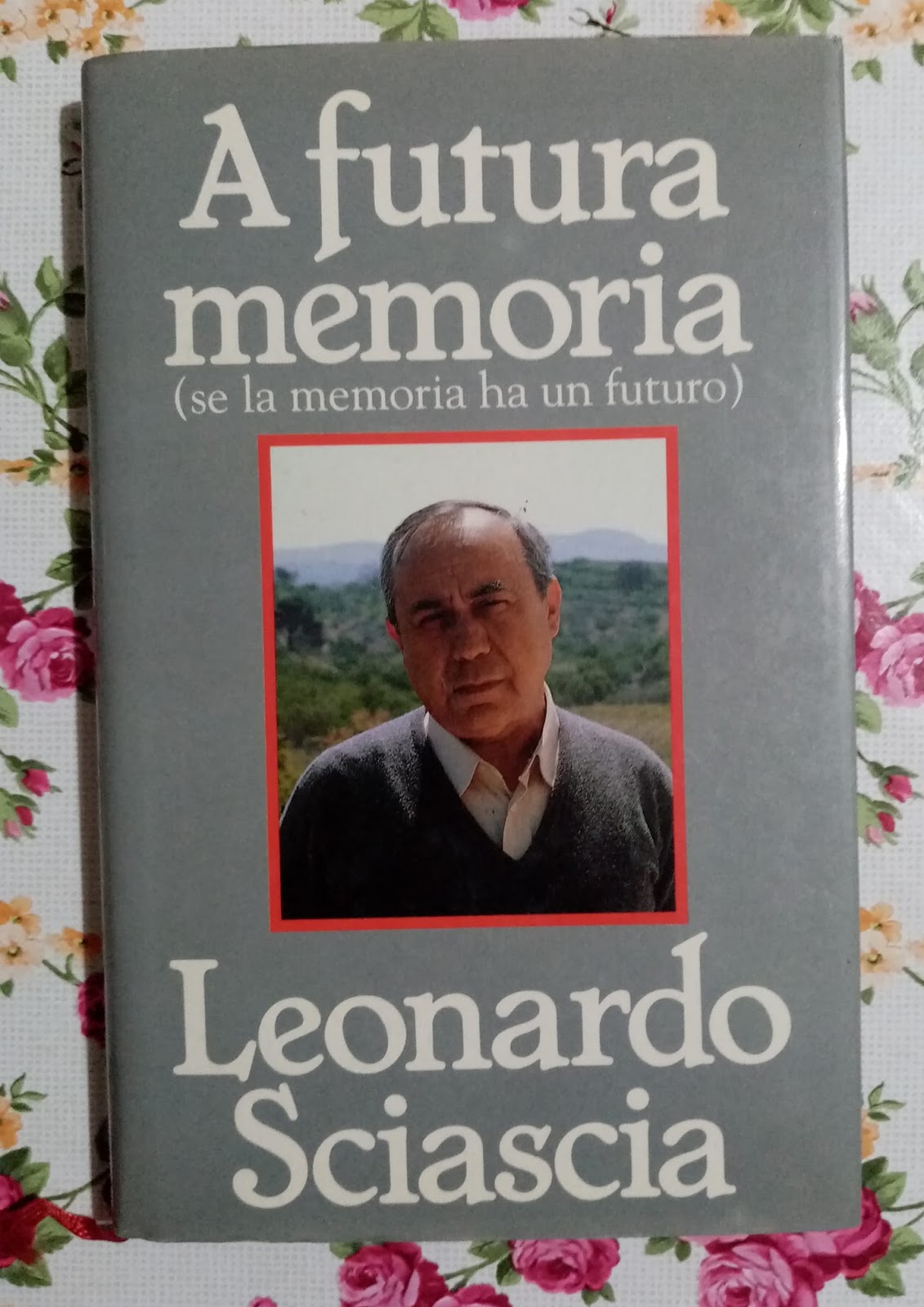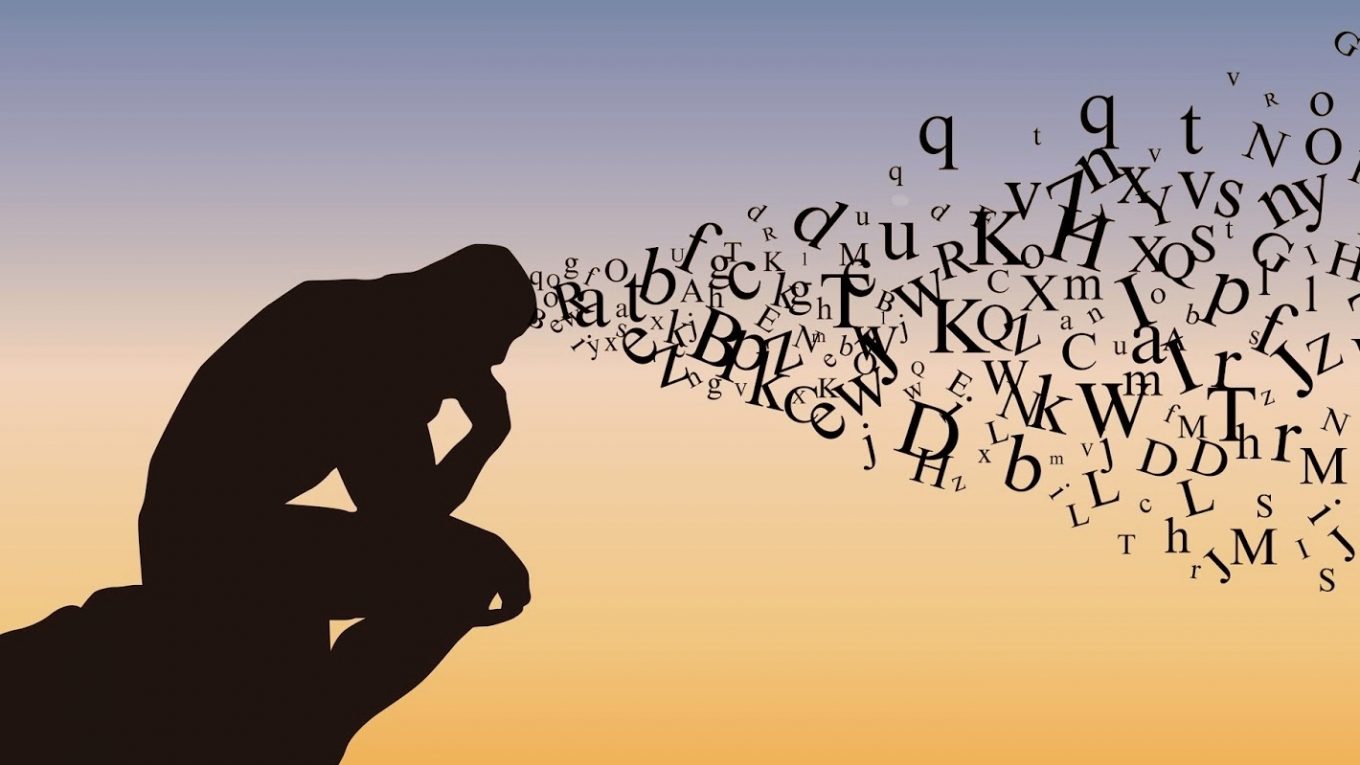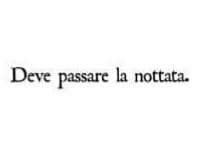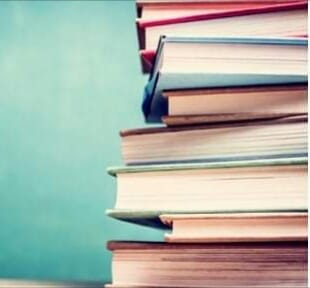Tutti ricorderanno la bella storia di Emma e Adriano (79 anni lei, 86 lui), i coniugi sposati da 60 anni che guarirono dal Covid-19 a due mesi dal contagio. Le immagini della loro uscita dall’ospedale di Bobbio, comune della Val Trebbia (Piacenza) eletto Borgo dei Borghi nel 2019, fecero il giro dei telegiornali e guadagnarono le prime pagine dei giornali. Accanto a loro il medico che li aveva seguiti sin dall’ingresso in ospedale, Antonio Manucra, sottolineava quanto quella vicenda fosse un segnale di speranza, “una piccola lucina nel buio degli ultimi due mesi”, pur non nascondendo “i momenti brutti e pesanti”, per superare i quali “è stato fondamentale l’aiuto di tutti, il conforto di tutti, le carezze e i sorrisi di ciascuno di noi”.
Diploma al liceo “Fermi” di Sant’Eufemia d’Aspromonte, una specializzazione e un master in geriatria dopo il conseguimento della laurea in medicina presso l’Università di Messina, da quindici anni Manucra è dirigente medico presso l’AUSL di Piacenza, in forze al presidio ospedaliero di Bobbio, dove svolge attività di reparto: responsabile del centro demenze e disturbi cognitivi, referente aziendale del centro Terapia Anticoagulante Orale e Nuovi Anticoagulanti Orali, referente delegato ambulatorio di angiologia, attualmente è inoltre facente funzioni di Direttore del nosocomio bobbiese.
L’Emilia Romagna (42.000 contagi) è seconda solo alla Lombardia per numero di decessi: 4.500, dei quali circa 1.000 nella sola provincia di Piacenza, la più colpita.
Per questo motivo crediamo possa essere utile ascoltare la voce di chi combatte sul campo il nemico subdolo che sta cambiando la vita di noi tutti. La voce di chi, mentre affrontava quel buio, scriveva per sé stesso una sorta di vademecum: «Una nuova maschera da indossare, una nuova giornata da affrontare. Solidi, sicuri, sempre… L’uomo prima di tutto, la dignità da preservare, sempre… Parole che confortano, sorrisi che riscaldano il cuore, carezze che allontanano la solitudine imposta. Gesti da ripetere, tornare, per ripartire. Il cuore che si riempie di emozioni, di tristezza di senso di impotenza. La pioggia dirompe e tutto vacilla, ma solo per un attimo, è umano! Poi la forza di reagire e di proseguire su una via impervia e sconosciuta, ma con la consapevolezza di proseguire e non fermarsi».
D – L’emergenza Covid ha messo a dura prova anche la tenuta emotiva del personale medico ed ospedaliero. Come si affronta un nemico “sconosciuto”?
R – «Il sentimento prevalente, dominante, di quei tristi giorni (mi riferisco all’ultima settimana di febbraio e al mese di marzo e poi, in misura minore, di aprile) era di incertezza, di disorientamento. Ci siamo trovati, nel giro di pochi giorni, dal pensare al virus come a qualcosa di lontano ad avercelo in casa (Lodi e Codogno sono molto più vicini a Piacenza che non a Milano): è stato come assistere alla deflagrazione di una bomba con conseguenze che sembravano non dover finire mai. Avevamo di fronte un nemico invisibile, sconosciuto e molto insidioso. Non conoscevamo nulla di questa infezione da Covid-19 (coronarivirus desease 2019). Non sapevamo, oltre ai problemi respiratori, cos’altro potesse interessare e intaccare. Né quali potessero essere i “reliquati” (conseguenze di una malattia passata, n.d.r.). Soltanto in un secondo momento si è visto, da uno studio sulle microembolie condotto presso l’ospedale di Castel San Giovanni (altro ospedale della nostra rete, che è stato il primo ospedale Covid in tutta Europa) che l’eparina poteva essere utile; si è visto che veniva interessato il microcircolo; si è visto che veniva interessato il sistema nervoso centrale e periferico (ecco il perché del sintomo della perdita dell’olfatto e del gusto). Insomma, ci siamo trovati spiazzati».
D – Detto in maniera un po’ brusca, il tuo lavoro e la “tipologia” dei tuoi pazienti ti porta ad avere una certa familiarità con i decessi. In che cosa il Covid è stato diverso?
R – «Da medico, ma soprattutto da uomo, credo che non ci si abitui mai alla morte. Il nostro reparto (internistico), come tutte le medicine, ospita in prevalenza pazienti in età avanzata e per questo fragili per definizione. Ovviamente ci siamo trovati di fronte ad una situazione straordinaria. Il momento peggiore del maledetto mese di marzo sono state le ore tra le 11.10 circa del 21 e le 14.00 del 22: abbiamo avuto 5 decessi, in un reparto che conta 24 posti. Nei mesi di marzo e aprile abbiamo avuto il numero di decessi che in genere contiamo in un anno e mezzo. Ma l’aspetto più angosciante è stata la solitudine dei pazienti, nonostante la fascia oraria dedicata alla videochiamata con i familiari. Pensare anche alla mancanza del conforto dei propri cari… Qualcosa di tremendo».
Un’esperienza professionale estrema, per le continue assenze di colleghi, infermieri ed operatori sanitari (a volte il 50% del personale), come ha successivamente sottolineato Manucra nel ringraziare il personale sanitario: «Siamo stati pronti a rivedere la nostra organizzazione interna, anche a causa delle numerose assenze tra il personale sanitario, e lo abbiamo fatto senza battere ciglio. Ognuno di noi ha rinunciato ai propri riposi per poter garantire l’assistenza ai nostri degenti, impedendo quindi che la “macchina” si fermasse. Molti di noi si sono ammalati, alcuni sono ad oggi ricoverati ed in serie condizioni cliniche e a loro va il nostro pensiero e le nostre quotidiane preghiere. Il tasso di mortalità, tra i degenti, di queste ultime settimane è stato spaventoso. Abbiamo visto morire molti anziani soli e senza il conforto dei propri cari. Tutti voi, infermieri e OSS, avete contribuito a mantenere operativo il nostro ospedale, sobbarcandovi di compiti difficili e pesanti. Avete saputo gestire con competenza e professionalità i ricoveri ed i decessi occorsi in questi giorni, anche in assenza del medico di reparto. A tutti voi, che avete accettato le “novità” organizzative, imposte dallo stato di necessità, a tutti voi dico GRAZIE!!!».
Assenze che per 16 giorni, come ricorda un servizio giornalistico del quotidiano di Piacenza “Libertà” (21 aprile), hanno fatto del geriatra eufemiese l’unico medico presente in ospedale. Mentre il virus si portava via gli amici ed entrava nella sua abitazione di Rivergaro, contagiando la moglie Mariana Iofrida – anche lei medico in servizio presso l’ospedale di Bobbio – e causando il trasferimento dei tre figli (Francesco, Marco, Matteo) presso nonna Carmela: «Il virus era ovunque. Mi viene da pensare quanto fosse complicato anche solo abbozzare un sorriso, comunicare ai figli che avevo la situazione in mano quando invece non era sempre così. Per me il mese di marzo del 2020 è un brivido che ancora mi insegue». Le salme che non si potevano portare nella camera mortuaria e venivano sistemate nel primo piano dell’ospedale, con la mascherina e avvolte da un telo disinfettato. Scene atroci, difficili da dimenticare perché “non siamo delle macchine”.
D – Cos’è cambiato rispetto a marzo, sotto il profilo organizzativo e nella capacità di dare risposte più efficaci e tempestive?
R – Nella nostra realtà, mi riferisco all’AUSL di Piacenza, è cambiato molto rispetto alla routine lavorativa dell’era pre-covid. Sono stati creati protocolli che regolano il flusso dei pazienti dal Pronto soccorso ai reparti e tra reparti. Le visite ai degenti erano state contingentate, ma dal 15 ottobre sono state nuovamente sospese a causa dell’aumento dei casi di positività. Sono stati creati nuovi posti di terapia intensiva e subintensiva (questi ultimi, nel giro di poche ore possono essere trasformati in posti letto di terapia intensiva), sono stati assunti più infermieri (77) per il territorio. In Emilia sono nate le USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) che fanno i tamponi casa per casa allo scopo di isolare e limitare la diffusione del virus: nella solo AUSL di Piacenza esistono, ad oggi, 18 squadre. Le attività ambulatoriali sono riprese, ma gli orari sono stati aumentati per evitare assembramenti.
D – L’emergenza sanitaria ci ha insegnato qualcosa?
R – L’emergenza sanitaria ci ha insegnato che deve essere la medicina a cercare i malati e non viceversa. Ci ha insegnato che la tendenza a centralizzare attorno agli ospedali “grandi” (i cosiddetti HUB), in una visione ospedalocentrica, non va bene. Occorre invece rafforzare il territorio. Ci ha insegnato che la sanità deve essere pubblica ed universale, in modo da consentire l’accesso alle cure a tutti. I tagli degli ultimi dieci anni sono stati pagati tutti e con gli interessi: tagli sugli ospedali (più di 200), riduzione dei posti letto inseguendo una media assurda, tagli agli investimenti…
D – Torneremo alla vita di prima? “Andrà tutto bene”?
R – Contrariamente a ciò che qualche incosciente sostiene, non siamo di fronte ad una “banale” influenza. Abbiamo a che fare con un virus insidioso, che purtroppo circola. Occorre comprendere che più aumentano i positivi e più aumenteranno gli ammalati; di conseguenza, crescerà il numero di coloro che avranno bisogno di cure e, anche, di cure intensive. Per questo è necessario un maggiore impegno delle istituzioni nel settore degli investimenti nella sanità pubblica. Ma per tornare alla vita di prima, per far sì che tutto vada bene, occorre uno sforzo di responsabilità e di senso civico. Dipende da noi. Ne usciremo, se riusciremo a superare individualismo; se, e solo, tutti insieme adotteremo le cautele del caso e ci adegueremo a indicazioni molto semplici: mascherina, distanziamento e igiene delle mani.