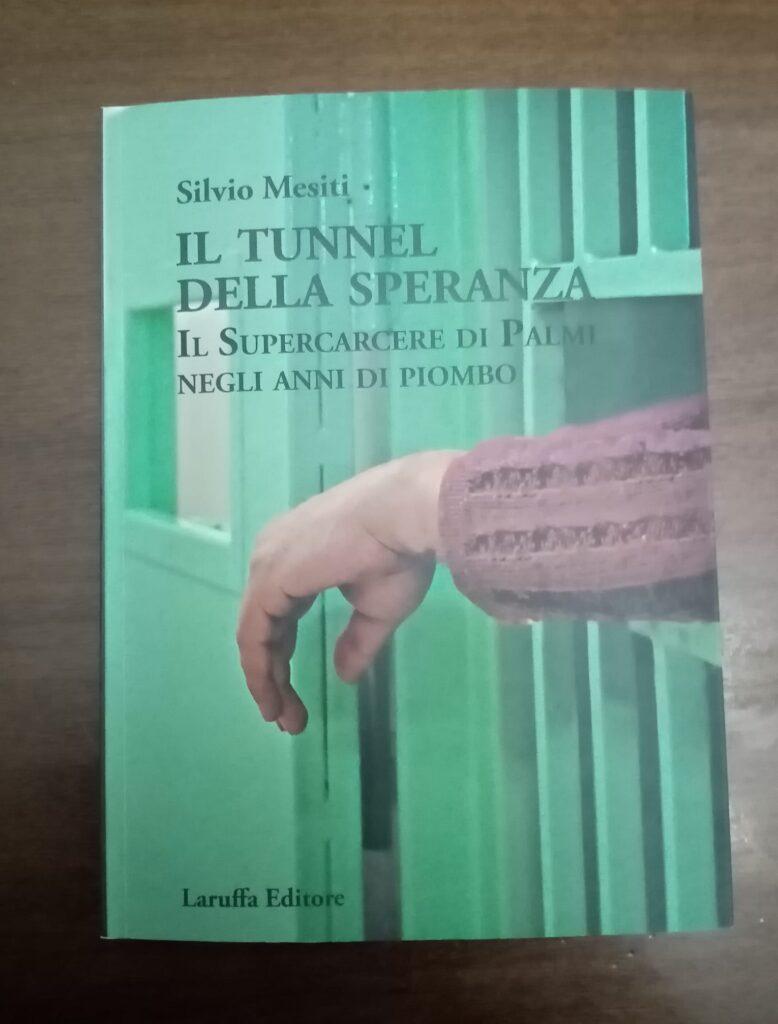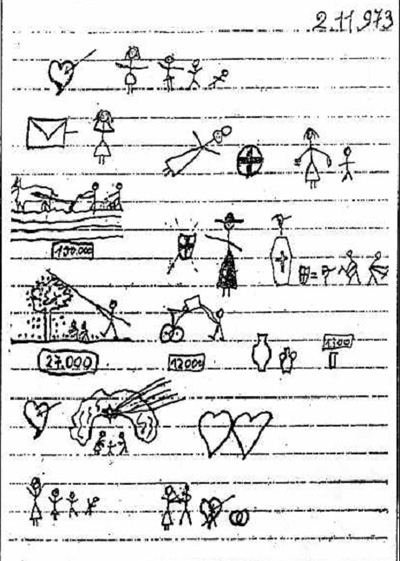Ci sono i dati e c’è l’interpretazione dei freddi numeri. Ma la politica, è notorio, su certi temi preferisce fare lo struzzo. Il dato è quello delle ingiuste detenzioni nell’anno 2020 diffuso dal Sole24Ore, che riporta il contenuto della “Relazione sull’applicazione delle misure cautelari personali e i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto al ristoro per ingiusta detenzione” redatta dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia: 1108 procedimenti e 46 milioni di euro liquidati, quasi 27 milioni di risarcimenti soltanto nelle Corti d’appello di Bari, Catanzaro, Palermo, Roma e Reggio Calabria. Capolista di questa speciale classifica dei risarcimenti, la Corte d’Appello di Reggio con circa 8 milioni liquidati, seguita da quella di Catanzaro (4 milioni e mezzo). Insomma, il Sud la fa da padrona. Si dirà: certo, c’è la mafia. Più reati uguale più arresti, ma anche maggiore possibilità di errori e di vittime collaterali della sacrosanta lotta al crimine.
E quindi? I numeri di matricola schiacciati dai panzer delle procure meritano un moto di indignazione e la ribalta politica, o basta un risarcimento? Scusate e tanti saluti.
Ancora: c’è una ragione se nonostante i rastrellamenti a tappeto di interi paesi la criminalità è viva e vegeta? Sì, c’è. Un motivo semplicissimo: la repressione da sola non è sufficiente e, anzi, gli errori provocati dalla pesca a strascico (o dal napalm: fate voi) fanno soltanto aumentare la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Nel suo pregevole La ’ndrangheta come alibi (Città del sole edizioni, 2019), Ilario Ammendolia con coraggio sostiene che la ’ndrangheta è stato ed è l’alibi di classi dirigenti incapaci, funzionale alla giustificazione del disimpegno dello Stato in Calabria. Stato che dà segnali di vita con interventi repressivi, intercettazioni telefoniche di massa, operazioni mediatiche che coinvolgono migliaia di innocenti, provocano assurdi scioglimenti di consigli comunali e interdittive antimafia contro le imprese. È il paradosso di uno Stato che si manifesta con la sospensione dello Stato di diritto e con il ricorso a una legislazione emergenziale.
Nihil sub sole novum: è storia antica, che non ha neanche il pregio dell’originalità. Già la legge Pica (1863), da applicare alle province del Sud dichiarate in “stato di brigantaggio”, non risolse il problema nonostante le migliaia di arresti, fucilazioni sommarie, condanne ai lavori forzati e al domicilio coatto. Un abuso denunciato subito (3 maggio 1863) dal deputato pugliese Giuseppe Massari, uno dei pochi a comprendere la complessità del fenomeno: «Il brigantaggio è stato considerato come questione di forza, e quindi per combatterlo non si è saputo far altro di meglio se non contrapporre forza a forza. Ma in cosiffatta questione la parte militare è accessoria, è secondaria».
Se l’emergenza non viene mai superata, bisognerebbe almeno porsi qualche dubbio sull’efficacia di uno strumento che evidentemente non va alle radici della questione, principalmente perché mischia fenomeno sociale e reati: da qui gli arresti di massa. Occorrerebbe prendere atto che la criminalità è effetto del sottosviluppo, non causa. Un ribaltamento di prospettiva che metterebbe sul banco degli imputati l’intera classe politica italiana, colpevole (non soltanto per incapacità) della mancanza di lavoro, infrastrutture e servizi in una vasta area del Paese.
Servirebbe l’antimafia dei fatti, che si traduce in politiche di sviluppo. E meno antimafia di parata, quella dei vuoti codici etici, degli ipocriti registri della “cittadinanza consapevole” e delle targhe “Qui la mafia non entra”. Togliete alla criminalità il brodo di coltura della disoccupazione e appassirà da sola.
*Pubblicato su CalabriaPost.net, 30 giugno 2021