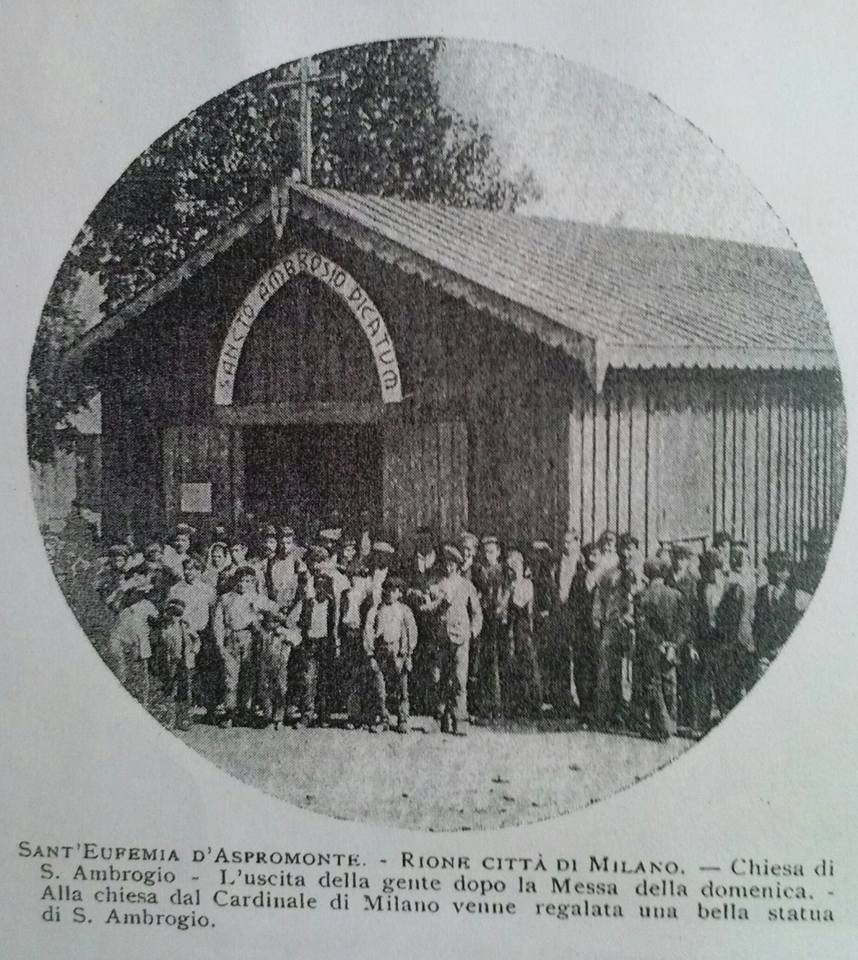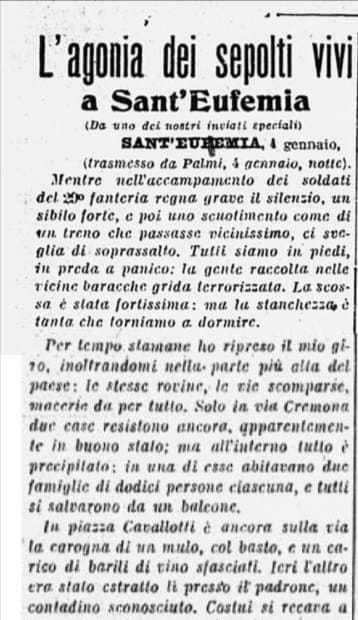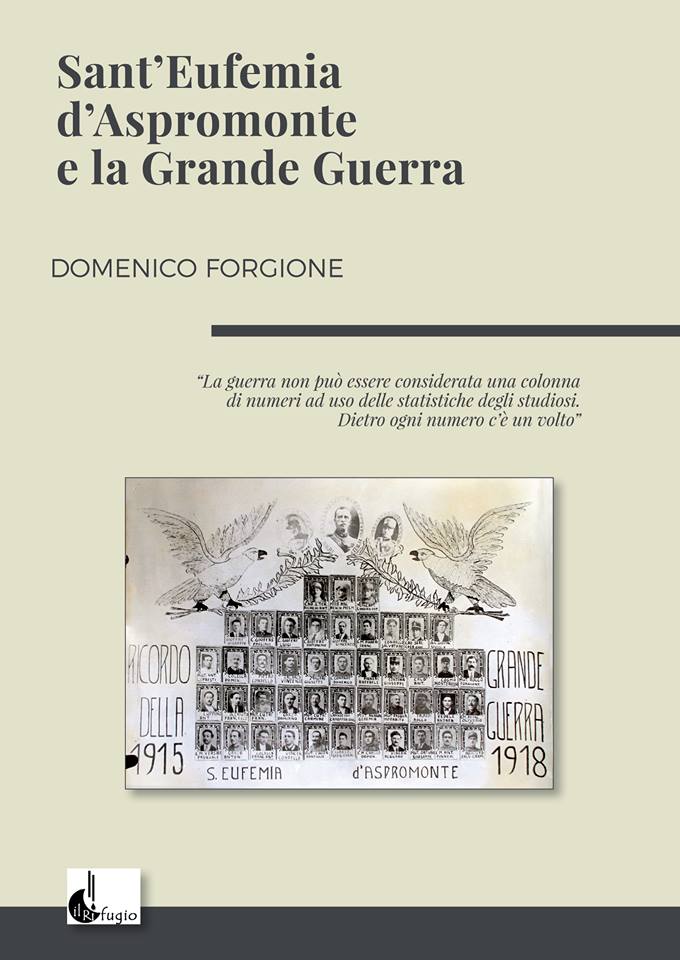La giornata volge al termine, un sole pallido sta per intascarsi dietro la linea dell’orizzonte. Un vecchio pescatore approfitta del tepore serale per riposare le stanche membra. La sabbia della spiaggia non scotta più. I suoi occhi si chiudono come in una tregua dalla fatica di vivere, sul viso solcato da rughe profonde. Una in particolare sembra esprimere serenità, “come una specie di sorriso”. Ricorda i vecchi mummioni di D’Arrigo, legni secchi e impregnati di salsedine che leggono il tempo e detestano lo scirocco, vento subdolo e cascittone.
A violare la pace del tramonto, irrompe sulla scena un assassino, arrivato da chissà dove. Non è dato sapere cosa esattamente gli sia successo. Sappiamo però che è un uomo in fuga, con due occhi grandi da bambino. Un indizio che rimanda ad una condizione di innocenza. I bambini sono innocenti. Occhi grandi di paura, spaventati dall’enormità commessa, forse per necessità, o dalle conseguenze che l’azione delittuosa potrebbe comportare. Un delitto è un delitto, ma Fabrizio De André non si erge mai a giudice: «al vostro posto non ci so stare», dirà anni dopo il detenuto di “Nella mia ora di libertà”, rivolto a uomini e donne di tribunale.
Sulla spiaggia ora ci sono soltanto due uomini. Un vecchio pescatore e un assassino affamato e assetato. L’assassino chiede da bere e da mangiare, il pescatore apre appena gli occhi e “senza neppure guardarsi intorno”, versa da bere e spezza il pane “per chi diceva ho sete, ho fame”. Non importa cosa l’assassino avesse fatto prima: ora, al cospetto del pescatore, c’è un uomo bisognoso d’aiuto.
“Il pescatore” è una parabola laica. I riferimenti evangelici sono evidenti: siate pescatori di anime, dice Cristo agli apostoli, molti dei quali erano effettivamente pescatori. E il pescatore ha molto del Gesù che scrive distrattamente per terra, mentre la giustizia umana vorrebbe lapidare la Maddalena, prima delle fatidiche parole: «Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra». D’altronde il brano esce nel 1970, poco prima dell’album “La buona novella”, esito artistico di un intenso studio dei Vangeli apocrifi.
Il conforto dura un momento, poi l’assassino riprende il suo cammino verso il vento (la libertà), la mente affollata da ricordi dolorosi e dalla nostalgia per l’infanzia, quando ancora la felicità era a portata di mano: «il rimpianto di un aprile giocato all’ombra di un cortile».
Ma c’è anche una chiave di lettura politica. L’insofferenza dell’anarchico De André nei confronti del potere costituito, dell’autorità con e senza divisa: «non esistono poteri buoni», sarà la conclusione del protagonista di “Nella mia ora di libertà”.
Se di fronte all’uomo in fuga il pescatore esce dal suo torpore, altrettanto non accade quando due gendarmi trafelati gli chiedono se da lì fosse passato un assassino. Il pescatore finge infatti di dormire e non dà alcuna risposta; i gendarmi proseguiranno invano l’inseguimento, imboccando probabilmente la direzione sbagliata.
Un atto rivoluzionario, come fu la vita di Gesù di Nazareth (“è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi”, dirà il cantautore introducendo “La buona novella”), che trasforma “un” pescatore ne “il” pescatore della strofa finale, archetipo universale di una visione scandalosa della giustizia, capace finalmente di inverarsi in carità e pietà.