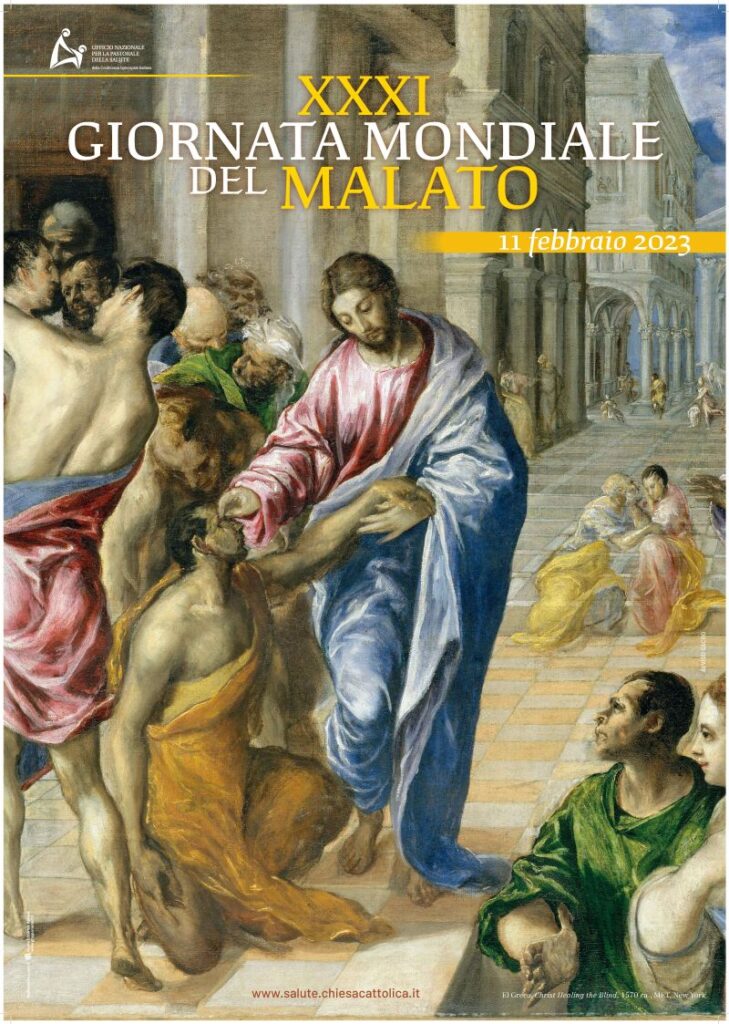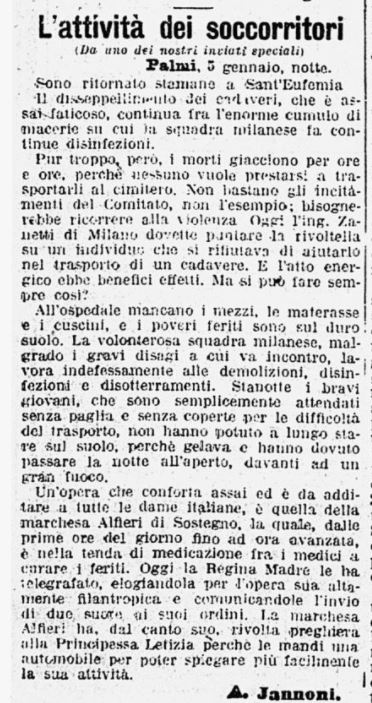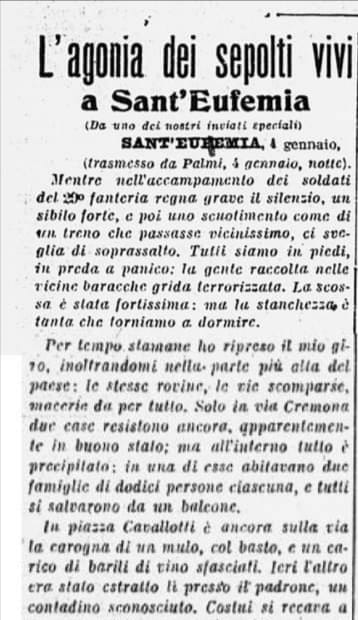Altri dodici giorni e avrebbe compiuto trent’anni. Chissà se Carlo Muscari pensò a quell’imminente anniversario, mentre infilava la testa dentro al cappio in piazza Mercato, a Napoli, il 6 marzo del 1800. Tra gli ultimi patrioti della Repubblica Napoletana ad essere giustiziato, Muscari era nato a Sant’Eufemia il 18 marzo 1770 da Francesco e Lavinia Pugliatti. Il padre apparteneva ad una ricca ed aristocratica famiglia di proprietari terrieri originaria di Melicuccà, la madre era una nobildonna reggina. Compiuti gli studi ginnasiali a Roma sotto la guida dello zio Giuseppe Maria Muscari, intimo di Pio VI e di Sant’Alfonso de’ Liguori, si laureò in legge a Napoli, dove viveva il fratello maggiore Giuseppe, avvocato, che curò anche la formazione di un altro fratello, Gregorio. Nella capitale borbonica frequentò gli ambienti massonici e nel 1794 fu coinvolto in una congiura giacobina che gli procurò l’arresto e la reclusione nel carcere della Vicaria, con l’accusa di “asportazione d’armi proibite, bestemmie, miscredenze, violenze ed altri eccessi”, oltre che per il possesso di “alcuni libri sediziosi francesi”. Messo in libertà dietro il pagamento di una cauzione di 1.000 ducati, subì un altro deferimento tra il 1795 e il 1797.
Con l’arrivo dei francesi a Napoli e la fuga del re Ferdinando IV, Carlo Muscari fu tra i protagonisti degli eventi che portarono alla proclamazione della Repubblica Napoletana, a gennaio del 1799. Inizialmente ebbe il comando della II compagnia della I legione, con il grado di capitano; successivamente, passò prima alla II legione come capo battaglione e infine fu comandante della Legione “Bruzia”, che contava 500 fanti e 200 cavalieri.
Il 20 gennaio 1799 partecipò alla presa del castello di Sant’Elmo e alle operazioni che sancirono la vittoria degli insorti filofrancesi, mentre a marzo si distinse nello scontro contro i filoborbonici di Torre Annunziata. Membro della “Commissione pel piano delle Finanze”, insieme al fratello Gregorio fu inoltre componente della Commissione “degl’informi” (23 marzo), che si occupava dell’epurazione dell’apparato burocratico borbonico.
Nel frattempo, anche il quarto fratello Muscari, Mercurio, era scappato da Sant’Eufemia in seguito al saccheggio ed al tentativo di incendio della propria abitazione da parte delle truppe sanfediste che stavano risalendo la Calabria e raggiunse i fratelli a Napoli. La guerra civile stava però cambiando segno. Dopo la capitolazione dei giacobini nella difesa del forte di Vigliena (13 giugno 1799), le truppe del cardinale Ruffo guadagnarono il controllo della città. Carlo, Gregorio e Giuseppe Muscari si asserragliarono nei Castelli. Mercurio, che inizialmente aveva trovato rifugio in un convento, da lì fu costretto a scappare travestito da frate, ma fu riconosciuto e arrestato.
Il trattato di capitolazione sottoscritto il 19 giugno concedeva agli insorti la facoltà di trasferirsi in Francia. Ma cinque giorni dopo sbarcò a Napoli l’ammiraglio Nelson, il quale come primo atto ordinò la sospensione del trattato. Cosicché dal vascello inglese “Audace”, dove aveva ottenuto di trasferirsi insieme ad altri patrioti calabresi che avevano scelto l’esilio e che era pronto a salpare verso la Francia, Carlo Muscari fu trasbordato sulla corvetta borbonica “Stabia”, riportato a terra e “fatto transitare assieme a tanti altri per le vie di Napoli con un collare al collo” prima di essere imprigionato nei Castelli del Carmine e Castelnuovo, in attesa del processo.
Tra le lettere della fitta corrispondenza intercorsa tra Ferdinando IV di Borbone e il cardinale Ruffo, ad agosto, una fa riferimento al condannato eufemiese: «Il Re ha risoluto, e vuole che la Suprema Giunta di Stato proceda in giustizia, e giudichi con tutto il rigore delle leggi i seguenti rei di Stato: Carlo Muscari, Michele Filangieri, Pietro Doria».
Per lo storico Vincenzo Cuoco la condanna a morte di Muscari, emessa il 27 gennaio 1800, è paradigmatica del clima giustizialista instauratosi con il ritorno dei Borboni: «Le sentenze erano fatte prima del giudizio. Chi era destinato alla morte doveva morire […]. Dal processo di Muscari nulla si rilevava che potesse farlo condannare; ma troppo zelo avea dimostrato Muscari per la Repubblica, e si voleva morto. La Giunta, dicesi, ebbe ordine di sospender la sentenza assolutoria e di non decidere la causa finché non si fosse trovata una causa di morte. A capo di due mesi è facile indovinare che questa causa si trovò».
Ferdinando IV di Borbone, con la “reale determinazione” del 14 febbraio riconfermò la sentenza di morte. Eseguita la sentenza, la salma fu poi sepolta nella chiesa di Santa Caterina ai Funari.
Nel centenario della morte il presidente del consiglio provinciale di Reggio Calabria, l’eufemiese Michele Fimmanò, tenne il discorso commemorativo che si concluse con la collocazione, all’interno del municipio di Sant’Eufemia, di una lapide in marmo con sopra scolpite le parole dettate da Vittorio Visalli: «Tradita la fede dei patti/ da bieca voluttà di tiranni/ CARLO MUSCARI/ milite della Repubblica Partenopea/ moriva strangolato a Napoli/ il 6 marzo 1800/ I cittadini eufemiesi dopo 100 anni/ a ricordo ed esempio».
Ridotta in macerie nel terremoto del 1908, una riproduzione dell’iscrizione fu posta alla fine degli anni Venti nel nuovo palazzo municipale, ma anch’essa andò distrutta con la demolizione dell’edificio, nella metà degli anni Ottanta.